Nuove pubblicazioni
Il digiuno può aiutare a curare il diabete di tipo 1 alterando il microbioma intestinale
Ultima recensione: 23.08.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.
Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.
Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.
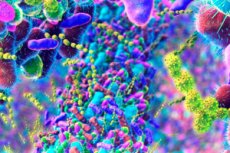
Il diabete autoimmune di tipo 1 (T1D) non riguarda solo insulina e glicemia. Un numero crescente di prove collega il microbioma intestinale al rischio, al decorso e all'infiammazione associata alle malattie autoimmuni. La dieta è uno dei modi più rapidi per modificare il microbiota, quindi l'interesse per il digiuno terapeutico è naturale: ha già modificato la composizione dei microbi e dei circuiti immunitari nelle persone sane e in diverse malattie autoimmuni. Ma fino ad ora non era chiaro come esattamente il microbioma delle persone con T1D rispondesse al digiuno. Un nuovo studio pubblicato su Frontiers in Endocrinology colma parte di questa lacuna, dimostrando che una settimana di digiuno sotto supervisione medica ristruttura drasticamente e brevemente il microbiota nel T1D, con un cambiamento che lo avvicina al profilo delle persone sane e, sorprendentemente, in parte sovrapponendosi a quanto osservato in un'altra malattia autoimmune, la sclerosi multipla (SM).
Contesto dello studio
Il diabete mellito di tipo 1 (T1DM) è una malattia autoimmune in cui il sistema immunitario distrugge le cellule β del pancreas; si stima che circa 9 milioni di persone in tutto il mondo ne siano affette. Oltre alla genetica, i fattori ambientali influenzano significativamente il rischio e il decorso del T1DM e, negli ultimi anni, il microbioma intestinale è diventato uno dei principali "sospettato": nelle persone con T1DM, la sua composizione e le sue funzioni differiscono da quelle delle persone sane e sono state descritte alterazioni del microbiota anche prima dell'insorgenza della malattia; più spesso, si registrano un aumento della permeabilità intestinale e uno spostamento dei metaboliti che influenzano l'immunità (acidi grassi a catena corta, derivati della vitamina A, triptofano, ecc.). Tutto ciò rientra nell'idea che l'"ecologia intestinale" possa alterare la risposta immunitaria e il decorso dell'autoimmunità.
La dieta è la leva più rapida per influenzare il microbiota, quindi c'è un crescente interesse per il digiuno terapeutico e gli approcci "post-mimetici". Nei modelli e nei volontari sani, le pause prolungate dal cibo ristrutturano la composizione microbica e, negli esperimenti sugli animali, cicli ripetuti di una "dieta che imita il digiuno" hanno ridotto il pool di cellule T autoaggressive e supportato le cellule T regolatrici; segnali simili sono stati ottenuti anche in un modello di sclerosi multipla. Tuttavia, rimaneva la domanda: come avrebbe risposto il microbioma delle persone con diabete di tipo 1 al digiuno e se le "firme microbiche" del digiuno precedentemente descritte in altri gruppi si sarebbero ripetute.
C'è anche un aspetto di sicurezza. Storicamente, le restrizioni dietetiche a lungo termine sono state considerate rischiose nel diabete di tipo 1 a causa del rischio di ipo/iperglicemia e chetoacidosi. Tuttavia, si stanno accumulando dati controllati sulla sicurezza: il digiuno del Ramadan è stato completato in sicurezza in pazienti selezionati e non sono stati segnalati eventi avversi gravi, inclusa la chetoacidosi diabetica, con il digiuno di 7 giorni sotto supervisione medica. Questo apre la strada a protocolli clinici accurati in cui l'obiettivo non è "affamare il diabete", ma studiare interventi brevi e controllati per comprenderne i meccanismi e i potenziali effetti adiuvanti.
In questo contesto, il progetto pilota di Frontiers in Endocrinology formula un'ipotesi chiara: se la "carenza di substrati nutrizionali" è un fattore determinante, indipendente dalla malattia, nella riorganizzazione del microbiota, allora un digiuno di una settimana dovrebbe indurre cambiamenti nel diabete di tipo 1 simili a quelli osservati in individui sani e in altre patologie autoimmuni. Il passo successivo è verificare quanto siano riproducibili questi cambiamenti, quanto durino e se siano almeno associati a cambiamenti nei parametri clinici (lipidi, pressione sanguigna), al fine di decidere se passare a studi più ampi e duraturi.
Come è strutturato lo studio (chi, cosa e quando)
Lo studio pilota ha incluso 19 adulti con diabete di tipo 1 (95% donne) e 10 controlli sani. Tutti sono stati sottoposti a un ciclo di digiuno terapeutico di 7 giorni in un ambiente ospedaliero (non ospedaliero, ma sotto osservazione): ~200 kcal/giorno a base di brodi vegetali, succhi e brodo d'avena; acqua e tisane - senza restrizioni. Le feci sono state raccolte: il giorno 0 (prima), il giorno 7 (subito dopo) e il giorno 150 (dopo ~5-6 mesi); la composizione del microbiota è stata valutata mediante sequenziamento 16S. Separatamente, gli autori hanno aggiunto un sottocampione dallo studio NAMS sulla SM: 10 pazienti con SM sono stati sottoposti a due settimane di digiuno con un intervallo di 6 mesi (tra di esse - una finestra di intervallo giornaliera di 14 ore); la dieta durante la fase di digiuno era fino a ~400 kcal/giorno.
Cosa è cambiato nel microbiota - la cosa principale
La scoperta più notevole: nei pazienti con diabete di tipo 1, il microbiota ha subito un "salto" dopo il digiuno: secondo la beta-diversità, la composizione al settimo giorno era già convergente verso il profilo delle persone sane, mentre nei controlli il modello generale per la stessa settimana non è cambiato quasi per niente dal punto di vista statistico (probabilmente a causa delle dimensioni ridotte del gruppo). Al 150° giorno, l'effetto si era attenuato: non si era instaurato un "nuovo equilibrio" stabile.
Suddividendo per genere, 21 taxa hanno mostrato cambiamenti differenziali nelle persone con diabete di tipo 1 dopo il digiuno. Sebbene i controlli avessero una significatività statistica inferiore, la direzione dei cambiamenti era la stessa. Ad esempio:
- Diminuzione: Agathobacter, Fusicatenibacter, Oscillospiraceae UCG-003;
- Crescita: Escherichia/Shigella, gruppo Ruminococcus torques, Ruminococcaceae UBA1819.
A un livello più sottile (ASV, "quasi specie-specifico"): solo nel DM1 sono cresciuti Bacteroides vulgatus e una delle Prevotella, mentre nei controlli Roseburia intestinalis e diverse altre ASV sono diminuite. Nel complesso, questo conferma che il digiuno produce un "clic" breve ma potente sul microbiota, e i dettagli dipendono dallo stato iniziale.
"Firma della fame": cambiamenti ripetibili nel diabete di tipo 1, nella sclerosi multipla e negli individui sani
Il confronto con il gruppo SM ha rivelato una "firma di fame" del microbioma indipendente dalla malattia. Sette generi sono cambiati nella stessa direzione in tutti: Agathobacter, Bifidobacterium, Fusicatenibacter e Lachnospiraceae UCG-001 sono diminuiti, mentre Erysipelatoclostridium, Escherichia/Shigella, Eisenbergiella sono aumentati, e questo è dimostrato anche da studi più ampi su popolazioni non autoimmuni. Nella seconda fase, la SM ha mostrato un'elevata riproducibilità: circa la metà degli ASV significativi si sono ripetuti in entrambe le settimane di fame. Il quadro coincide con la biologia generale della fame: gli "amanti delle fibre vegetali" (molte Lachnospiraceae) diminuiscono, e i distruttori di mucina e glicosaminoglicani ( R. gnavus, R. torques, Hungatella ) aumentano, spostandosi verso le risorse dell'ospite; Eisenbergiella è associata alla chetosi e potrebbe utilizzare il β-idrossibutirrato come combustibile.
È correlato agli indicatori sanitari?
Gli autori hanno confrontato le variazioni "batteriche" con le variazioni dei marcatori clinici nel diabete di tipo 1 e nei controlli. Dopo aver corretto i dati per confronti multipli, hanno ottenuto 9 associazioni significative. Ad esempio, Oscillospiraceae UCG-002 è risultata correlata con la dinamica delle LDL e, nei controlli, anche con le HDL e la pressione diastolica; la crescita di Erysipelatoclostridium (controlli) e Romboutsia (DMT1) ha coinciso con una diminuzione della pressione arteriosa; Lachnospira "si è accompagnata" a una diminuzione del citrato urinario nel diabete di tipo 1. Si tratta di correlazioni, non di causalità, ma sono in linea con la letteratura sull'effetto dei singoli taxa sui lipidi e sul tono vascolare.
Come si inserisce questo nella fisiologia della fame?
La logica è semplice: quando c'è una carenza di substrati alimentari, i microbi con ampie capacità metaboliche e accesso alle risorse dell'ospite - muco (mucina), glicosaminoglicani, corpi chetonici - vincono. Pertanto, il digiuno sposta naturalmente l'ecosistema da fermentatori attivi di fibre alimentari ( Agathobacter e i suoi parenti sono grandi produttori di butirrato, "amano" le fibre) a "generalisti" e "mangiatori di muco". Cambiamenti simili (inclusa la crescita di Akkermansia ) sono già stati descritti dopo digiuni di 3-10 giorni in altri gruppi; il lavoro attuale mostra che la direzione rimane la stessa nel diabete di tipo 1.
Cosa significa questo per le persone affette da diabete di tipo 1?
- Si tratta del microbioma, non di "curare il diabete" con la fame. I cambiamenti sono a breve termine e riguardano principalmente la composizione dei batteri; non è stata registrata alcuna "ristrutturazione" stabile a lungo termine, nell'arco di 5-6 mesi.
- La sicurezza è fondamentale. Un digiuno di sette giorni nel diabete di tipo 1 è possibile in condizioni di monitoraggio (non è stata osservata alcuna chetoacidosi diabetica negli studi pilota) ed esistono dati sulla sicurezza del digiuno del Ramadan in pazienti selezionati. Ma questo non è un motivo per sperimentare a casa: i rischi di ipo/iperglicemia e chetoacidosi sono reali.
- Qual è il vantaggio pratico? I ricercatori suggeriscono due vettori: (1) comprendere quali taxa sono associati a miglioramenti della pressione sanguigna e dei lipidi; (2) verificare se la caratteristica della fame può essere imitata da misure dietetiche "soft" (finestre di alimentazione, composizione della dieta) o probiotici/prebiotici, senza una settimana intera di digiuno.
Restrizioni
Si tratta di uno studio pilota con piccoli gruppi; le statistiche principali sono state "estratte" da DM1, mentre la significatività è diminuita nei controlli. Metodo: 16S (tassonomia, non funzioni); virus/micobioma non sono stati profilati. Le correlazioni con i marcatori clinici sono associative; le relazioni causa-effetto tra batteri specifici e, ad esempio, le LDL devono ancora essere verificate. E, infine, l'effetto si è rivelato transitorio: l'"impronta" della fame si cancella nel giro di mesi.
Cosa dovrebbe fare ora la scienza?
- RCT più ampi con obiettivi clinici (variabilità glicemica, pressione sanguigna, lipidi), multi-omica (metagenomica/metabolomica) e monitoraggio della durata dell'effetto.
- Confronto dei regimi: settimana di digiuno vs. finestra di intervallo (ad esempio 14-16 ore), fase chetogenica, protocolli “post-mimetici”.
- Obiettivi del microbiota: verificare se la "firma della fame" può essere riprodotta tramite dieta/integratori senza digiuno rigoroso nel diabete di tipo 1.
Fonte: Graef FA et al. Il digiuno provoca cambiamenti caratteristici del microbioma intestinale che si estendono ai pazienti con diabete di tipo 1. Frontiers in Endocrinology, 13 agosto 2025. DOI 10.3389/fendo.2025.1623800
