Nuove pubblicazioni
Nuovo sistema a nanoparticelle utilizza gli ultrasuoni per la somministrazione precisa dei farmaci
Ultima recensione: 23.08.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.
Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.
Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.
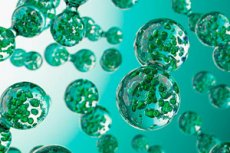
La somministrazione controllata su richiesta è sempre stata considerata un sogno: iniettare un farmaco nel sangue e attivarlo esattamente dove e quando serve. Il team di Stanford e dei suoi partner ha dimostrato una piattaforma operativa che lo fa in un linguaggio farmaceutico semplice e traducibile: i liposomi attivati acusticamente (AAL), con saccarosio aggiunto al nucleo. Questo eccipiente sicuro e ampiamente utilizzato in medicina modifica le proprietà acustiche del "riempimento" d'acqua dei liposomi, e gli ultrasuoni pulsati a bassa intensità fanno "respirare" brevemente la membrana, rilasciando una dose di farmaco senza riscaldare il tessuto. Nei ratti, la ketamina è stata "attivata" in aree specifiche del cervello e un anestetico locale vicino al nervo sciatico, ottenendo l'effetto nel punto giusto, senza inutili effetti collaterali.
Contesto dello studio
La farmacologia mirata è da tempo bloccata su due problemi principali: dove somministrare il farmaco e quando attivarlo. Nel cervello, questo è ostacolato dalla barriera emato-encefalica, sui nervi periferici dal rischio di effetti collaterali sistemici degli anestetici locali e dalla "diffusione" del blocco nei tessuti. Abbiamo bisogno di uno strumento che consenta di somministrare il farmaco per via endovenosa, e poi di attivare la sua azione in modo puntuale – in pochi millimetri della corteccia desiderata o attorno a uno specifico tronco nervoso – e solo per la durata della procedura.
Sono già stati sperimentati "controlli remoti" fisici per i farmaci: la luce (fotoattivazione) è limitata dalla profondità di penetrazione e dalla diffusione; i vettori magnetici e termosensibili richiedono attrezzature specifiche e spesso il riscaldamento dei tessuti, il che complica la clinica; le microbolle con ultrasuoni focalizzati sono in grado di aprire la barriera ematoencefalica, ma ciò è accompagnato da cavitazione e microdanneggiamento, difficili da dosare e standardizzare in sicurezza. All'altro estremo ci sono i liposomi classici: sono compatibili con le tecnologie farmaceutiche e ben tollerati, ma troppo stabili per erogare un "impulso di dose a comando" senza una brusca stimolazione termica o chimica.
Da qui l'interesse per l'attivazione acustica senza riscaldamento e cavitazione. Gli ultrasuoni pulsati a bassa intensità penetrano in profondità, sono da tempo utilizzati in medicina (neuromodulazione, fisioterapia), sono ben focalizzati e scalabili. Se il vettore è realizzato in modo che brevi impulsi acustici aumentino temporaneamente la permeabilità della membrana e rilascino parte del carico, è possibile ottenere una modalità di "sganciamento del farmaco" - rilascio controllato - senza stress termico e rottura delle pareti vascolari. La sottigliezza chiave qui è la composizione del "nucleo" delle particelle: da essa dipendono le proprietà acustiche e la risposta agli ultrasuoni.
E infine, il "filtro traslazionale": anche una fisica brillante è di scarsa utilità se la piattaforma si basa su materiali esotici. Per una clinica, è fondamentale che il vettore sia assemblato con componenti GRAS, resista a una logistica a freddo, sia compatibile con la produzione di massa e gli standard qualitativi, e che le modalità ecografiche si adattino alla gamma consueta di dispositivi medici. Pertanto, l'attenzione si sta ora spostando su versioni "intelligenti" di vettori lipidici già collaudati, in cui una piccola modifica dell'ambiente interno (ad esempio, dovuta a eccipienti sicuri) trasforma il liposoma in un pulsante "ON" per gli ultrasuoni, con potenziali applicazioni che vanno dall'anestesia mirata alla neuropsicofarmacologia mirata.
Come funziona
- Nel liposoma viene versato un tampone contenente il 5% di saccarosio: questo aumenta l'impedenza acustica e crea un gradiente osmotico, che accelera il rilascio delle molecole quando esposte agli ultrasuoni.
- Gli ultrasuoni focalizzati (circa 250 kHz, ciclo di lavoro 25%, PRF 5 Hz; pressione negativa di picco nei tessuti ~0,9-1,7 MPa) vengono applicati all'area bersaglio e il liposoma si "apre", liberando il farmaco.
- Un dettaglio importante: non è necessario alcun riscaldamento (a 37°C l'effetto è ancora maggiore, ma funziona anche a temperatura ambiente) e l'approccio "zucchero" stesso utilizza eccipienti GRAS e processi standard di produzione dei liposomi.
Cosa è stato mostrato esattamente
- In vitro: la piattaforma funziona con quattro farmaci contemporaneamente:
- Ketamina (anestetico/antidepressivo);
- Ropivacaina, bupivacaina, lidocaina (anestetici locali).
L'aggiunta di saccarosio al 5-10% ha prodotto un rilascio di circa il 40-60% al minuto rispetto alla sonicazione standard; il 10% è più potente, ma ha una stabilità inferiore, quindi la dose ottimale è il 5%.
- Nel cervello (SNC): dopo infusione endovenosa di SonoKet (ketamina in AAL), l'ecografia alla mPFC o alla corteccia retrospleniale ha aumentato i livelli di farmaco nel sito bersaglio rispetto al controllo controlaterale/finto e ha indotto alterazioni elettrofisiologiche senza danni tissutali. Non si è osservata alcuna apertura della barriera ematoencefalica o evidenza di danno da cavitazione.
- Nei nervi periferici (SNP): la formulazione SonoRopi (ropivacaina in AAL) con irradiazione esterna dell'area del nervo sciatico ha prodotto un blocco locale sul lato trattato, senza alterazioni dell'ECG e senza danni istologici nel tessuto.
Numeri da ricordare
- Parametri degli ultrasuoni: 250 kHz, 25% duty, 5 Hz PRF; nel cervello ~0,9-1,1 MPa, test in vitro fino a 1,7 MPa; “finestra” di esposizione - 60-150 s.
- Stabilità: a 4°C, gli AAL hanno mantenuto le dimensioni/polidispersità per almeno 90 giorni (DLS ~166-168 nm, PDI 0,06-0,07).
- Fisica di base: la forza di "apertura" è lineare con l'impedenza acustica dell'ambiente interno (correlazione r² ≈ 0,97 per tamponi equiosmolari NaCl/glucosio/saccarosio).
In che modo questo è migliore dei precedenti vettori "ultrasonici"?
- Privo di PFC e bolle di gas: minor rischio di cavitazione e instabilità.
- Senza riscaldare il tessuto: non sono necessarie condizioni di temperatura "pesanti" o requisiti di gioielleria per l'attrezzatura.
- Percorso venoso, farmaco standard: dimensioni ~165 nm, componenti lipidici familiari e saccarosio come chiave per la sensibilità acustica.
Perché la clinica ha bisogno di questo?
- Neuropsichiatria: le molecole simili alla ketamina sono efficaci ma presentano effetti collaterali discutibili. Concentrarsi sulla mPFC/altre regioni produrrebbe teoricamente effetti con minori effetti dissociativi/sedanti/simpaticomimetici.
- Sollievo dal dolore e anestesia regionale: il blocco nervoso controllato tramite ultrasuoni è "ad alta efficacia, basso effetto sistemico", promettendo una minore tossicità cardiovascolare e del SNC.
- Una piattaforma, non un caso isolato: l'approccio è trasferibile ad altri liposomi/vettori polimerici "liquido-nucleari" e, potenzialmente, a una varietà di farmaci.
E per quanto riguarda la sicurezza e la farmacocinetica?
- Nei ratti, l'istologia del cervello/tessuti terminali era priva di danni; negli esperimenti con parametri "cattivi" si sono verificate microemorragie, ma non in modalità di lavoro.
- Nel sangue, sono stati osservati più metaboliti e meno farmaco non metabolizzato negli organi parenchimali con AAL, in linea con l'assorbimento/metabolismo delle particelle da parte del fegato al basale e il rilascio ai bersagli durante la sonicazione.
Dov'è qui il "cucchiaio dello scetticismo"?
- Si tratta di uno studio preclinico sui roditori; la cinetica dell'assorbimento epatico e la "perdita" basale senza ultrasuoni richiedono un'ottimizzazione.
- Passare agli esseri umani semplificherà i dettagli metabolici (minore flusso sanguigno epatico), ma è obbligatoria la conferma della sicurezza/dosimetria.
- La selezione delle modalità ultrasoniche e degli eccipienti (che modificano l'acustica in modo più marcato, ma non compromettono la stabilità) è il compito della prossima serie di lavori.
Conclusione
Il "riempimento di zucchero" dei liposomi trasforma gli ultrasuoni in un pulsante "ON" per i farmaci, piuttosto che in un rozzo "martello da fabbro". Di conseguenza, il farmaco può essere attivato localmente – in zone millimetriche del cervello o lungo un nervo – e disattivato nel resto del corpo. Non si tratta di magia, ma di ingegneria acustica e osmotica – e, a giudicare dai risultati, è molto vicina a diventare uno strumento di routine della farmacologia mirata.
Fonte: Mahaveer P. Purohit, Brenda J. Yu, Raag D. Airan et al. Liposomi attivabili acusticamente come nanotecnologia traslazionale per il rilascio mirato di farmaci e la neuromodulazione non invasiva. Nature Nanotechnology (pubblicato il 18 agosto 2025, accesso libero). DOI: 10.1038/s41565-025-01990-5.
