Nuove pubblicazioni
Il selenio al microscopio: da una “stretta finestra di sicurezza” a nuove idee terapeutiche
Ultima recensione: 18.08.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.
Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.
Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.
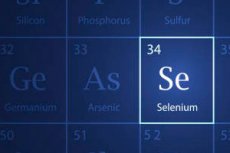
Il selenio è un oligoelemento con una biografia complessa: fin dalla sua scoperta nel 1817, è stato considerato tossico, fino a quando, nel 1957, si scoprì che protegge i ratti carenti di vitamina E dalla necrosi epatica ed è essenziale per l'uomo. Oggi conosciamo circa 25 geni delle selenoproteine e decine di processi in cui sono coinvolti, dalla protezione antiossidante e dalla regolazione della trascrizione alle funzioni immunitarie e riproduttive. Ma il selenio ha anche un "lato oscuro": un intervallo di consumo sicuro ristretto e diverse forme con biodisponibilità molto diverse. Tutto questo ha costituito la base di un numero speciale di Nutrients, per il quale i redattori hanno raccolto dati aggiornati, da modelli cellulari e animali a studi sull'uomo.
Sfondo
Il selenio è un micronutriente paradossale: enzimi chiave della protezione antiossidante e del metabolismo tiroideo (selenoproteine della famiglia GPx, TrxR, delle deiodinasi), funzioni immunitarie e riproduttive non possono funzionare senza di esso, ma la sua "dose utile" è limitata e l'effetto biologico dipende fortemente dalla forma (selenito, selenometionina/lievito, nuove nanoforme) e dalla dieta di base. Sulla mappa del mondo, la presenza di selenio è distribuita a punti: nelle regioni con terreni poveri, si sono storicamente verificate sindromi da carenza (cardiomiopatia, artropatie), mentre in quelle "ricche" c'è il rischio di eccesso cronico (selenosi), perdita di capelli, dermatopatie. Per la clinica e la salute pubblica, questo crea un problema a "U": sia la carenza che l'eccesso sono ugualmente pericolosi.
Il quadro è complicato dalla metodologia e dalle prove.
- Misure di stato: Se sierico totale, selenoproteina P, attività GPx - marcatori di diversa “profondità”, non sempre intercambiabili.
- Eterogeneità degli interventi: forme organiche e inorganiche, dosi “ad occhio”, diverse matrici alimentari → diversa biodisponibilità e distribuzione nei tessuti.
- Endpoint: da quelli molecolari (segnali redox, ferroptosi) a quelli clinici (esiti cardiovascolari, epatici, oncologici); non sempre sono disponibili studi randomizzati con endpoint rigidi.
- Combinazioni di nutrienti: il selenio è stato a lungo studiato “in combinazione” (ad esempio, con la vitamina E, il coenzima Q₁₀), ma le regole del “chi con chi e quando” sono ancora in fase di definizione.
- Fattori personali: genetica del metabolismo del Se, microbiota, background proteico-amminoacidico della dieta, età e malattie concomitanti modificano la risposta alle stesse dosi.
In questo contesto, è nato il numero dedicato ai nutrienti: sistematizza dove il selenio apporta effettivamente benefici (e in quale forma), dove i rischi sono superiori, come combinare il selenio con altri micro e macronutrienti e quali modelli/biomarcatori dovrebbero essere utilizzati negli studi futuri. L'obiettivo è passare dal consiglio universale di "assumere selenio" alla nutrizione di precisione: valutazione dello stato basale, scelta equilibrata di forma e dose, indicazioni chiare e monitoraggio della sicurezza.
Cosa c'è di importante nel selenio
- Biologia: gli effetti principali sono mediati dalle selenoproteine (ad esempio la famiglia della glutatione perossidasi), che supportano l'omeostasi redox, l'apoptosi, lo sviluppo del SNC e la resistenza allo stress.
- La dose è determinante: una carenza è causa di disturbi immunitari e patologie specifiche, un eccesso di dermatiti, perdita di capelli e un possibile aumento del rischio di diversi problemi metabolici/neurologici. La "giusta via di mezzo" dipende dalla forma (organica/inorganica) e dal contenuto di aminoacidi nella dieta.
- La forma è importante: selenito, selenometionina/lievito, nanoparticelle: si tratta di farmacocinetiche ed effetti sui tessuti diversi; "un selenio" ≠ "tutto uguale".
La questione si è rivelata "a mosaico": gli autori non cercano una pillola magica, ma mostrano esattamente dove i microelementi (incluso il selenio) sono in grado di modificare la traiettoria della malattia, e dove è ancora troppo presto per trarre conclusioni definitive. Di seguito i punti principali.
Cosa ha mostrato il numero speciale: risultati e tendenze chiave
- Chi assume il selenio e dove (Stati Uniti, NHANES): i dati trasversali indicano che il selenio totale assunto con la dieta è il principale predittore dei livelli di selenio nel sangue (tenendo conto di sesso, razza, istruzione, reddito, BMI, fumo/alcol). Un'analisi separata associa selenio e manganese a parametri eritrocitari migliori, mentre il cromo a parametri peggiori (associazioni con i livelli ematici).
- Muscoli e forme di Se (modello adolescenziale): le nanoparticelle di selenite e selenio agiscono in modo diverso: le nanoparticelle di Se hanno peggiorato la massa muscolare e l'aumento di proteine e hanno interrotto la segnalazione dell'insulina, mentre la selenite, al contrario, ha "smorzato" il catabolismo. Conclusione: il potenziale terapeutico dipende dalla forma.
- Fegato e selenio "alleati": la co-somministrazione di coenzima Q e Se nel modello MASH ha ridotto lo stress ossidativo, la perossidazione lipidica e la ferroptosi, riducendo al contempo infiammazione e fibrosi. Un suggerimento per strategie combinate di supporto nutrizionale al fegato.
- Oncologia e Selol: una miscela di trigliceridi di selenite ha aumentato l'attività degli enzimi antiossidanti nei topi sani e ha modificato la morfologia delle cellule tumorali in un modello di cancro alla prostata. C'è interesse meccanicistico, ma è lontano dall'uso clinico.
- Non solo Se: magnesio nel morbo di Crohn: una meta-analisi ha mostrato livelli e assunzioni di Mg più bassi nei pazienti; gli integratori di magnesio sono stati associati a maggiori possibilità di remissione e a un sonno migliore.
- Vitamina D nei bambini in età prescolare: uno studio trasversale rumeno ha supportato l'idea di prevenire le infezioni respiratorie con un livello sufficiente di vitamina D, un argomento a favore delle raccomandazioni stagionali.
- “Il cibo come medicina” per i reni: una revisione dei micronutrienti botanici (il concetto di omologia medicina-cibo) ha sistematizzato i meccanismi di nefroprotezione: dai percorsi antiossidanti alla modulazione dell’infiammazione.
Cosa significa questo per la pratica?
- Selenio - sì, ma mirato:
• valutare lo stato (dieta, geografia, gruppi prioritari),
• scegliere una forma (le forme organiche e il lievito sono spesso preferibili alla selenite nella prevenzione; non viene trasferito meccanicamente alla terapia!),
• evitare l'autodosaggio: "un po' troppo poco" e "un po' troppo" sono separati da una banda stretta. - Pensate alle combinazioni: laddove lo stress ossidativo gioca un ruolo (fegato in MASH, sarcopenia), gli approcci combinati sono ragionevoli (ad esempio, CoQ + Se); per ora si tratta di un'ipotesi basata su dati preclinici.
- Non bisogna guardare solo al selenio: anche le carenze di Mg o vitamina D sono clinicamente significative; le fasce vulnerabili (IBD, bambini) traggono beneficio dallo screening dello stato di salute e da una corretta integrazione.
Dove sono ora le "linee rosse"?
- Forme di selenio ≠ compresse intercambiabili. Le nanoforme e la selenite producono segnali diversi nei tessuti; i risultati ottenuti su modelli animali non possono essere trasferiti direttamente all'uomo.
- Associazione non significa causalità. La maggior parte dei dati "umani" sono trasversali: utili per ipotesi, non per prescrizioni. Sono necessari studi randomizzati con biomarcatori di inclusione e risultati "duri".
- "Finestra di sicurezza" ristretta. Assumere regolarmente "multivitaminici con Se" "per ogni evenienza" è una cattiva idea: il rischio di "saltare" all'eccesso è reale, soprattutto se si consumano contemporaneamente alimenti ricchi di Se.
Dove dovrebbe muoversi la scienza: compiti mirati per i prossimi anni
- Decifrare i "cavalli neri" tra le selenoproteine: funzioni di proteine poco studiate e loro ruoli specifici nei tessuti (cervello, immunità, riproduzione).
- Confronta le forme in clinica: studi RCT comparativi di forme organiche, selenite e (attenzione) nanoforme, con farmacocinetica e marcatori tissutali di azione.
- Regimi nutrizionali combinati: Se + CoQ in MASH, Se + proteine/amminoacidi negli studi sulla sarcopenia, con endpoint ben progettati.
- Personalizzazione della dose: tenendo conto della genetica del metabolismo del Se, della dieta di base degli aminoacidi e del microbiota per personalizzare dosi e forme.
Conclusione
Questo numero speciale non fa scalpore: riporta ordine laddove il selenio (e altri micronutrienti) è realmente appropriato e dove è importante non nuocere. In pratica, questo significa "meno schemi universali, più stratificazione": valutare lo stato, scegliere una forma, lavorare sulle carenze e aggiungere attentamente combinazioni laddove abbiano senso dal punto di vista biologico.
Fonte: Shuang-Qing Zhang. Effetti dell'assunzione di selenio e altri micronutrienti sulla salute umana. Editoriale del numero speciale di Nutrients, 7 luglio 2025; 17(13):2239. https://doi.org/10.3390/nu17132239
