Esperto medico dell'articolo
Nuove pubblicazioni
Immunodeficienza secondaria
Ultima recensione: 04.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.
Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.
Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.
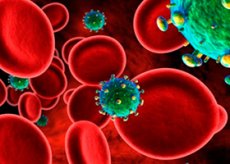
Significativa prevalenza nella popolazione di malattie infettive e infiammatorie croniche, refrattarie al trattamento convenzionale e concomitanti a numerose patologie somatiche; decorso grave delle malattie infettive acute, talvolta fatali; complicazioni settiche dopo interventi chirurgici, gravi ferite, stress, ustioni; complicazioni infettive in concomitanza con chemioradioterapia; elevata prevalenza di persone malate frequentemente e a lungo termine, che causano fino al 40% di tutte le perdite di parto; la comparsa di una malattia infettiva del sistema immunitario come l'AIDS ha determinato la comparsa del termine immunodeficienza secondaria.
L'immunodeficienza secondaria è rappresentata da disturbi del sistema immunitario che si sviluppano nel tardo periodo postnatale in adulti e bambini e non sono il risultato di alcun difetto genetico. Hanno un meccanismo di origine eterogeneo, che porta a un aumento della morbilità infettiva; decorso atipico del processo infettivo e infiammatorio di varie localizzazioni ed eziologie, con trattamento eziotropico da torpore a adeguatamente selezionato. L'immunodeficienza secondaria è caratterizzata dalla presenza obbligatoria di infezione del processo purulento-infiammatorio. È opportuno notare che l'infezione stessa può essere sia una manifestazione che una causa di una violazione della risposta immunitaria.
Sotto l'influenza di vari fattori (infezioni, farmacoterapia, radioterapia, diverse situazioni di stress, lesioni, ecc.) può svilupparsi un deficit della risposta immunitaria, che porta allo sviluppo di alterazioni sia transitorie che irreversibili. Queste alterazioni possono essere la causa dell'indebolimento delle difese anti-infettive.
 [ 1 ]
[ 1 ]
Quali sono le cause dell'immunodeficienza secondaria?
La classificazione più diffusa e accettata delle immunodeficienze secondarie è stata proposta da RM Khaiton. Vengono distinte tre forme di immunodeficienze secondarie.
- immunodeficienza secondaria acquisita (AIDS);
- indotto;
- spontaneo.
L'immunodeficienza secondaria indotta si verifica a seguito di cause esterne che ne hanno determinato la comparsa: infezioni, radiografie, terapia citostatica, uso di glucocorticoidi, lesioni e interventi chirurgici. Inoltre, la forma indotta include disturbi immunitari che si sviluppano secondariamente alla malattia principale (diabete, malattie epatiche, malattie renali, neoplasie maligne). In presenza di una causa specifica che porta a un difetto irreversibile del sistema immunitario, si forma un'immunodeficienza secondaria con manifestazioni cliniche e principi di trattamento caratteristici. Ad esempio, sullo sfondo di radioterapia e chemioterapia, è possibile un danno irreversibile al pool di cellule responsabili della sintesi delle immunoglobuline, e quindi questi pazienti, nel loro decorso clinico e nei principi di trattamento, assomigliano ai pazienti con malattia infiammatoria pelvica (PID) con danno al legame umorale dell'immunità. Nel XX secolo, l'umanità ha incontrato per la prima volta l'infezione virale da HIV, in cui il virus danneggia irreversibilmente le cellule del sistema immunitario, causando lo sviluppo di una grave malattia infettiva: l'AIDS. Questa malattia è caratterizzata da un alto tasso di mortalità, caratteristiche epidemiologiche proprie, un proprio insieme di manifestazioni cliniche e principi di trattamento. In questo caso, l'induttore dello sviluppo dell'immunodeficienza è un virus immunotropico che danneggia irreversibilmente i linfociti, causando immunodeficienza secondaria. Considerando il danno irreversibile diretto del virus alle cellule immunocompetenti (linfociti T), nonché la gravità e le caratteristiche epidemiche del decorso di questa malattia, è stata isolata in un gruppo separato di immunodeficienze geneticamente non determinate, ovvero l'immunodeficienza acquisita secondaria - AIDS.
In caso di un difetto reversibile del sistema immunitario, non si verifica una malattia indipendente, ma si verifica un aumento della morbilità infettiva a fronte della malattia di base (diabete mellito, malattie renali, malattie epatiche, neoplasie maligne, ecc.) o a fronte di un effetto induttore (infezioni, stress, farmacoterapia, ecc.). Tale immunodeficienza secondaria può spesso essere eliminata eliminando la causa che l'ha causata e con un trattamento di base adeguatamente selezionato per la malattia di base. Il trattamento di questi pazienti si basa principalmente su una diagnosi corretta, sulla correzione della patologia concomitante, tenendo conto degli effetti collaterali della farmacoterapia volta a eliminare quelli che portano all'immunodeficienza.
L'immunodeficienza secondaria spontanea è caratterizzata dall'assenza di una causa evidente che abbia causato un disturbo del sistema immunitario. La manifestazione clinica di questa forma è rappresentata da malattie infettive e infiammatorie croniche, spesso ricorrenti, dell'apparato broncopolmonare, dei seni paranasali, dell'apparato genitourinario e digerente, degli occhi, della pelle e dei tessuti molli, causate da microrganismi opportunisti o patogeni. I pazienti con immunodeficienze secondarie spontanee rappresentano un gruppo eterogeneo e molti ritengono che queste malattie debbano essere basate su cause ancora sconosciute. Si può presumere che la causa delle immunodeficienze secondarie sia una carenza congenita di qualche componente del sistema immunitario, compensata per un certo periodo grazie alla normale elevata attività funzionale di altri anelli di questo sistema. Tale carenza non può essere identificata per vari motivi: approccio metodologico inadeguato, utilizzo di materiale di ricerca inappropriato o impossibilità di identificare il disturbo in questa fase dello sviluppo scientifico. Quando viene identificato un difetto del sistema immunitario, alcuni pazienti potrebbero successivamente essere inseriti nel gruppo con PID. Pertanto, il confine tra i concetti di immunodeficienza primaria e secondaria (soprattutto nella forma spontanea) può essere condizionale. Fattori ereditari ed effetti indotti svolgono un ruolo decisivo nel determinare la forma di immunodeficienza. D'altra parte, molto spesso ai pazienti vengono fornite ricerche insufficienti e pertanto la causa dell'immunodeficienza rimane non specificata. Quanto più approfondito viene condotto l'esame dei pazienti con immunodeficienza secondaria spontanea, tanto più ristretto diventa questo gruppo.
In termini quantitativi, l'immunodeficienza secondaria indotta prevale. È necessario evitare l'errore principale nella gestione del paziente e nell'assistenza sanitaria pratica, ovvero quando il decorso grave e lento di una malattia infiammatoria infettiva è causato non da un difetto del sistema immunitario, ma da un'errata attribuzione di cause ed effetti, nonché da un errore diagnostico.
Poiché allo stato attuale, dato lo stato delle basi diagnostiche dell'immunologia clinica, non è sempre possibile determinare i marcatori di laboratorio degli stati di immunodeficienza, la diagnosi di "immunodeficienza secondaria" è principalmente un concetto clinico. Il principale segno clinico dell'immunodeficienza secondaria è il decorso atipico di processi infiammatori infettivi acuti e cronici, che risultano insensibili a un trattamento adeguato.
Quando si può sospettare un'immunodeficienza secondaria?
Le malattie più comuni che possono accompagnare sia le forme congenite che quelle acquisite di immunodeficienza e per le quali è obbligatorio l'esame immunologico sono:
- infezioni generalizzate: sepsi, meningite purulenta, ecc.;
- bronchite cronica con frequenti ricadute e anamnesi di polmonite e combinazione con malattie ORL (sinusite purulenta, otite, linfoadenite), resistenti alla terapia standard;
- polmonite e broncopleuropolmonite ricorrenti;
- bronchiectasie;
- infezioni batteriche croniche della pelle e del tessuto sottocutaneo (piodermite, foruncolosi, ascessi, flemmone, granulomi settici, paraproctite ricorrente negli adulti);
- infezioni fungine croniche della pelle e delle mucose, candidosi, malattie parassitarie;
- stomatite aftosa ricorrente in combinazione con aumentata incidenza di infezioni virali respiratorie acute;
- infezione ricorrente da virus herpes di varie localizzazioni;
- gastroenteropatia con diarrea cronica ad eziologia sconosciuta, disbatteriosi intestinale;
- linfoadenopatia, linfoadenite ricorrente;
- temperatura subfebbrile prolungata, GNL.
Queste malattie possono manifestarsi sullo sfondo di patologie somatiche preesistenti, il cui decorso e trattamento predispongono alla formazione di immunodeficienza con una diminuzione della tolleranza alle infezioni (diabete mellito, malattie autoimmuni, oncologiche, ecc.).
Come si manifesta l’immunodeficienza secondaria?
I sintomi dell'immunodeficienza secondaria sono aspecifici e multiformi. L'ICD-10 non prevede una diagnosi di "immunodeficienza secondaria", ad eccezione dell'immunodeficienza acquisita (AIDS). In questa classificazione, gli adulti non hanno una diagnosi di PID (a differenza della classificazione pediatrica delle malattie). Pertanto, sorge una legittima domanda sul coordinamento della diagnosi di "immunodeficienza secondaria" con l'ICD-10. Alcuni suggeriscono la seguente soluzione a questo problema: quando le alterazioni dello stato immunitario sono irreversibili e portano alla formazione di una malattia, allora la diagnosi dovrebbe essere fatta del difetto immunologico identificato, poiché ciò implica un complesso certo e permanente di misure terapeutiche, ad esempio AIDS; AO con una compromissione del sistema del complemento; la diagnosi principale è un tumore cerebrale; la condizione dopo radioterapia e chemioterapia è l'ipogammaglobulinemia; sinusite purulenta cronica.
Quando le alterazioni dello stato immunitario sono reversibili e accompagnano malattie somatiche o possono essere il risultato di trattamenti farmacologici o di altro tipo, le anomalie transitorie di laboratorio rilevate non sono incluse nella diagnosi. La diagnosi viene stabilita in base alla malattia di base e alla patologia concomitante, ad esempio: la diagnosi principale è diabete mellito di tipo II, decorso grave, variante insulino-dipendente, fase di scompenso; le complicanze sono foruncolosi cronica ricorrente, riacutizzazione.
Come riconoscere l'immunodeficienza secondaria?
I test di laboratorio immunologici di screening (Livello 1) sono disponibili, appropriati e possono essere eseguiti in molti ospedali e cliniche dotati di un laboratorio di diagnostica clinica. Tali test includono lo studio dei seguenti indicatori:
- numero assoluto di leucociti, neutrofili, linfociti e piastrine;
- livelli di proteine e frazione y;
- livello delle immunoglobuline sieriche IgG, IgA, IgM, IgE;
- attività emolitica del complemento;
- ipersensibilità ritardata (test cutanei).
Un'analisi approfondita può essere effettuata solo in un istituto medico e preventivo specializzato, dotato di un moderno laboratorio di immunologia clinica.
Gli studi sullo stato immunitario nelle immunodeficienze dovrebbero includere lo studio della quantità e dell'attività funzionale dei principali componenti del sistema immunitario che svolgono un ruolo fondamentale nella difesa anti-infettiva dell'organismo. Tra questi rientrano il sistema fagocitico, il sistema del complemento e le sottopopolazioni di linfociti T e B. I metodi utilizzati per valutare il funzionamento del sistema immunitario sono stati suddivisi condizionatamente da RV Petrov et al. nel 1984 in test di 1° e 2° livello. I test di 1° livello sono indicativi e mirano a identificare difetti macroscopici del sistema immunitario che determinano una diminuzione della difesa anti-infettiva.
I test di Livello 2 sono test aggiuntivi volti a identificare una specifica patologia del sistema immunitario. Integrano significativamente le informazioni sul funzionamento del sistema immunitario corrispondente.
Test di livello 1 per la valutazione del legame fagocitario:
- determinazione del numero assoluto di neutrofili e monociti;
- determinazione dell'intensità di neutralizzazione dei microrganismi da parte dei neutrofili e dei monociti;
- determinazione del contenuto di forme di ossigeno attivo.
Test di livello 1 per la valutazione del sistema immunitario B:
- determinazione del livello di IgG, IgA, IgM e IgE nel siero sanguigno;
- determinazione della percentuale e del numero assoluto di linfociti B (CD19, CD20) nel sangue periferico.
La determinazione del livello di immunoglobuline è un metodo importante e affidabile per valutare le funzioni del sistema immunitario B. Può essere considerato il metodo principale per diagnosticare tutte le forme di immunodeficienza associate a una ridotta sintesi di anticorpi. Questo tipo di disturbo è quello più frequente. Può accompagnare molte malattie somatiche e condizioni acute associate a un aumento del catabolismo o a una ridotta sintesi di immunoglobuline.
Test di livello 1 per la valutazione del sistema immunitario T:
- determinazione del numero totale dei linfociti;
- determinazione della percentuale e del numero assoluto di linfociti T maturi (CD3 e le loro due principali sottopopolazioni: helper (CD4) e killer (CD8));
- rilevazione della risposta proliferativa dei linfociti T ai mitogeni (fitoemoagglutinano e concanavalina A).
I test di livello 2 sono finalizzati allo studio approfondito dello stato immunitario, all'identificazione delle cause dei disturbi e dei difetti del sistema immunitario a livello cellulare, molecolare e genetico-molecolare.
Test di livello 2 per la valutazione della fagocitosi:
- determinazione dell'intensità della chemiotassi dei fagociti:
- instaurazione dell'espressione di molecole di adesione (CD11a, CD11b, CD11c, CD18) sulla membrana superficiale dei neutrofili;
- determinazione del completamento della fagocitosi mediante semina o citometria a flusso.
Test di livello 2 per la valutazione del sistema immunitario B:
- determinazione del contenuto delle sottoclassi di immunoglobuline (in particolare IgG):
- determinazione del contenuto di IgA secretorie;
- stabilire il rapporto tra le catene kappa e lambda:
- determinazione del contenuto di anticorpi specifici contro antigeni proteici e polisaccaridici;
- Determinazione della capacità dei linfociti di rispondere ai mitogeni con proliferazione: cellule B - stafilococco, lipopolisaccaride degli enterobatteri; cellule T e B - mitogeno della fitolacca.
La determinazione delle sottoclassi di IgG ha un certo valore diagnostico, poiché una carenza di sottoclassi di immunoglobuline può verificarsi anche con un livello normale di IgG. In alcuni casi, queste persone presentano un'immunodeficienza secondaria sotto forma di protezione anti-infettiva indebolita, ovvero la sottoclasse di IgG2, che contiene principalmente anticorpi contro i polisaccaridi dei batteri capsulati (Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae). Informazioni importanti sullo stato dell'immunità umorale vengono fornite dalla determinazione del livello di anticorpi contro antigeni proteici e polisaccaridici batterici, poiché il grado di protezione dell'organismo da una specifica infezione dipende dal livello generale di immunoglobuline e dal numero di anticorpi contro il suo agente patogeno. Pertanto, l'assenza di anticorpi IgG specifici per un'infezione pregressa è sempre un segno prognosticamente favorevole. Informazioni preziose sullo stato dell'immunità umorale possono essere ottenute anche studiandone le proprietà funzionali. Innanzitutto, ciò include una proprietà degli anticorpi come l'affinità, da cui dipende in larga misura la forza dell'interazione degli anticorpi con l'antigene. La produzione di anticorpi a bassa affinità può portare a una protezione insufficiente contro le infezioni.
Il sistema immunitario B può essere valutato in base al livello e alla qualità dell'attività funzionale delle immunoglobuline, poiché queste costituiscono il principale prodotto finale di queste cellule. Tale approccio è ancora difficile da implementare in relazione al sistema immunitario T, poiché il principale prodotto finale dell'attivazione dei linfociti T sono le citochine e i sistemi per la loro determinazione sono ancora scarsamente disponibili nella pratica sanitaria. Ciononostante, la valutazione dell'attività funzionale del sistema immunitario T è un compito estremamente importante, poiché questa attività può essere significativamente ridotta con un numero normale di linfociti T e il rapporto tra le loro sottopopolazioni. I metodi per valutare l'attività funzionale dei linfociti T sono piuttosto complessi. Il più semplice è la reazione di trasformazione blastica che utilizza due principali mitogeni T: fitoemoagglutinina e concanavalina A. La risposta proliferativa dei linfociti T ai mitogeni è ridotta in quasi tutti i processi infiammatori infettivi cronici, nelle malattie maligne (in particolare del sistema emopoietico); in tutti i tipi di trattamento immunosoppressivo, AIDS e tutti i tipi di immunodeficienza primaria delle cellule T.
La determinazione della produzione di citochine da parte di linfociti e macrofagi è ancora di grande importanza. La determinazione di citochine come TNF, IL-1 e IF-γ svolge un ruolo fondamentale nell'eziopatogenesi di vari processi infiammatori acuti e cronici, non solo di natura infettiva, ma anche autoimmune. La loro aumentata produzione è la causa principale dello shock settico.
È opportuno notare che le citochine sono mediatori delle interazioni cellulari; determinano solo la gravità dell'infiammazione, sia infettiva che non infettiva.
Lo studio dell'espressione delle molecole di attivazione e di adesione sulla superficie dei linfociti fornisce informazioni importanti sul grado di attivazione. Un'espressione alterata del recettore dell'IL-2 è stata osservata in molte malattie ematologiche maligne (leucemia a cellule T, leucemia a cellule capellute, linfogranulomatosi, ecc.) e in processi autoimmuni (artrite reumatoide, lupus eritematoso sistemico, anemia aplastica, sclerodermia, morbo di Crohn, sarcoidosi, diabete mellito, ecc.).
Secondo le raccomandazioni di specialisti stranieri e in conformità con le raccomandazioni degli esperti dell'OMS, i test cutanei nella diagnosi delle immunodeficienze delle cellule T vengono utilizzati come test di screening o test di primo livello. I test cutanei sono i test più semplici e allo stesso tempo più informativi che consentono di valutare l'attività funzionale dei linfociti T. Test cutanei positivi ad alcuni antigeni microbici con elevata probabilità consentono di escludere la presenza di immunodeficienza delle cellule T nel paziente. Diverse aziende occidentali hanno sviluppato sistemi standardizzati per la determinazione dei test cutanei che includono i principali antigeni per la determinazione dell'immunità delle cellule T. Ciò consente di valutare l'attività funzionale del sistema immunitario delle cellule T in condizioni rigorosamente controllate. Sfortunatamente, i sistemi di test cutanei per la valutazione del sistema immunitario delle cellule T sono assenti in Russia e, pertanto, non vengono praticamente utilizzati.
Schema di esame dei vari collegamenti del sistema immunitario
Immunità umorale:
- classi principali e sottoclassi di immunoglobuline: IgG (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) IgA, IgM, IgE; IgA, IgM, IgG, IgE antigene-specifiche; complessi immunitari circolanti;
- sistema del complemento: inibitore C3, C4, C5, C1;
- affinità anticorpale.
Fagocitosi:
- indice fagocitario dei neutrofili e dei monociti;
- indice opsonico;
- attività battericida e fungicida intracellulare dei fagociti;
- formazione di specie reattive dell'ossigeno nella chemiluminescenza spontanea e indotta dipendente da luminol e lucentinina.
Immunofenotipizzazione:
- CD19, CD3, CD3 CD4, CD3 CD8, CD3-HLA-DR, CD3-HLA-DR;
- CD3 CD16/56. CD4 CD25.
Attività funzionale dei linfociti:
- Risposta proliferativa ai mitogeni T e B;
- Attività citotossica delle cellule RL;
- Determinazione del profilo delle citochine (IL I, IL-2, IL-4, IL-6, ecc.).
Profilo dell'interferone:
- determinazione dell'IF-a nel siero sanguigno e nel supernatante delle sospensioni leucocitarie attivate dal virus della malattia di Newcastle;
- determinazione dell'IF-γ nel siero sanguigno e nel surnatante delle sospensioni linfocitarie attivate dalla fitoemoagglutinina.
In base alla natura delle alterazioni identificate durante l'esame immunologico, i pazienti con immunodeficienza secondaria possono essere suddivisi in tre gruppi:
- pazienti con segni clinici di immunodeficienza e alterazioni identificate nei parametri dello stato immunitario;
- pazienti con solo segni clinici di immunodeficienza e indicatori dello stato immunitario normali;
- pazienti senza manifestazioni cliniche di immunodeficienza, ma con alterazioni identificate nei parametri dello stato immunitario.
Per i gruppi 1 e 2, è necessario selezionare un trattamento immunotropico. Il gruppo 3 richiede osservazione e visita di controllo da parte di un immunologo per escludere artefatti di ricerca, nonché un esame clinico approfondito per chiarire le cause che hanno portato alle alterazioni immunologiche.
Trattamento dell'immunodeficienza secondaria
Lo strumento principale per il trattamento dei pazienti con immunodeficienza secondaria è la terapia immunotropica. Si articola in tre direzioni:
- immunizzazione attiva (vaccinazione);
- terapia sostitutiva (preparati ematici: plasma, immunoglobuline, massa leucocitaria, ecc.);
- farmaci immunotropici (immunostimolanti, fattori stimolanti le colonie di granulociti-macrofagi; immunomodulatori di origine esogena ed endogena, chimicamente puri e di sintesi)
La scelta del trattamento immunotropico dipende dalla gravità del processo infettivo e infiammatorio e dal difetto immunologico identificato.
Terapia vaccinale
La terapia vaccinale viene utilizzata esclusivamente a scopo profilattico durante il periodo di remissione delle malattie infettive e somatiche. Ciascuno dei farmaci utilizzati ha indicazioni, controindicazioni e schemi d'uso specifici.
Terapia sostitutiva per l'immunodeficienza secondaria
Può essere utilizzato in qualsiasi fase del processo infettivo e infiammatorio. I farmaci della terapia sostitutiva sono i farmaci di scelta in caso di malattia acuta. Le immunoglobuline per via endovenosa sono le più utilizzate. I principali componenti attivi di questi farmaci sono anticorpi specifici, ottenuti da un gran numero di donatori. Attualmente, le immunoglobuline per via endovenosa vengono utilizzate per prevenire i processi infettivi e trattare le malattie nella cui patogenesi sono presenti difetti dell'immunità umorale. La terapia sostitutiva viene eseguita per reintegrare la carenza di anticorpi in una serie di malattie acute e croniche con immunodeficienza secondaria, accompagnata da ipogammaglobulinemia, causata da un aumentato catabolismo delle immunoglobuline o da una compromissione della loro sintesi.
Un aumento del catabolismo delle immunoglobuline si osserva nella sindrome nefrosica, nelle enteropatie di varia eziologia, nelle ustioni, nel digiuno, nella paraproteinemia, nella sepsi e in altre condizioni. L'interruzione della sintesi delle immunoglobuline si verifica nei tumori primari del tessuto linfoide in concomitanza con il trattamento con citostatici, glucocorticoidi e radioterapia, nonché nelle malattie accompagnate da tossicosi (insufficienza renale, tireotossicosi, infezioni generalizzate gravi di varia eziologia).
La frequenza di somministrazione e il dosaggio delle immunoglobuline per via endovenosa dipendono dalla situazione clinica, dal livello iniziale di IgG, dalla gravità e dalla prevalenza del processo infettivo e infiammatorio. Le preparazioni di immunoglobuline per via endovenosa più utilizzate contengono solo IgG: gabriglobina (immunoglobulina umana normale), octagam (immunoglobulina umana normale), intraglobina (immunoglobulina umana normale). Le immunoglobuline per via endovenosa contenenti tutte e tre le classi di immunoglobuline (IgA, IgM, IgG) simili a quelle plasmatiche - pentaglobina (immunoglobulina umana normale |1gG+IgA+IgM]) sono incluse negli standard per il trattamento dei pazienti settici. Le immunoglobuline con un titolo di IgG aumentato contro antigeni specifici, come il cytotec (immunoglobulina anti-citomegalovirus) con un titolo di anticorpi aumentato contro l'infezione da citomegalovirus e il neohepatec (immunoglobulina contro l'epatite B umana) contro l'epatite B, sono utilizzate molto meno frequentemente. È importante ricordare che i preparati contenenti IgA (pentaglobina, plasma) sono controindicati nei pazienti con immunodeficienza selettiva A.
Trattamento immunotropico dell'immunodeficienza secondaria
E attualmente non vi è dubbio che l'uso di immunomodulatori di varia origine nel trattamento complesso di processi infettivi e infiammatori aumenti l'efficacia della terapia antimicrobica. Gli immunomodulatori sono ampiamente utilizzati nei pazienti con immunodeficienza secondaria.
Principi generali sull'uso degli immunomodulatori nei pazienti con protezione anti-infettiva insufficiente.
- Gli immunomodulatori sono prescritti in combinazione con il trattamento eziotropico del processo infettivo. La monoterapia è consentita solo in fase di remissione del processo infettivo.
- La scelta dell'immunomodulatore e lo schema del suo utilizzo vengono determinati in base alla gravità del processo infiammatorio infettivo, alla sua causa, al difetto immunitario identificato, tenendo conto delle malattie somatiche e degli effetti induttivi.
- I criteri principali per la prescrizione di farmaci immunomodulatori sono le manifestazioni cliniche dell'immunodeficienza (presenza di un processo infiammatorio infettivo resistente a un adeguato trattamento eziotropico).
- Dosi, regimi e durata del trattamento devono essere conformi alle istruzioni del farmaco; l'adattamento dei regimi di impiego del farmaco deve essere effettuato solo da un immunologo clinico esperto.
- Se l'istituzione medica e preventiva in questione dispone di una base materiale e tecnica adeguata, è consigliabile utilizzare immunomodulatori sullo sfondo del monitoraggio immunologico, che dovrebbe essere effettuato indipendentemente dalle modifiche inizialmente identificate nei parametri immunologici.
- La presenza di qualsiasi parametro immunitario rilevato durante uno studio immunodiagnostico in una persona praticamente sana non può costituire la base per la prescrizione di un trattamento immunomodulatore. Tali pazienti devono sottoporsi a ulteriori accertamenti e sottoporsi alla supervisione di un immunologo.
Nonostante l'azione dei farmaci immunomodulatori sia multidirezionale, ognuno di essi presenta i suoi vantaggi. In caso di danno alle cellule del sistema monocito-macrofagico, si utilizzano poliossidonio (azoximer), galavit (aminodiidroftalazinedione sodico), broncomunal e ribomunil. In caso di difetti del sistema immunitario cellulare, è consigliabile prescrivere poliossidonio (azoximer), taktivin (timo).
Estratto), timotene (alfa-glutamil-triptofano), timalin (estratto di timo), imunofano (arginil-alfa-aspartil-lisil-valil-tirosil-arginina). In caso di alterata sintesi anticorpale da parte dei linfociti B e di ridotta affinità degli anticorpi al determinante antigenico comune, sono indicati galavit (aminodiidroftalazinedione sodico) e mielopidi. Le alterazioni degli indicatori di stato dell'interferone vengono corrette utilizzando farmaci induttori dell'interferone o una terapia sostitutiva con interferone naturale o ricombinante.
È necessario prestare attenzione quando si prescrivono immunomodulatori nella fase acuta del processo infettivo. Ad esempio, l'uso di preparati di origine microbica è sconsigliato in questo periodo a causa del possibile sviluppo di attivazione policlonale delle cellule del sistema immunitario. Quando si utilizzano citochine, è necessario ricordare che le indicazioni per il loro uso sono leucopenia, linfopenia e bassa attivazione spontanea dei neutrofili; in caso contrario, possono provocare una grave risposta infiammatoria sistemica, che può portare a shock settico. L'immunomodulatore più sicuro in questi casi è il poliossidonio, che, oltre all'effetto immunomodulatorio, possiede proprietà detossificanti, antiossidanti e chelanti.
Immunostimolanti
Le preparazioni di fattori stimolanti le colonie di granulociti-macrofagi vengono utilizzate solo nei casi di leucopenia grave e agranudocitosi sotto monitoraggio quotidiano degli esami clinici del sangue.
Pertanto, data la natura multifattoriale dei fattori eziologici coinvolti nella formazione di una malattia come l'immunodeficienza secondaria, il successo del trattamento di tali pazienti dipende dalla professionalità dell'immunologo, che porrà correttamente l'accento sulle relazioni causa-effetto, valuterà adeguatamente i risultati dello studio immunologico e selezionerà il trattamento immunotropico, che ridurrà la durata dell'ospedalizzazione, prolungherà la remissione nei processi infettivi e infiammatori cronici e, in alcuni casi, salverà la vita del paziente.
Tra gli immunomodulatori sistemici, merita attenzione l'uso di farmaci induttori dell'interferone, tra cui Lavomaks, compresse rivestite con film (principio attivo tiloron 0,125 g). Lavomaks induce la sintesi di tutti e tre i tipi di interferoni da parte dell'organo stesso, attivando meccanismi immunitari cellulari che, insieme, interrompono la riproduzione di virus e altri agenti intracellulari nelle cellule infette o ne causano la morte, favorendo l'eliminazione del virus. La sintesi di interferone nel sangue dopo la somministrazione di Lavomaks viene determinata 20-24 ore dopo l'assunzione del farmaco. Una caratteristica distintiva di Lavomaks come induttore dell'interferone è la capacità di indurre la circolazione a lungo termine nel sangue di dosi terapeutiche di IFN, prevenendo l'infezione di cellule non infette e creando una barriera antivirale, inibendo la sintesi di proteine specifiche del virus e la riproduzione intracellulare dell'HPV. Inoltre, l'induzione di IFN endogeno può essere considerata un meccanismo fisiologico di genesi dell'IFN. Schema posologico: 1 compressa per i primi due giorni, poi 1 compressa a giorni alterni. La dose giornaliera raccomandata è di 10-20 compresse.

