Esperto medico dell'articolo
Nuove pubblicazioni
Decifrare i risultati dell'elettroencefalogramma
Ultima recensione: 06.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.
Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.
Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.
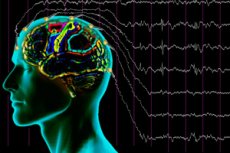
L'analisi EEG viene eseguita durante la registrazione e infine al suo completamento. Durante la registrazione, viene valutata la presenza di artefatti (induzione di campi di corrente di rete, artefatti meccanici dovuti al movimento degli elettrodi, elettromiogramma, elettrocardiogramma, ecc.) e vengono adottate misure per eliminarli. Vengono valutate la frequenza e l'ampiezza dell'EEG, identificati gli elementi grafici caratteristici e determinata la loro distribuzione spaziale e temporale. L'analisi viene completata dall'interpretazione fisiologica e patofisiologica dei risultati e dalla formulazione di una conclusione diagnostica con correlazione clinico-elettroencefalografica.
Il principale documento medico sull'EEG è il referto clinico-elettroencefalografico, redatto da uno specialista sulla base dell'analisi dell'EEG "grezzo". Il referto EEG deve essere formulato secondo determinate regole e consistere in tre parti:
- descrizione delle principali tipologie di attività ed elementi grafici;
- riassunto della descrizione e sua interpretazione patofisiologica;
- Correlazione dei risultati delle due parti precedenti con i dati clinici. Il termine descrittivo di base nell'EEG è "attività", che definisce qualsiasi sequenza di onde (attività alfa, attività a onde acute, ecc.).
- La frequenza è definita come il numero di oscillazioni al secondo; viene espressa in hertz (Hz) e rappresentata da un numero corrispondente. La descrizione fornisce la frequenza media dell'attività valutata. Solitamente, vengono acquisiti 4-5 segmenti EEG della durata di 1 secondo e viene calcolato il numero di onde in ciascuno di essi.
- L'ampiezza è l'intervallo delle oscillazioni del potenziale elettrico sull'EEG; viene misurata dal picco dell'onda precedente al picco dell'onda successiva in fase opposta, ed è espressa in microvolt (μV). Per misurare l'ampiezza viene utilizzato un segnale di calibrazione. Pertanto, se il segnale di calibrazione corrispondente a una tensione di 50 μV ha un'altezza di 10 mm sulla registrazione, di conseguenza, 1 mm di deflessione della penna significherà 5 μV. Per caratterizzare l'ampiezza dell'attività nella descrizione dell'EEG, vengono presi i suoi valori massimi più tipici, escludendo i valori anomali.
- La fase determina lo stato attuale del processo e indica la direzione del vettore delle sue variazioni. Alcuni fenomeni EEG sono valutati in base al numero di fasi che contengono. Monofasica è un'oscillazione in una direzione dalla linea isoelettrica con ritorno al livello iniziale, bifasica è un'oscillazione in cui, dopo il completamento di una fase, la curva supera il livello iniziale, devia nella direzione opposta e torna alla linea isoelettrica. Polifasica sono oscillazioni contenenti tre o più fasi. In senso più stretto, il termine "onda polifasica" definisce una sequenza di onde a e lente (solitamente 5).
Ritmi dell'elettroencefalogramma di una persona adulta sveglia
Il termine "ritmo" nell'EEG si riferisce a un certo tipo di attività elettrica corrispondente a un determinato stato cerebrale e associato a specifici meccanismi cerebrali. Quando si descrive un ritmo, se ne indicano la frequenza, tipica di un determinato stato e area cerebrale, l'ampiezza e alcune caratteristiche delle sue variazioni nel tempo, in relazione all'attività funzionale del cervello.
- Ritmo alfa(a): frequenza 8-13 Hz, ampiezza fino a 100 μV. È registrato nell'85-95% degli adulti sani. È meglio espresso nelle regioni occipitali. Il ritmo alfa presenta la massima ampiezza in uno stato di veglia calma e rilassata, con gli occhi chiusi. Oltre ai cambiamenti associati allo stato funzionale del cervello, nella maggior parte dei casi si osservano variazioni spontanee dell'ampiezza del ritmo alfa, che si esprimono in un'alternanza di aumento e diminuzione con la formazione di caratteristici "fusi" della durata di 2-8 secondi. Con l'aumento del livello di attività funzionale del cervello (attenzione intensa, paura), l'ampiezza del ritmo alfa diminuisce. Sull'EEG compare un'attività irregolare ad alta frequenza e bassa ampiezza, che riflette la desincronizzazione dell'attività neuronale. Con una stimolazione esterna improvvisa e di breve durata (in particolare un lampo di luce), questa desincronizzazione si verifica bruscamente e, se la stimolazione non è di natura emotiogenica, il ritmo a viene ripristinato abbastanza rapidamente (in 0,5-2 secondi). Questo fenomeno è chiamato "reazione di attivazione", "reazione di orientamento", "reazione di estinzione del ritmo a", "reazione di desincronizzazione".
- Ritmo beta: frequenza 14-40 Hz, ampiezza fino a 25 μV. Il ritmo beta è meglio registrato nell'area delle circonvoluzioni centrali, ma si estende anche alle circonvoluzioni centrali posteriori e frontali. Normalmente, è espresso molto debolmente e nella maggior parte dei casi ha un'ampiezza di 5-15 μV. Il ritmo beta è associato a meccanismi corticali somatici sensoriali e motori e provoca una reazione di estinzione all'attivazione motoria o alla stimolazione tattile. L'attività con una frequenza di 40-70 Hz e un'ampiezza di 5-7 μV è talvolta chiamata ritmo-y, ma non ha significato clinico.
- Ritmo mu: frequenza 8-13 Hz, ampiezza fino a 50 μV. I parametri del ritmo mu sono simili a quelli del ritmo a normale, ma il ritmo mu differisce da quest'ultimo per proprietà fisiologiche e topografia. Visivamente, il ritmo mu è osservato solo nel 5-15% dei soggetti nella regione rolandica. L'ampiezza del ritmo mu (in rari casi) aumenta con l'attivazione motoria o la stimolazione somatosensoriale. Nell'analisi di routine, il ritmo mu non ha alcun significato clinico.
Tipi di attività patologiche per una persona adulta sveglia
- Attività theta: frequenza 4-7 Hz, ampiezza dell'attività theta patologica > 40 μV e il più delle volte supera l'ampiezza dei ritmi cerebrali normali, raggiungendo 300 μV o più in alcune condizioni patologiche.
- Attività delta: frequenza 0,5-3 Hz, ampiezza uguale all'attività theta.
Oscillazioni theta e delta possono essere presenti in piccole quantità nell'EEG di una persona adulta sveglia e in condizioni normali, ma la loro ampiezza non supera quella del ritmo a. Un EEG contenente oscillazioni theta e delta con un'ampiezza >40 μV e che occupi più del 15% del tempo di registrazione totale è considerato patologico.
L'attività epilettiforme è un fenomeno tipicamente osservato nell'EEG dei pazienti con epilessia. Deriva da spostamenti parossistici di depolarizzazione altamente sincronizzati in ampie popolazioni di neuroni, accompagnati dalla generazione di potenziali d'azione. Ciò si traduce in potenziali acuti di elevata ampiezza, che hanno nomi corrispondenti.
- Spike (in inglese spike - point, peak) è un potenziale negativo di forma acuta, della durata inferiore a 70 ms, con un'ampiezza di >50 μV (talvolta fino a centinaia o addirittura migliaia di μV).
- Un'onda acuta differisce da un picco perché è prolungata nel tempo: la sua durata è di 70-200 ms.
- Onde acute e punte possono essere combinate con onde lente, formando complessi stereotipati. Un'onda punta-lenta è un complesso di una punta e di un'onda lenta. La frequenza dei complessi punta-onda lenta è di 2,5-6 Hz e il periodo, rispettivamente, è di 160-250 ms. Un'onda acuta-lenta è un complesso di un'onda acuta e di un'onda lenta successiva, il cui periodo è di 500-1300 ms.
Una caratteristica importante delle onde acute e acute è la loro improvvisa comparsa e scomparsa e la loro netta distinzione dall'attività di fondo, che superano in ampiezza. I fenomeni acuti con parametri corrispondenti non chiaramente distinguibili dall'attività di fondo non sono definiti onde acute o acute.
Le combinazioni dei fenomeni descritti sono designate da alcuni termini aggiuntivi.
- Burst è un termine utilizzato per descrivere un gruppo di onde con inizio e fine improvvisi, nettamente distinte dall'attività di fondo per frequenza, forma e/o ampiezza.
- Una scarica è un'esplosione di attività epilettiforme.
- Un quadro di crisi epilettica è una scarica di attività epilettiforme che tipicamente coincide con una crisi epilettica clinica. La rilevazione di tali fenomeni, anche se lo stato di coscienza del paziente non può essere chiaramente valutato clinicamente, è anch'essa definita "quadro di crisi epilettica".
- L'ipsaritmia (in greco: "ritmo ad alta ampiezza") è un'attività ipersincrona lenta, continua e generalizzata, ad alta ampiezza (>150 μV), con onde acute, punte, complessi punta-onda lenta, polipunta-onda lenta, sincroni e asincroni. Un'importante caratteristica diagnostica delle sindromi di West e Lennox-Gastaut.
- I complessi periodici sono impulsi di attività ad alta ampiezza caratterizzati da una forma costante per un dato paziente. I criteri più importanti per il loro riconoscimento sono: un intervallo pressoché costante tra i complessi; presenza continua durante l'intera registrazione, a condizione che il livello di attività cerebrale funzionale sia costante; stabilità intra-individuale della forma (stereotipicità). Il più delle volte, sono rappresentati da un gruppo di onde lente ad alta ampiezza e onde acute, combinate con oscillazioni delta o theta ad alta ampiezza e acute, che a volte assomigliano a complessi epilettiformi di un'onda acuta-lenta. Gli intervalli tra i complessi variano da 0,5-2 a decine di secondi. I complessi periodici generalizzati bilateralmente sincroni sono sempre associati a gravi disturbi della coscienza e indicano un grave danno cerebrale. Se non sono causati da fattori farmacologici o tossici (astinenza da alcol, overdose o sospensione improvvisa di farmaci psicotropi e ipnosedativi, epatopatia, avvelenamento da monossido di carbonio), allora, di norma, sono conseguenza di una grave encefalopatia metabolica, ipossica, da prioni o virale. Se si escludono intossicazioni o disturbi metabolici, complessi periodici con elevata affidabilità indicano una diagnosi di panencefalite o malattia da prioni.
Varianti di un elettroencefalogramma normale in un adulto sveglio
L'EEG è sostanzialmente uniforme per l'intero cervello e simmetrico. L'eterogeneità funzionale e morfologica della corteccia determina le caratteristiche dell'attività elettrica delle diverse aree cerebrali. Il cambiamento spaziale dei tipi di EEG nelle singole aree cerebrali avviene gradualmente.
Nella maggior parte (85-90%) degli adulti sani, con gli occhi chiusi a riposo, l'EEG registra un ritmo a dominante con ampiezza massima nelle regioni occipitali.
Nel 10-15% dei soggetti sani, l'ampiezza delle oscillazioni sull'EEG non supera i 25 μV; in tutte le derivazioni viene registrata un'attività ad alta frequenza e bassa ampiezza. Tali EEG sono chiamati a bassa ampiezza. Gli EEG a bassa ampiezza indicano la prevalenza di influenze desincronizzazione nel cervello e rappresentano una variante normale.
In alcuni soggetti sani, al posto del ritmo alfa, nelle aree occipitali viene registrata un'attività di 14-18 Hz con un'ampiezza di circa 50 μV e, come nel normale ritmo alfa, l'ampiezza diminuisce in direzione anteriore. Questa attività è chiamata "variante alfa veloce".
Molto raramente (0,2% dei casi) all'EEG ad occhi chiusi nelle aree occipitali si registrano onde lente regolari, prossime a sinusoidali, con una frequenza di 2,5-6 Hz e un'ampiezza di 50-80 μV. Questo ritmo presenta tutte le altre caratteristiche topografiche e fisiologiche del ritmo alfa ed è chiamato "variante alfa lenta". Non essendo associato ad alcuna patologia organica, è considerato al limite tra la norma e la patologia e può indicare una disfunzione dei sistemi diencefalici aspecifici del cervello.
Cambiamenti nell'elettroencefalogramma durante il ciclo sonno-veglia
- La veglia attiva (durante lo stress mentale, il monitoraggio visivo, l'apprendimento e altre situazioni che richiedono una maggiore attività mentale) è caratterizzata dalla desincronizzazione dell'attività neuronale; sull'EEG predomina l'attività ad alta frequenza e bassa ampiezza.
- La veglia rilassata è lo stato in cui il soggetto riposa su una sedia comoda o a letto, con i muscoli rilassati e gli occhi chiusi, senza essere impegnato in alcuna particolare attività fisica o mentale. Nella maggior parte degli adulti sani, in questo stato viene registrato un ritmo alfa regolare sull'EEG.
- La prima fase del sonno è equivalente alla sonnolenza. L'EEG mostra la scomparsa del ritmo alfa e la comparsa di oscillazioni delta e theta singole e di gruppo a bassa ampiezza e di attività ad alta frequenza a bassa ampiezza. Gli stimoli esterni causano raffiche del ritmo alfa. La fase dura 1-7 minuti. Al termine di questa fase, compaiono oscillazioni lente con un'ampiezza <75 μV. Allo stesso tempo, possono comparire "potenziali transitori di vertice acuti" sotto forma di onde acuminate monofasiche superficialmente negative, singole o di gruppo, con un massimo nell'area della corona, con un'ampiezza solitamente non superiore a 200 μV; sono considerati un fenomeno fisiologico normale. La prima fase è anche caratterizzata da movimenti oculari lenti.
- La seconda fase del sonno è caratterizzata dalla comparsa di fusi del sonno e complessi K. I fusi del sonno sono impulsi di attività con una frequenza di 11-15 Hz, predominanti nelle derivazioni centrali. La durata dei fusi è di 0,5-3 s, l'ampiezza è di circa 50 μV. Sono associati a meccanismi sottocorticali mediani. Il complesso K è un'onda di attività, tipicamente costituita da un'onda bifasica di elevata ampiezza con una fase iniziale negativa, talvolta accompagnata da un fuso. La sua ampiezza è massima nell'area della corona cerebrale, e la durata non è inferiore a 0,5 s. I complessi K si verificano spontaneamente o in risposta a stimoli sensoriali. In questa fase, si osservano episodicamente anche impulsi di onde lente polifasiche di elevata ampiezza. Sono assenti movimenti oculari lenti.
- Fase 3 del sonno: i fusi scompaiono gradualmente e onde delta e theta con ampiezza superiore a 75 μV compaiono in quantità dal 20 al 50% del periodo di analisi. In questa fase, è spesso difficile distinguere i complessi K dalle onde delta. I fusi del sonno possono scomparire completamente.
- Lo stadio IV del sonno è caratterizzato da onde con una frequenza <2 Hz e superiore a 75 μV, che occupano più del 50% del tempo dell'epoca di analisi.
- Durante il sonno, una persona sperimenta occasionalmente periodi di desincronizzazione sull'EEG, il cosiddetto sonno con movimenti oculari rapidi (REM). Durante questi periodi, viene registrata un'attività polimorfica con una predominanza di alte frequenze. Questi periodi sull'EEG corrispondono all'esperienza del sogno, a un calo del tono muscolare con la comparsa di rapidi movimenti dei bulbi oculari e, a volte, rapidi movimenti degli arti. Il verificarsi di questa fase del sonno è associato al funzionamento del meccanismo di regolazione a livello del ponte; la sua interruzione indica una disfunzione di queste aree del cervello, il che è di grande importanza diagnostica.
 [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ]
[ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ]
Cambiamenti legati all'età nell'elettroencefalogramma
L'EEG di un neonato prematuro fino a 24-27 settimane di gestazione è rappresentato da raffiche di lenta attività delta e theta, episodicamente combinate con onde acute, della durata di 2-20 s, sullo sfondo di un'attività di bassa ampiezza (fino a 20-25 μV).
Nei bambini di 28-32 settimane di gestazione, l'attività delta e theta con un'ampiezza fino a 100-150 μV diventa più regolare, sebbene possa includere anche raffiche di attività theta di ampiezza maggiore intervallate da periodi di appiattimento.
Nei bambini di età gestazionale superiore alle 32 settimane, gli stati funzionali iniziano a essere tracciati sull'EEG. Durante il sonno tranquillo, si osserva un'attività delta intermittente ad alta ampiezza (fino a 200 μV e oltre), combinata con oscillazioni theta e onde acute, alternata a periodi di attività di ampiezza relativamente bassa.
In un neonato a termine, l'EEG distingue chiaramente tra veglia con occhi aperti (attività irregolare con una frequenza di 4-5 Hz e un'ampiezza di 50 μV), sonno attivo (attività costante a bassa ampiezza di 4-7 Hz con oscillazioni a bassa ampiezza più veloci sovrapposte) e sonno tranquillo, caratterizzato da raffiche di attività delta ad alta ampiezza in combinazione con fusi di onde ad alta ampiezza più veloci intervallate da periodi a bassa ampiezza.
Nei neonati prematuri e a termine sani, si osserva un'attività alternata durante il sonno tranquillo durante il primo mese di vita. L'EEG dei neonati contiene potenziali acuti fisiologici caratterizzati da multifocalità, comparsa sporadica e irregolarità. La loro ampiezza di solito non supera i 100-110 μV, la frequenza di comparsa è in media di 5 all'ora e il loro numero principale è limitato al sonno tranquillo. Sono considerati normali anche potenziali acuti relativamente regolari nelle derivazioni frontali, con ampiezza non superiore a 150 μV. L'EEG normale di un neonato maturo è caratterizzato dalla presenza di una risposta sotto forma di appiattimento dell'EEG agli stimoli esterni.
Durante il primo mese di vita di un bambino maturo, l'EEG alternato del sonno tranquillo scompare; nel secondo mese compaiono i fusi del sonno, un'attività dominante organizzata nelle derivazioni occipitali, che raggiunge una frequenza di 4-7 Hz all'età di 3 mesi.
Durante il 4°-6° mese di vita, il numero di onde theta sull'EEG aumenta gradualmente e le onde delta diminuiscono, cosicché entro la fine del 6° mese, l'EEG è dominato da un ritmo con una frequenza di 5-7 Hz. Dal 7° al 12° mese di vita, si forma il ritmo alfa con una graduale diminuzione del numero di onde theta e delta. Entro i 12 mesi, dominano le oscillazioni che possono essere caratterizzate come un ritmo alfa lento (7-8,5 Hz). Da 1 anno a 7-8 anni, continua il processo di graduale sostituzione dei ritmi lenti con oscillazioni più veloci (intervallo alfa e beta). Dopo 8 anni, il ritmo alfa domina sull'EEG. La formazione definitiva dell'EEG avviene entro i 16-18 anni.
Valori limite della frequenza del ritmo dominante nei bambini
Età, anni |
Frequenza, Hz |
1 |
>5 |
3 |
>6 |
5 |
>7 |
8 |
>8 |
L'EEG dei bambini sani può contenere onde lente diffuse eccessive, raffiche di oscillazioni lente ritmiche e scariche di attività epilettiforme, cosicché dal punto di vista della valutazione tradizionale delle norme di età, anche in individui ovviamente sani di età inferiore ai 21 anni, solo il 70-80% dell'EEG può essere classificato come "normale".
Dai 3-4 ai 12 anni la percentuale di EEG con onde lente eccessive aumenta (dal 3 al 16%), per poi diminuire piuttosto rapidamente.
La risposta all'iperventilazione sotto forma di onde lente ad alta ampiezza all'età di 9-11 anni è più pronunciata rispetto al gruppo più giovane. È possibile, tuttavia, che ciò sia dovuto alla minore precisione nell'esecuzione del test da parte dei bambini più piccoli.
Rappresentazione di alcune varianti EEG nella popolazione sana in base all'età
Tipo di attività |
1-15 anni |
16-21 anni |
Attività diffusa lenta con un'ampiezza superiore a 50 μV, registrata per oltre il 30% del tempo di registrazione |
14% |
5% |
Attività ritmica lenta nelle derivazioni posteriori |
25% |
0,5% |
Attività epilettiforme, raffiche di onde lente ritmiche |
15% |
5% |
Varianti EEG "normali" |
68% |
77% |
La già menzionata relativa stabilità delle caratteristiche EEG di un adulto si mantiene fino a circa 50 anni di età. Da questo periodo in poi, si osserva una ristrutturazione dello spettro EEG, espressa in una diminuzione dell'ampiezza e della quantità relativa del ritmo alfa e in un aumento della quantità di onde beta e delta. La frequenza dominante dopo i 60-70 anni tende a diminuire. A questa età, le onde theta e delta, visibili all'analisi visiva, compaiono anche in individui praticamente sani.

