Esperto medico dell'articolo
Nuove pubblicazioni
Osteocondropatie delle ossa
Last reviewed: 07.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.
Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.
Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.
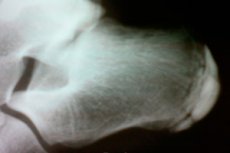
Le osteocondropatie sono un gruppo di malattie del sistema osseo e articolare. Sono caratterizzate da infarto subcondrale asettico dell'area marginale del tessuto osseo spugnoso nelle aree sottoposte a carico aumentato.
I principali tipi di processi degenerativi-distrofici nelle ossa:
- Le estremità epifisarie delle ossa tubulari sono la testa del femore, la testa del secondo e del terzo osso metatarsale e l'estremità sternale della clavicola.
- Ossa spugnose: rotula, osso navicolare del piede e della mano, osso semilunare della mano, corpo delle vertebre, osso sesamoide della prima articolazione metatarsofalangea.
- Apofisi delle ossa: tuberosità tibiale, tuberosità calcaneare, apofisi vertebrali, osso pubico.
- Danni parziali alle superfici articolari: testa del femore, estremità distale del femore, articolazioni del gomito e della caviglia, testa dell'omero, radio, ulna.
La necrosi ossea asettica può essere primaria e secondaria:
- Primaria: si sviluppa durante l'infanzia, associata all'azione di fattori vascolari, legati all'età e al sistema endocrino. La rapida crescita scheletrica nei bambini e le caratteristiche costituzionali del sistema scheletrico hanno un impatto significativo sullo sviluppo della malattia.
- Secondaria (sintomatica) – è una complicazione della malattia di base. Si sviluppa in concomitanza con ischemia del tessuto osseo, vasculite, disturbi degenerativi e metabolici, disturbi neurotrofici ed endocrini e altri processi patologici.
Nella maggior parte dei casi, la malattia presenta un carattere monoarticolare della lesione. Più spesso, è localizzata nella testa del femore, nell'osso navicolare del piede e nelle ossa metatarsali. Raramente, si riscontrano lesioni multiple delle epifisi delle falangi degli arti superiori, lesioni bilaterali della tuberosità della tibia e della tuberosità del calcagno.
Le osteocondropatie ossee sono caratterizzate da una marcata sensazione di dolore nella sede della lesione, che aumenta con il carico e diminuisce a riposo. Si osserva un gonfiore doloroso localizzato dovuto alla sinovite reattiva, che si verifica quando la parte interessata dell'osso subisce una lesione. È possibile anche un lieve peggioramento del benessere generale.
Il processo patologico è caratterizzato da un decorso lungo con graduale scomparsa dei segni clinici e diagnostici. Per stabilire la diagnosi si utilizzano una serie di esami di laboratorio e strumentali. Il trattamento consiste in un ciclo di terapia farmacologica, fisioterapia e attività fisica limitata. Nei casi particolarmente gravi, si ricorre all'intervento chirurgico.
Osteocondropatia del piede
Il processo degenerativo-distrofico nelle ossa del piede è associato alla necrosi dell'osso spugnoso, che è soggetto al massimo carico meccanico. La malattia è inoltre caratterizzata da danni alle apofisi delle ossa tubulari. Viene diagnosticata più spesso nei bambini e negli adolescenti; gli adulti si ammalano estremamente raramente.
Nella maggior parte dei casi, la patologia ha un decorso benigno, senza compromettere la funzionalità delle articolazioni. L'autoguarigione è tipica della malattia. In questo caso, la presenza di necrosi asettica può essere valutata solo mediante radiografia e la presenza di artrosi deformante.
Il meccanismo della malattia non è completamente compreso. Il più delle volte, è associata a disturbi vascolari locali che insorgono a causa dell'azione di vari fattori: traumi, infezioni, patologie congenite e metaboliche.
L'osteocondropatia del piede si presenta in diverse forme:
- Lesione dello scafoide (malattia di Kohler di tipo I) - si sviluppa più spesso nei ragazzi di età compresa tra 3 e 10 anni. Sono possibili sia processi monolaterali che bilaterali. La necrosi dello scafoide negli adulti è la sindrome di Müller-Weiss.
- Necrosi asettica delle teste metatarsali (malattia di Kohler II): questa forma della malattia si verifica in meno dell'1% dei casi di lesioni al piede. Viene diagnosticata più spesso in pazienti di sesso femminile di età compresa tra 10 e 20 anni. In caso di necrosi multipla, si osservano deformazioni statiche del piede: piede piatto-valgo e valgo, piede piatto trasversale e longitudinale, sviluppo displastico.
- Distruzione dell'osso sesamoide della prima articolazione metatarso-falangea (malattia di Renander-Muller) - si verifica nelle donne di età compresa tra 15 e 30 anni, manifestandosi con dolore acuto sotto la testa del primo metatarso, che si intensifica durante l'estensione del dito e la deambulazione. I segni radiografici indicano un'alterazione della struttura dell'osso interessato, con la sua frammentazione.
- Lesione tuberosa del quinto osso metatarsale: si sviluppa a causa di un disturbo dell'ossificazione, da punti di ossificazione aggiuntivi. La radiografia mostra una frattura tuberosa non consolidata, un'apofisi persistente o un ulteriore osso Vesalio. La malattia viene diagnosticata in età infantile con un aumento del carico sul piede. I pazienti presentano un'andatura zoppicante con un aumento del carico sulla parte interna del piede.
- Osteocondrosi dissecante dell'astragalo - si verifica più spesso a causa di traumi all'articolazione della caviglia. Il processo patologico si verifica nell'area del blocco astragalico e si manifesta con un'infiammazione asettica. Alla radiografia, si osserva un focolaio di distruzione con contorni smerlati, delimitato dal tessuto sano da una zona di sclerosi.
- Necrosi asettica della tuberosità calcaneare (malattia di Gaglund-Schinz): dolore al carico e alla palpazione del calcagno si manifesta in pazienti di età compresa tra 7 e 14 anni. Il disturbo si manifesta con periostite o borsite, con possibile atrofia dei muscoli del polpaccio. La radiografia mostra danni all'apofisi del calcagno e allentamento della corticale sotto l'apofisi.
Tutte le osteocondropatie sopra descritte attraversano diverse fasi di sviluppo. Il trattamento dipende dallo stadio della malattia, dalla presenza di complicanze e dalle caratteristiche fisiche del paziente. Nella maggior parte dei casi si ricorre a una terapia conservativa, ma nei casi particolarmente gravi è possibile ricorrere all'intervento chirurgico.
Osteocondropatia del calcagno
Questa forma di malattia degenerativo-necrotica è diagnosticata più spesso nei bambini che negli adulti. Il gruppo a rischio comprende le bambine di età compresa tra 7 e 9 anni e i bambini di età compresa tra 9 e 11 anni. L'osteocondropatia del calcagno è tipica degli atleti professionisti e delle persone che praticano regolarmente un'intensa attività fisica.
La malattia di Schinz, o necrosi asettica del calcagno, si sviluppa a causa di un'alterazione della nutrizione del tessuto osseo. Le principali cause del disturbo includono:
- Disturbi endocrini e metabolici.
- Scarso assorbimento del calcio.
- Lesioni e aumento dell'attività fisica.
I sintomi della malattia dipendono dallo stadio e dalla presenza di complicanze. In alcuni casi, la malattia progredisce lentamente per un lungo periodo di tempo, mentre in altri causa dolore acuto. L'alterazione della nutrizione del tessuto osseo si manifesta con gonfiore nella zona interessata, difficoltà di flessione ed estensione del piede e dolore alla palpazione. È anche possibile riscontrare un aumento della temperatura corporea locale, zoppia durante la deambulazione e dolore nel punto di inserzione del tendine d'Achille sul calcagno.
La diagnosi include radiografia, TC e risonanza magnetica. La radiografia mostra anomalie nei modelli strutturali dell'apofisi e frammentazione, con distanze distorte tra l'osso del tallone e l'apofisi. Nella gamba malata, l'irregolarità dei contorni è più pronunciata rispetto a quella sana. La diagnosi differenziale è obbligatoria. La patologia viene confrontata con alterazioni ossee che presentano una sintomatologia simile.
Il trattamento consiste in un ciclo di terapia farmacologica. Ai pazienti vengono prescritti condroprotettori, preparati a base di calcio e analgesici. Sono indicate procedure fisioterapiche per alleviare il dolore e stimolare i processi rigenerativi. È inoltre necessario ridurre al minimo il carico sull'arto interessato e scegliere le calzature più adatte.
Osteocondropatia della tuberosità calcaneare
La distruzione e il lento ripristino del tessuto osseo spugnoso della tuberosità calcaneare si verificano prevalentemente in pazienti di sesso femminile di età compresa tra 12 e 15 anni. La malattia può presentare una lesione monolaterale o bilaterale.
Cause del processo degenerativo delle ossa:
- Microtraumi.
- Aumento dell'attività fisica.
- Fattori endocrini, vascolari e neutrofici.
I sintomi principali includono: forte dolore durante la deambulazione, gonfiore dei tessuti interessati, alterazione della struttura e atrofia muscolare. La diagnosi si avvale di una serie di metodi di laboratorio e strumentali. Viene inoltre effettuata la diagnosi differenziale con tubercolosi ossea, tumori maligni, borsiti, periostiti, osteomieliti e lesioni infiammatorie.
Il trattamento inizia con metodi conservativi. Sono indicati l'immobilizzazione dell'arto interessato, la terapia del dolore, la fisioterapia e l'assunzione di complessi multivitaminici. Se i metodi sopra descritti non producono il risultato terapeutico desiderato, è indicato l'intervento chirurgico. Particolare attenzione viene prestata alle misure preventive volte a prevenire le ricadute della malattia.
Osteocondropatia delle ossa metatarsali
Le ossa metatarsali sono cinque ossa tubulari corte che fanno parte del piede. Sono soggette a processi degenerativi-distrofici. La malattia di Alban-Kohler II, o necrosi asettica delle ossa metatarsali, è più comune nelle giovani donne. La causa principale dello sviluppo della patologia è l'uso frequente e prolungato di scarpe con tacchi alti.
La condizione dolorosa progredisce gradualmente, causando un dolore acuto durante la deambulazione. Cambiare scarpe e ridurre il carico sui piedi allevia il fastidio, ma la necrosi ossea continua, evolvendo in artrosi deformante. Le radiografie rivelano una testa metatarsale compattata e la sua frammentazione.
Il trattamento è conservativo nella maggior parte dei casi. I pazienti sono invitati a ridurre il carico sulla gamba, sottoporsi a fisioterapia e indossare plantari. Nei casi particolarmente gravi, viene eseguita la resezione dell'osso metatarsale per rimuovere le estese escrescenze ossee.
Osteocondropatia della testa metatarsale
La lesione asettica della testa metatarsale viene diagnosticata più spesso nelle pazienti di sesso femminile di età compresa tra 12 e 18 anni. Nel 10% dei casi, la necrosi interessa diverse ossa metatarsali, mentre meno frequentemente si verificano lesioni bilaterali.
La causa principale della malattia è una compromissione della nutrizione ossea. Ciò si verifica a causa di lesioni, scarpe strette o inadatte, sovraccarico degli arti inferiori e piedi piatti (in posizione trasversale o longitudinale). La distruzione dei tessuti avviene gradualmente, quindi i sintomi si manifestano in modo graduale. I segni del disturbo includono:
- Sensazioni dolorose quando si carica il peso sul piede.
- Zoppia.
- Impossibilità di camminare a piedi nudi, con scarpe morbide e su terreni irregolari.
- Sul dorso del piede, a livello della lesione, è presente una piccola tumefazione che si estende prossimalmente lungo l'osso metatarsale.
- La palpazione della testa è dolorosa.
- Accorciamento del dito adiacente alla testa.
- Deformazione dell'articolazione metatarsofalangea e limitazione del movimento della stessa.
Per la diagnosi si utilizzano radiografie, tomografia computerizzata e risonanza magnetica. Sono indicati anche esami di laboratorio e metodi differenziali.
Segni radiologici della malattia:
- Il primo stadio si manifesta con una leggera compattazione della struttura del tessuto osseo della zona interessata.
- Nella seconda fase si verifica un ispessimento della superficie articolare della testa dell'osso metatarsale e un aumento della densità del suo tessuto osseo.
- La terza fase è caratterizzata dalla frammentazione, cioè dal riassorbimento del tessuto osseo necrotico.
- La quarta fase è il ripristino della struttura dell'osso deformato e la scomparsa dei segni di frammentazione.
Nella diagnosi differenziale, la malattia viene confrontata con le complicazioni di una frattura della testa del metatarso, con processi infiammatori e con la malattia di Deichlander (frattura di marzo).
Nella prima e seconda fase, è indicata l'immobilizzazione dell'arto interessato. Nelle fasi successive, è necessario indossare un plantare ortopedico con la disposizione degli archi trasversali e longitudinali del piede. È inoltre necessario escludere completamente qualsiasi sovraccarico del piede. Vengono eseguite procedure fisioterapiche per ridurre la sensazione dolorosa e stimolare i processi rigenerativi.
Se la terapia conservativa non dà i risultati attesi, si procede con l'intervento chirurgico. L'intervento chirurgico mira a rimuovere le escrescenze ossee che aumentano il dolore e interferiscono con la normale calzata. È anche possibile ripristinare la mobilità articolare. La prognosi è favorevole nella maggior parte dei casi. Le forme avanzate della malattia si evolvono in artrosi deformante con disfunzione dell'avampiede.
Osteocondropatia dell'osso scafoide
La malattia di Köhler I è raramente diagnosticata e solitamente in seguito a traumi. I ragazzi dai 3 ai 10 anni in su spesso presentano questa patologia. È possibile la necrosi asettica dell'osso scafoide sia monolaterale che bilaterale. Se la patologia viene diagnosticata negli adulti, si tratta di una forma nosologica indipendente di osteocondropatia ed è chiamata sindrome di Müller-Weiss.
Nei bambini, la malattia si manifesta quando il processo di ossificazione dell'osso navicolare viene interrotto. Alla radiografia, ciò si manifesta con i seguenti segni:
- Aumento della densità dell'osso interessato.
- Appiattimento del nucleo di ossificazione.
- Frammentazione dell'osso scafoide in direzione sagittale.
- Dilatazione dello spazio interosseo.
Sul dorso del piede, lungo il bordo interno, compaiono gonfiore e dolore. Per questo motivo, il paziente zoppica, camminando con l'arto interessato. La malattia può presentarsi in concomitanza con piedi piatti, deformità del piede e delle dita. Nella diagnosi differenziale, si considera la possibilità di una frattura, di un processo infiammatorio o di una lesione tubercolare isolata.
Il trattamento è conservativo. È necessario immobilizzare l'arto interessato con un gesso. Sono obbligatorie procedure fisioterapiche che migliorano l'afflusso di sangue ai tessuti interessati, alleviano il dolore e favoriscono la guarigione. Non viene eseguito alcun intervento chirurgico. Il ripristino completo della struttura ossea richiede 1,5-2 anni.
Osteocondropatia dell'astragalo
L'astragalo, o osso calcaneare, è una delle ossa che formano la parte inferiore della caviglia. È ricoperto per il 60% da cartilagine articolare ed è responsabile del trasferimento del peso corporeo sulla superficie del piede. L'osso è costituito da diverse parti: blocco, testa e processo posteriore.
La necrosi asettica di questa localizzazione è rara e può causare mobilità limitata e disabilità. Gli uomini sono più spesso colpiti da questo problema rispetto alle donne. La fascia d'età principale dei pazienti è quella compresa tra i 20 e i 45 anni.
Cause dei processi degenerativo-distrofici:
- Complicanze della frattura.
- Disturbi circolatori.
- Lesioni alla caviglia.
- Aumento dell'attività fisica.
La malattia è caratterizzata da una lenta progressione. La necrosi attraversa diverse fasi. I sintomi principali includono gonfiore localizzato e dolore durante la deambulazione.
Nel processo diagnostico vengono utilizzati radiografia, TC, risonanza magnetica e una serie di esami di laboratorio. La radiografia mostra chiaramente una lesione a struttura cellulare, delimitata da una zona di sclerosi dell'osso sano. Inoltre, si osserva una protrusione e un assottigliamento della placca motrice al di sopra della lesione. In questo caso, sono possibili sia processi unilaterali che bilaterali.
Il trattamento è conservativo nella maggior parte dei casi. Ai pazienti vengono prescritti farmaci e fisioterapia per migliorare la circolazione sanguigna, ripristinare la densità ossea e stimolare i processi rigenerativi. Se si ricorre tempestivamente all'assistenza medica, la prognosi è favorevole.
Osteocondropatia dell'articolazione dell'anca
La malattia di Legg-Calvé-Perthes rappresenta circa il 2% di tutte le patologie ortopediche. Viene diagnosticata più spesso tra i 4 e i 14 anni. Allo stesso tempo, i pazienti di sesso maschile sono più frequentemente colpiti rispetto alle donne. Il processo patologico può essere bilaterale, ma la localizzazione unilaterale della necrosi è più comune.
Cause di danni all'articolazione dell'anca:
- Mielodisplasia del midollo spinale lombare.
- Infiammazione dell'articolazione dell'anca.
- Lesioni con compressione dei vasi sanguigni e interruzione dell'afflusso di sangue.
- Malattie infettive.
Le fasi iniziali del processo degenerativo sono asintomatiche. Con il progredire della patologia, compaiono dolore alle articolazioni dell'anca e del ginocchio e zoppia. Successivamente, si verificano deformazione della testa del femore e limitazione del movimento nell'articolazione interessata. La deformazione dipende dalle dimensioni della lesione e determina l'esito della patologia.
Per la diagnosi si utilizzano la risonanza magnetica, l'ecografia dell'anca e la radiografia. Il trattamento mira a ripristinare la struttura anatomica dell'osso per prevenire disturbi dell'andatura ed eliminare il dolore. Ai pazienti vengono prescritti farmaci, fisioterapia ed esercizi terapeutici. Il trattamento chirurgico è indicato per le forme gravi della patologia. L'operazione mira a migliorare l'afflusso di sangue all'anca e a eliminare i disturbi dell'articolazione. La durata del trattamento è di 3-4 anni.
Osteocondropatia del femore
La malattia di Perthes è una condizione patologica in cui l'afflusso di sangue alla testa del femore viene interrotto, con conseguente necrosi asettica. Si manifesta nell'infanzia e nell'adolescenza, dai 3 ai 14 anni, ed è una delle osteocondropatie più comuni. I ragazzi sono colpiti più spesso delle ragazze, ma in queste ultime la malattia progredisce con gravi complicazioni.
Cause e fattori dei disturbi della nutrizione del tessuto osseo:
- Disturbi metabolici.
- Impatto di fattori esterni.
- Lesioni e danni.
- Mielodisplasia.
- Malattie infiammatorie e infettive.
- Cambiamenti ormonali nell'adolescenza.
- Interruzione del metabolismo implicato nella formazione del tessuto osseo.
- Predisposizione genetica.
- Anomalie della struttura dell'articolazione dell'anca.
La necrosi asettica del femore attraversa cinque fasi principali di sviluppo:
- Interruzione dell'afflusso sanguigno e formazione di un focolaio necrotico.
- Frattura da impronta nella zona distrutta.
- Riassorbimento del tessuto necrotico, accorciamento del collo femorale.
- Proliferazione del tessuto connettivo nella lesione.
- Sostituzione del tessuto connettivo con nuovo osso, guarigione della frattura.
Nelle fasi iniziali, si avverte un leggero dolore durante la deambulazione, localizzato nell'articolazione dell'anca. Il fastidio può irradiarsi all'articolazione del ginocchio o interessare l'intera gamba. Il paziente inizia a zoppicare, trascinando l'arto interessato. L'ulteriore distruzione della testa e la sua frattura da impronta provocano dolore acuto e grave zoppia. In questo contesto, la mobilità è limitata, il paziente non riesce a ruotare la gamba verso l'esterno, i movimenti di flessione ed estensione dell'articolazione dell'anca sono limitati. Si osservano anche disturbi vegetativi nelle sezioni distali: piedi pallidi e freddi, aumento della sudorazione.
Per la diagnosi si utilizzano radiografie, risonanze magnetiche e TC. Il trattamento dipende dallo stadio della malattia, dalle sue complicanze e dai sintomi. Nella maggior parte dei casi, la terapia è conservativa. Sono indicati lo scarico completo dell'arto e l'assunzione di farmaci per migliorare la circolazione sanguigna e stimolare la crescita del tessuto osseo. Le procedure fisioterapiche che mantengono il tono muscolare e accelerano il processo di rigenerazione non sono meno efficaci.
Osteocondropatia della testa femorale
Questa è una delle forme più comuni di malattia ossea degenerativo-distrofica. Si manifesta in pazienti di età compresa tra 5 e 12 anni. Il più delle volte, il danno è monolaterale, ma è possibile anche un processo patologico bilaterale. Le cause principali includono disturbi circolatori, lesioni, malattie pregresse e predisposizione genetica.
Nelle fasi iniziali della malattia, i sintomi sono sfumati. Con il progredire della malattia, si manifestano forti dolori durante la deambulazione, atrofia muscolare, zoppia e accorciamento di 1-2 cm dell'arto interessato. I segni diagnostici di necrosi compaiono dopo 6 mesi. La radiografia evidenzia un uniforme oscuramento della testa del femore dovuto alla necrosi e una frattura da impronta.
Il trattamento mira a ripristinare la funzionalità dell'arto interessato. Sono indicati la limitazione della mobilità dell'anca, l'uso di stampelle e dispositivi ortopedici. L'intervento chirurgico viene eseguito raramente ed è mirato a migliorare la circolazione sanguigna nella testa del femore.
Osteocondropatia apofisaria
La malattia di Scheuermann-Mau è una necrosi asettica delle apofisi, ovvero i processi dei corpi vertebrali. Questa forma della malattia viene diagnosticata più spesso nei pazienti durante il periodo di crescita intensiva, ovvero tra gli 11 e i 18 anni. La causa principale della patologia sono difetti congeniti nello sviluppo dei dischi intervertebrali, una compromissione della resistenza delle placche terminali dei corpi vertebrali. I fattori di rischio includono malattie endocrine, sovraccarichi funzionali e lesioni. In altre parole, una compromissione del processo di ossificazione nella zona di crescita dei corpi vertebrali porta alla loro necrosi e deformazione.
I processi degenerativo-distrofici sono tipici delle vertebre toraciche VII, VIII, IX e X. È possibile che colpiscano anche le regioni lombo-toracica e lombare. I sintomi della malattia dipendono dallo stadio.
I principali segni di necrosi:
- Nella prima fase, la sensazione dolorosa è minima. Sono possibili asimmetrie delle scapole, lieve aumento della cifosi toracica e asimmetria paravertebrale. A livello di alterazioni patologiche, i processi spinosi sporgono, la cui palpazione causa dolore. È anche possibile una limitazione dell'inclinazione del corpo.
- Il secondo stadio è caratterizzato dalla comparsa di ossificazione delle apofisi. Si manifesta mal di schiena durante la deambulazione prolungata o la posizione seduta, con aumento dell'affaticamento e debolezza muscolare di gambe e schiena. Aumento della cifosi toracica e deformazione. Si sviluppa una sindrome radicolare con mobilità limitata delle vertebre.
- Il terzo stadio è la fusione delle apofisi con i corpi vertebrali. È caratterizzato da cifosi e deformazione a forma di cuneo dei corpi vertebrali, segni di artrosi spinale con sindrome dolorosa acuta. La cifosi fissa e la lordosi lombare non possono essere corrette.
La diagnosi si basa su una serie di metodi strumentali e differenziali. Il trattamento è conservativo nella maggior parte dei casi. Ai pazienti vengono prescritte procedure di rafforzamento generale, vitamine e un regime di lavoro e riposo delicato. Per sviluppare una postura corretta, è necessario scegliere un materasso rigido ed è anche possibile indossare un corsetto speciale, un correttore posturale.
Nuoto, massaggio alla schiena e fisioterapia hanno un effetto terapeutico. In caso di cifosi grave con complicanze neurologiche, si ricorre all'intervento chirurgico. Se il trattamento viene iniziato tempestivamente, la malattia ha una prognosi favorevole.
Osteocondropatia dell'articolazione del ginocchio
Questo tipo di necrosi asettica viene diagnosticato più spesso nei bambini e negli adolescenti. La causa principale del danno articolare al ginocchio è l'aumento dei carichi meccanici e delle lesioni.
Il processo degenerativo-distrofico comprende diverse patologie della zona del ginocchio, ognuna delle quali presenta sintomi e localizzazione propri:
- La malattia di Koenig è una lesione della superficie del ginocchio e dell'articolazione femoro-rotulea.
- La malattia di Osgood-Schlatter è una necrosi della tuberosità tibiale.
- La malattia di Sinding-Larsen-Johansson è una lesione della rotula superiore/inferiore.
Nelle fasi iniziali, la malattia non si manifesta con sintomi evidenti. La patologia può essere sospettata dalla sindrome dolorosa, che aumenta con lo sforzo fisico sul ginocchio. Allo stesso tempo, il fastidio scompare a riposo. Nelle fasi successive della necrosi, il dolore diventa permanente.
La malattia viene diagnosticata tramite ecografia, risonanza magnetica, scintigrafia, artroscopia e metodi differenziali. Il trattamento può essere effettuato sia con metodi conservativi che chirurgici. Nel primo caso, è indicato ridurre il carico sul ginocchio fissandolo. Durante l'intervento, il corpo cartilagineo viene rimosso con successiva condroplastica.
L'esito della malattia dipende dallo stadio della malattia e dalla presenza di complicanze. Se si ricorre tempestivamente al medico, la prognosi è favorevole. Nelle fasi avanzate, esiste il rischio di sviluppare gonartrosi, zoppia e limitazione del movimento dell'articolazione del ginocchio. Il recupero completo dell'arto interessato richiede circa 1 anno.
Osteocondropatia della rotula
La malattia di Sinding-Larsen-Johansson è una necrosi asettica nella zona della rotula. Questa patologia viene diagnosticata più frequentemente in pazienti di età compresa tra 10 e 15 anni. La malattia è polieziologica. Il processo degenerativo può essere associato alla rottura e al distacco di una porzione di tessuto osseo dalla rotula a causa dell'aumentata funzionalità del muscolo quadricipite.
Sintomi della patologia:
- Aumento del dolore nell'articolazione del ginocchio.
- Gonfiore dei tessuti molli nella zona interessata.
- Atrofia/stiramento del quadricipite.
In alcuni casi l'osteocondropatia della rotula si manifesta sullo sfondo della necrosi della tuberosità tibiale, ovvero nella sindrome di Osgood-Schlatter.
Per la diagnosi vengono utilizzati diversi metodi strumentali. La radiografia mostra danni alla corticale della porzione antero-inferiore della rotula, frammentazione del suo polo inferiore e periostite.
Il trattamento consiste in un complesso di metodi conservativi. Ai pazienti vengono mostrati scarico articolare, fisioterapia e massaggi. Se la patologia non risponde al trattamento conservativo, si procede con un intervento chirurgico con la rimozione dell'osso interessato.
Osteocondropatia della clavicola
La distruzione e il lento ripristino del tessuto osseo spugnoso della clavicola sono estremamente rari. Questa patologia è chiamata sindrome di Friedrich. Viene diagnosticata più spesso in pazienti adolescenti. L'eziologia, nella maggior parte dei casi, è associata a microtraumi.
Segni della malattia:
- Gonfiore doloroso nella zona dell'articolazione sternoclavicolare.
- Dolore che aumenta con lo sforzo fisico.
- La radiografia mostra un ispessimento dell'estremità sternale della clavicola e un'illuminazione focale; il tessuto osseo è frammentato.
Per la diagnosi si utilizzano TC, risonanza magnetica e radiografia. Per la diagnosi differenziale, la malattia viene confrontata con periostite, osteomielite della clavicola e altre patologie. Il trattamento è conservativo. L'ortopedico fissa l'arto superiore sul lato interessato per 7-10 giorni. Sono indicate anche procedure fisioterapiche e l'assunzione di complessi minerali. La prognosi è favorevole.
Osteocondropatia dell'omero
L'omero è una parte dello scheletro dell'arto superiore, situato tra la scapola in alto, l'ulna e il radio in basso. È un lungo osso tubulare e partecipa alla formazione delle articolazioni della spalla e del gomito, garantendone la libertà di movimento. Il processo degenerativo-distrofico consiste nella distruzione della materia ossea con aree di necrosi e la loro sostituzione con tessuto adiposo.
Il danno alla testa omerale è una delle cause di necrosi asettica. Lo sviluppo della malattia può anche essere associato ai seguenti fattori:
- Interruzione dell'afflusso di sangue all'osso.
- Sindrome compartimentale.
- Manipolazioni mediche violente.
- Terapia ormonale a lungo termine con corticosteroidi.
- Trombosi e patologie infiammatorie.
- Stati di immunodeficienza.
- Radioterapia o chemioterapia.
- Stati di decompressione.
La necrosi asettica dell'omero si manifesta con sensazioni dolorose alla palpazione dell'osso e durante l'aumento dell'attività fisica. Con il progredire della necrosi, la mobilità dell'arto interessato è compromessa, i muscoli del cingolo scapolare si atrofizzano e l'osso diventa fragile.
La diagnosi prevede un esame visivo dell'area interessata, radiografie, risonanze magnetiche ed esami di laboratorio. Il trattamento è farmacologico e prevede un ciclo di fisioterapia. L'intervento chirurgico viene eseguito solo nei casi gravi. Con un trattamento tempestivo, la malattia ha una prognosi favorevole.
Osteocondropatia della tibia
Questa patologia è un grave processo degenerativo-distrofico del tessuto osseo dovuto all'interruzione dell'afflusso ematico, alla compromissione della struttura e alla degenerazione grassa del midollo osseo. La malattia è polieziologica, ma sono stati identificati diversi fattori principali che aumentano il rischio di necrosi:
- Trauma e displasia.
- Effetti tossici dei farmaci.
- Osteopenia.
- Osteoporosi.
- Artrite reumatoide.
- Cardiopatia ischemica.
La condizione patologica si manifesta con dolore all'articolazione dell'anca e all'inguine, che può irradiarsi al ginocchio, alla parte bassa della schiena e all'osso sacro. Con il progredire della malattia, il fastidio diventa permanente. Il paziente inizia a zoppicare e l'arto interessato perde la sua mobilità a causa dell'atrofia muscolare.
La diagnosi di necrosi asettica della tibia si basa su radiografia standard, risonanza magnetica, TC e scintigrafia dei tessuti molli. Il trattamento è conservativo: fisioterapia, terapia farmacologica, terapia fisica. L'intervento chirurgico è possibile in caso di gravi alterazioni degenerative.
Osteocondropatia del perone
Il perone è una parte tubolare, sottile e lunga della gamba. Si collega alla tibia ed è costituito da un corpo e due estremità. Funge da stabilizzatore esterno dell'articolazione della caviglia.
La lesione degenerativo-distrofica del perone si verifica spesso sullo sfondo della necrosi delle ossa pelviche e si manifesta con i seguenti sintomi: allargamento dello spazio articolare, diminuzione dell'altezza delle epifisi e morte del tessuto osseo.
La malattia provoca dolore al movimento e alla palpazione della zona interessata. La patologia è caratterizzata da un decorso ciclico. La sua durata totale varia dai 2 ai 4 anni. Il trattamento è complesso: farmaci, fisioterapia, terapia fisica, complessi minerali.
Osteocondropatia della tuberosità tibiale
La malattia di Osgood-Schlatter è una delle forme più comuni di necrosi asettica nei bambini. La lesione della tuberosità tibiale viene diagnosticata in pazienti di età compresa tra 10 e 18 anni che praticano sport. La malattia può essere monolaterale o con lesioni simmetriche a entrambi gli arti.
La causa principale del disturbo sono i frequenti infortuni e l'eccessiva attività fisica. Il processo degenerativo-distrofico si manifesta con i seguenti sintomi:
- Gonfiore della lesione.
- Dolore locale alla palpazione e alla flessione dell'arto.
- Alla palpazione si rileva una crescita ossea dura.
Nelle fasi iniziali, il fastidio è intermittente. Con il progredire della malattia, il dolore diventa persistente e si intensifica camminando e accovacciandosi. A causa del gonfiore, si osserva una moderata deformazione della parte anteroprossimale della tibia. Questa è chiaramente visibile lateralmente quando l'articolazione del ginocchio è piegata. La tuberosità può essere elastica o di struttura ossea densa.
Nella diagnosi, si prendono in considerazione i segni radiografici della patologia. Si osserva un'alterazione della struttura e dei contorni della tuberosità tibiale: aree chiare si alternano a zone scure e prive di struttura, con formazione di una cavità marginale. La diagnosi differenziale si effettua con sublussazione ricorrente della rotula, tumori del tessuto cartilagineo, frattura da avulsione della tuberosità tibiale, osteomielite e borsite infrapatellare.
Il trattamento consiste nel limitare i movimenti di flessione nelle articolazioni del ginocchio dell'arto interessato. Ai pazienti vengono prescritti antidolorifici e farmaci che rinforzano il tessuto osseo e il corpo. La fisioterapia è finalizzata a stimolare i processi rigenerativi. L'intervento chirurgico è estremamente raro, poiché sussiste il rischio di danni alla zona di crescita e di sviluppo di sinostosi. La malattia dura 1-1,5 anni e si conclude con il ripristino della struttura ossea. Nei casi avanzati, è possibile la deformazione della lesione.
Osteocondropatia dell'ischio
Una delle tre parti che formano l'osso pelvico è l'ischio. La necrosi asettica di questa localizzazione è la sindrome di Van Neck. La malattia si manifesta tra i 6 e i 10 anni, più spesso nei maschi che nelle femmine. La patologia si manifesta con dolore all'anca e all'inguine, zoppia riflessa e aumento della temperatura corporea. In alcuni casi, si osserva dolore limitato alla sinfisi.
Per la diagnosi si utilizzano metodi strumentali: radiografia e risonanza magnetica. Le radiografie rivelano un'espansione sferica nella zona dell'osso ischiatico, necrosi mono o bilaterale. Il processo degenerativo si differenzia dalle lesioni tumorali del bacino, dalla tubercolosi ossea e dall'osteomielite. Il trattamento e la prognosi dipendono dalla gravità della malattia.
Osteocondropatia dell'osso sfenoide
La necrosi asettica delle ossa tarsali del piede (a forma di cuneo) è la sindrome di Künscher. L'osso a cuneo viene danneggiato da urti, pressione eccessiva, torsione o flessione del piede. Una delle cause più comuni della malattia è l'uso di scarpe inadeguate, non adatte alla taglia e alla larghezza del piede.
Il processo degenerativo si manifesta con dolore nella zona del piede, che si intensifica durante la deambulazione. Il paziente inizia a zoppicare, cercando di non calpestare l'arto dolorante. Vengono eseguite radiografie per confermare la diagnosi. L'osteocondropatia dello sfenoide viene differenziata dalla sua frattura.
Il trattamento è conservativo nella maggior parte dei casi. L'arto interessato viene immobilizzato con un tutore gessato e vengono prescritti farmaci per migliorare la circolazione sanguigna. Sono inoltre raccomandate procedure fisioterapiche che stimolano i processi di rigenerazione del tessuto osseo.


 [
[