Esperto medico dell'articolo
Nuove pubblicazioni
Allergia all'aspirina
Ultima recensione: 08.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.
Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.
Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

L'acido acetilsalicilico, noto anche come aspirina, è uno di quei farmaci ampiamente e a lungo termine utilizzati per le malattie caratterizzate da infiammazione e sindromi dolorose.
Oggi si sa che l'aspirina provoca asma bronchiale (ne diventa la causa nel 10% dei casi); orticaria (0,3% di probabilità), mentre nell'orticaria cronica nel 23% dei casi si sviluppa una recidiva.
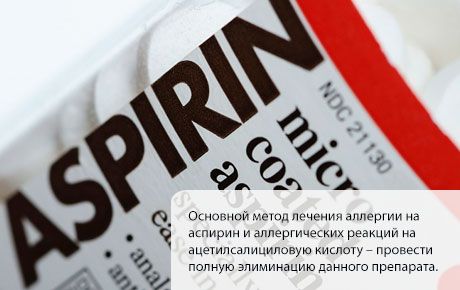
L'allergia all'aspirina si sviluppa anche nei pazienti con: atopia, sesso femminile, se il fenotipo HLA include l'antigene DQw2 e la frequenza dell'antigene HLA DPBI 0401 diminuisce.
Segni di allergia all'aspirina
I seguenti sintomi sono considerati manifestazioni cliniche dell'allergia all'aspirina:
- la presenza di reazioni anafilattoidi, che possono essere causate da farmaci come zomepirac, tolmetina, diclofenac;
- la presenza di rinocongiuntivite e asma bronchiale - nella rinosinusite eosinofila cronica, in presenza o assenza di polipi nasali, e anche in presenza di un'infezione purulenta secondaria; nell'asma, il più delle volte grave e corticosteroide-dipendente. La triade classica è la presenza di rinite accompagnata da polipi nasali, asma bronchiale e ipersensibilità all'aspirina;
- presenza di manifestazioni cutanee: orticaria cronica, angioedema, edema periorbitale isolato, sindrome di Lyell (con fenbrufen, indometacina, piroxicam); porpora (con fenilbutazone, salicilati); fotodermatite (con naprossene, piroxicam, acido tiaprofenico, benoxaprofene);
- la presenza di manifestazioni ematologiche - eosinofilia, citopenia;
- Con manifestazioni respiratorie - polmonite (con febbre, tosse, infiltrati polmonari). Si osservano quando il paziente è affetto da artrite (nelle sue diverse forme) e solitamente quando vengono utilizzati naprossene, sulindac, ibuprofene, azapropazone, indometacina, piroxicam, fenilbutazone, ossifenilbutazone, diclofenac.
Il quadro clinico è descritto da una nuova triade: atopia, sensibilità ai farmaci antinfiammatori non steroidei e sviluppo di anfilassi in caso di esposizione alla polvere domestica (allergene atmosferico).
Sintomi respiratori associati all'allergia all'aspirina:
- presenza di soffocamento;
- presenza di attacchi d'asma;
- presenza di mancanza di respiro;
- respiro sibilante.
- formicolio nei polmoni.
Sintomi dell'apparato digerente associati all'allergia all'aspirina:
- il tratto gastrointestinale non funziona correttamente;
- disturbi allo stomaco periodici o persistenti;
- gli escrementi diventano di colore chiaro;
- la presenza di coliche nella zona dell'ombelico;
- il paziente soffre di bruciore di stomaco;
- secchezza e amarezza in bocca;
- rutti involontari.
- aumentando la soglia del riflesso faringeo;
Sintomi del sistema nervoso in caso di allergia all'aspirina:
- il paziente soffre di mal di testa, tra cui emicrania;
- la pressione sanguigna aumenta;
- la parte posteriore della testa diventa insensibile;
- il paziente si sente stordito;
- la comparsa di fischi nelle orecchie;
- presenza di stanchezza generale;
- apatia;
- la temperatura corporea aumenta;
- il colore della pelle cambia;
- sul corpo del paziente compaiono delle macchie rosse che si desquamano leggermente lungo la circonferenza;
- stadio primario dell'orticaria.
Diagnosi di allergia all'aspirina
Quando gli esperti hanno provato a identificare un'allergia all'aspirina tramite test cutanei, questo metodo si è rivelato inefficace (sono stati colpiti gli anticorpi IgE contro gli antigeni piastrinici, saliciloil e O-metil-saliciloil).
Per diagnosticare qualitativamente l'ipersensibilità all'aspirina, così come ai farmaci antinfiammatori non steroidei, è ideale utilizzare un test di provocazione orale controllato. Per farlo, è necessario:
Se si sospetta un'orticaria da aspirina:
Il primo giorno, assumere un placebo; il secondo giorno, cento, duecento milligrammi di aspirina; il terzo giorno, trecentoventicinque milligrammi, poi seicentocinquanta milligrammi di aspirina. Contemporaneamente, monitorare l'orticaria (controllare ogni due ore per vedere quanti ne sono presenti).
Se si sospetta che un paziente abbia una rinosinusite/asma bronchiale indotta dall'aspirina:
Piano di applicazione: il primo giorno, alle otto del mattino, assumere un placebo, lo stesso alle undici del mattino e alle due del pomeriggio; il secondo giorno, alle otto del mattino, trenta milligrammi di aspirina, sessanta milligrammi alle undici e cento milligrammi alle due del pomeriggio; il terzo giorno, centocinquanta milligrammi di acido acetilsalicilico alle otto del mattino, trecentoventicinque milligrammi alle undici e seicentocinquanta milligrammi alle due del pomeriggio. Anche in caso di ipersensibilità, l'86% dei pazienti ha presentato una riduzione del FEV1 di oltre il 20% (si è osservata la comparsa di broncocostrizione) e/o si sono manifestate reazioni naso-oculari.
Anche il test di provocazione inalatoria è efficace quando si utilizza l'acido lisina-acetilsalicilico. Gli esperti affermano che è facile da eseguire e il vantaggio è che non si verificano reazioni broncocostrittive. La polvere di coniugato di lisina-acido acetilsalicilico è disciolta in acqua in dosi di 11,25 mg, 22,5 mg, 45 mg, 90 mg, 180 mg, 360 mg.
Chi contattare?
Trattamento dell'allergia all'aspirina
Il metodo principale per trattare l'ipersensibilità all'aspirina e le reazioni allergiche all'acido acetilsalicilico è quello di eliminare completamente questo farmaco.
A volte vengono utilizzate misure desensibilizzanti:
- quando il processo infiammatorio delle vie respiratorie non è controllato, nonostante venga effettuata una terapia adeguata (utilizzando corticosteroidi locali e sistemici);
- quando è necessario un trattamento chirurgico ripetuto della sinusite;
- quando il paziente soffre di artrite.
Con una desensibilizzazione efficace all'acido acetilsalicilico si verifica una diminuzione dei derivati del leucotriene solfidopeptide (LTE4).
Nei pazienti con ipersensibilità all'aspirina, esiste un'alta probabilità che si sviluppi broncospasmo se vengono utilizzati farmaci oftalmici topici (uso di cheto-rolac, flurbiprofene, siprofene, diclofenac).
L'allergia all'aspirina è una delle forme più comuni di allergia ai farmaci. La diagnosi e il trattamento dell'allergia all'aspirina non sono particolarmente difficili.


 [
[