Esperto medico dell'articolo
Nuove pubblicazioni
Sistema nervoso autonomo
Ultima recensione: 04.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.
Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.
Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.
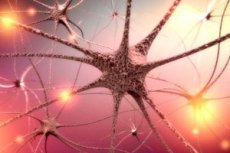
Il sistema nervoso autonomo (systema nervosum autonomicum) è una parte del sistema nervoso che controlla le funzioni degli organi interni, delle ghiandole e dei vasi sanguigni, e ha un effetto adattativo e trofico su tutti gli organi umani. Il sistema nervoso autonomo mantiene la costanza dell'ambiente interno del corpo (omeostasi). La funzione del sistema nervoso autonomo non è controllata dalla coscienza umana, ma è subordinata al midollo spinale, al cervelletto, all'ipotalamo, ai nuclei della base dell'encefalo terminale, al sistema limbico, alla formazione reticolare e alla corteccia cerebrale.
La distinzione tra il sistema nervoso vegetativo (autonomo) e quello vegetativo è determinata da alcune delle sue caratteristiche strutturali. Queste caratteristiche includono quanto segue:
- localizzazione focale dei nuclei vegetativi nel sistema nervoso centrale;
- accumulo di corpi di neuroni effettori sotto forma di nodi (gangli) come parte dei plessi autonomi periferici;
- natura bi-neuronale del percorso nervoso dai nuclei del sistema nervoso centrale all'organo innervato;
- conservazione di caratteristiche che riflettono un'evoluzione più lenta del sistema nervoso autonomo (rispetto al sistema nervoso animale): calibro più piccolo delle fibre nervose, minore velocità di conduzione dell'eccitazione, assenza di guaina mielinica in molti conduttori nervosi.
Il sistema nervoso autonomo è diviso in sezioni centrale e periferica.
Il dipartimento centrale comprende:
- nuclei parasimpatici delle coppie III, VII, IX e X dei nervi cranici situati nel tronco encefalico (mesencefalo, ponte, midollo allungato);
- nuclei sacrali parasimpatici situati nella materia grigia dei tre segmenti sacrali del midollo spinale (SII-SIV);
- nucleo vegetativo (simpatico) situato nella colonna intermedia laterale [sostanza grigia intermedia laterale] dell'VIII segmento cervicale, di tutti i segmenti toracici e dei due segmenti lombari superiori del midollo spinale (CVIII-ThI-LII).
La parte periferica del sistema nervoso autonomo comprende:
- nervi vegetativi (autonomi), rami e fibre nervose che emergono dal cervello e dal midollo spinale;
- plessi viscerali vegetativi (autonomi);
- nodi dei plessi vegetativi (autonomi, viscerali);
- tronco simpatico (destro e sinistro) con i suoi nodi, rami internodali e di collegamento e nervi simpatici;
- nodi della parte parasimpatica del sistema nervoso autonomo;
- fibre vegetative (parasimpatiche e simpatiche) che vanno verso la periferia (agli organi, ai tessuti) dai nodi vegetativi che fanno parte dei plessi e che si trovano nello spessore degli organi interni;
- terminazioni nervose coinvolte nelle reazioni autonome.
I neuroni dei nuclei della parte centrale del sistema nervoso autonomo sono i primi neuroni efferenti sui percorsi che dal SNC (midollo spinale e cervello) vanno all'organo innervato. Le fibre formate dai prolungamenti di questi neuroni sono chiamate fibre nervose pregangliari, poiché si dirigono ai nodi della parte periferica del sistema nervoso autonomo e terminano in sinapsi con le cellule di questi nodi.
I nodi vegetativi fanno parte dei tronchi simpatici, grandi plessi vegetativi della cavità addominale e del bacino, e sono localizzati anche nello spessore o in prossimità degli organi dell'apparato digerente, respiratorio e genitourinario, innervati dal sistema nervoso autonomo.
La dimensione dei nodi vegetativi è determinata dal numero di cellule in essi contenute, che varia da 3000-5000 a diverse migliaia. Ogni nodo è racchiuso da una capsula di tessuto connettivo, le cui fibre, penetrando in profondità nel nodo, lo dividono in lobi (settori). Tra la capsula e il corpo del neurone si trovano cellule satellite, un tipo di cellule gliali.
Le cellule gliali (cellule di Schwann) includono i neurolemmociti, che formano le guaine dei nervi periferici. I neuroni dei gangli autonomi si dividono in due tipi principali: cellule di Dogel di tipo I e di tipo II. Le cellule di Dogel di tipo I sono efferenti e su di esse terminano i processi pregangliari. Queste cellule sono caratterizzate da un assone lungo, sottile e non ramificato e da numerosi dendriti (da 5 a diverse decine) che si ramificano in prossimità del corpo di questo neurone. Queste cellule presentano diversi processi leggermente ramificati, tra cui un assone. Sono più grandi dei neuroni di Dogel di tipo I. I loro assoni entrano in connessione sinaptica con i neuroni efferenti di Dogel di tipo I.
Le fibre pregangliari sono rivestite da una guaina mielinica, motivo per cui sono biancastre. Escono dall'encefalo come parte delle radici dei corrispondenti nervi cranici e spinali. I nodi della parte periferica del sistema nervoso autonomo contengono i corpi dei secondi neuroni efferenti (effettori) che si trovano lungo i percorsi verso gli organi innervati. I processi di questi secondi neuroni, che trasportano l'impulso nervoso dai nodi autonomici agli organi funzionali (muscolatura liscia, ghiandole, vasi, tessuti), sono fibre nervose postganglionari. Non sono rivestite da una guaina mielinica e quindi sono grigie.
La velocità di conduzione dell'impulso lungo le fibre pregangliari simpatiche è di 1,5-4 m/s, mentre quella parasimpatica è di 10-20 m/s. La velocità di conduzione dell'impulso lungo le fibre postganglionari (amieliniche) non supera 1 m/s.
I corpi delle fibre nervose afferenti del sistema nervoso autonomo si trovano nei nodi spinali (intervertebrali), nonché nei nodi sensoriali dei nervi cranici; nei nodi sensoriali propriamente detti del sistema nervoso autonomo (cellule di Dogel di tipo II).
La struttura dell'arco riflesso autonomo differisce dalla struttura dell'arco riflesso della parte somatica del sistema nervoso. L'arco riflesso del sistema nervoso autonomo ha un collegamento efferente costituito da due neuroni anziché uno. In generale, un arco riflesso autonomo semplice è rappresentato da tre neuroni. Il primo collegamento dell'arco riflesso è un neurone sensoriale, il cui corpo si trova nei gangli spinali o nei gangli dei nervi cranici. Il processo periferico di tale neurone, che ha una terminazione sensitiva - un recettore - ha origine in organi e tessuti. Il processo centrale, come parte delle radici posteriori dei nervi spinali o delle radici sensoriali dei nervi cranici, è diretto ai corrispondenti nuclei vegetativi del midollo spinale o dell'encefalo. La via efferente (in uscita) dell'arco riflesso autonomo è rappresentata da due neuroni. Il corpo del primo di questi neuroni, il secondo in un arco riflesso autonomo semplice, si trova nei nuclei vegetativi del sistema nervoso centrale. Questo neurone può essere definito intercalare, poiché si trova tra il collegamento sensoriale (afferente, afferente) dell'arco riflesso e il terzo neurone (efferente, efferente) della via efferente. Il neurone effettore è il terzo neurone dell'arco riflesso autonomo. I corpi dei neuroni effettori si trovano nei nodi periferici del sistema nervoso autonomo (tronco simpatico, nodi autonomici dei nervi cranici, nodi dei plessi autonomici extra- e intraorganici). I prolungamenti di questi neuroni sono diretti a organi e tessuti come parte di nervi autonomici organici o misti. Le fibre nervose postganglionari terminano nella muscolatura liscia, nelle ghiandole, nelle pareti dei vasi sanguigni e in altri tessuti con corrispondenti apparati nervosi terminali.
In base alla topografia dei nuclei e dei nodi autonomi, alle differenze nella lunghezza del primo e del secondo neurone della via efferente e alle caratteristiche delle funzioni, il sistema nervoso autonomo viene suddiviso in due parti: simpatico e parasimpatico.
Fisiologia del sistema nervoso autonomo
Il sistema nervoso autonomo controlla la pressione sanguigna (PA), la frequenza cardiaca (FC), la temperatura corporea e il peso, la digestione, il metabolismo, l'equilibrio idrico ed elettrolitico, la sudorazione, la minzione, la defecazione, la risposta sessuale e altri processi. Molti organi sono controllati principalmente dal sistema simpatico o parasimpatico, sebbene possano ricevere input da entrambe le parti del sistema nervoso autonomo. Più spesso, l'azione del sistema simpatico e parasimpatico sullo stesso organo è direttamente opposta: ad esempio, la stimolazione simpatica aumenta la frequenza cardiaca e la stimolazione parasimpatica la diminuisce.
Il sistema nervoso simpatico promuove l'attività intensa dell'organismo (processi catabolici) e, a livello ormonale, regola la fase "combatti o fuggi" della risposta allo stress. Pertanto, i segnali efferenti simpatici aumentano la frequenza cardiaca e la contrattilità miocardica, causano la broncodilatazione, attivano la glicogenolisi nel fegato e il rilascio di glucosio, aumentano il metabolismo basale e la forza muscolare; e stimolano anche la sudorazione dei palmi delle mani. Funzioni vitali meno importanti in un ambiente stressante (digestione, filtrazione renale) vengono ridotte sotto l'influenza del sistema nervoso autonomo simpatico. Tuttavia, il processo di eiaculazione è completamente sotto il controllo della divisione simpatica del sistema nervoso autonomo.
Il sistema nervoso parasimpatico contribuisce a ripristinare le risorse dell'organismo, ovvero a garantire i processi anabolici. Il sistema nervoso autonomo parasimpatico stimola la secrezione delle ghiandole digestive e la motilità del tratto gastrointestinale (inclusa l'evacuazione), riduce la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna e garantisce l'erezione.
Le funzioni del sistema nervoso autonomo sono fornite da due neurotrasmettitori principali: acetilcolina e noradrenalina. A seconda della natura chimica del mediatore, le fibre nervose che secernono acetilcolina sono chiamate colinergiche; si tratta di fibre parasimpatiche pregangliari e postganglionari. Le fibre che secernono noradrenalina sono chiamate adrenergiche; si tratta della maggior parte delle fibre simpatiche postganglionari, ad eccezione di quelle che innervano i vasi sanguigni, le ghiandole sudoripare e i muscoli erettori del piloro, che sono colinergiche. Le ghiandole sudoripare palmari e plantari rispondono parzialmente alla stimolazione adrenergica. I sottotipi di recettori adrenergici e colinergici si distinguono a seconda della loro localizzazione.
Valutazione del sistema nervoso autonomo
La disfunzione autonomica può essere sospettata in presenza di sintomi quali ipotensione ortostatica, scarsa tolleranza alle alte temperature e perdita del controllo intestinale e vescicale. La disfunzione erettile è uno dei sintomi precoci della disfunzione autonomica. Xeroftalmia e xerostomia non sono sintomi specifici della disfunzione autonomica.
 [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ]
[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ]
Esame fisico
Una diminuzione sostenuta della pressione arteriosa sistolica di oltre 20 mm Hg o diastolica di oltre 10 mm Hg dopo aver assunto la posizione verticale (in assenza di disidratazione) suggerisce la presenza di disfunzione autonomica. È necessario prestare attenzione alle variazioni della frequenza cardiaca (FC) durante la respirazione e quando si cambia posizione del corpo. L'assenza di aritmie respiratorie e un aumento insufficiente della FC dopo aver assunto la posizione verticale indicano una disfunzione autonomica.
La miosi e la ptosi moderata (sindrome di Horner) indicano un danno alla divisione simpatica del sistema nervoso autonomo, mentre una pupilla dilatata che non reagisce alla luce (pupilla di Adie) indica un danno al sistema nervoso autonomo parasimpatico.
Riflessi urogenitali e rettali anomali possono anche essere sintomi di insufficienza del sistema nervoso autonomo. L'esame include la valutazione del riflesso cremasterico (normalmente, strofinando la pelle della coscia si provoca l'elevazione dei testicoli), del riflesso anale (normalmente, strofinando la pelle perianale si provoca la contrazione dello sfintere anale) e del riflesso bulbocavernoso (normalmente, la compressione del glande o del clitoride si provoca la contrazione dello sfintere anale).
Ricerca di laboratorio
In presenza di sintomi di disfunzione autonomica, al fine di determinare la gravità del processo patologico e una valutazione quantitativa oggettiva della regolazione autonomica del sistema cardiovascolare, vengono eseguiti un test cardiovagale, test di sensibilità dei recettori α-drenergici periferici e una valutazione quantitativa della sudorazione.
Il test quantitativo del riflesso assonale sudomotorio viene utilizzato per verificare la funzionalità dei neuroni postganglionari. La sudorazione locale viene stimolata mediante ionoforesi con acetilcolina, gli elettrodi vengono posizionati su tibie e polsi e l'intensità della sudorazione viene registrata da uno speciale sudometro che trasmette le informazioni in forma analogica a un computer. Il risultato del test può essere una diminuzione della sudorazione, la sua assenza o la sudorazione continua dopo l'interruzione della stimolazione. Il test termoregolatorio viene utilizzato per valutare le condizioni delle vie di conduzione pregangliari e postganglionari. I test con colorante sono utilizzati molto meno frequentemente per valutare la funzionalità della sudorazione. Dopo l'applicazione del colorante sulla pelle, il paziente viene posto in una stanza chiusa che viene riscaldata fino al raggiungimento della massima sudorazione; la sudorazione porta a un cambiamento del colore del colorante, che rivela aree di anidrosi e ipoidrosi e consente la loro analisi quantitativa. L'assenza di sudorazione indica un danno alla parte efferente dell'arco riflesso.
I test cardiovagali valutano la risposta della frequenza cardiaca (registrazione e analisi ECG) alla respirazione profonda e alla manovra di Valsalva. Se il sistema nervoso autonomo è integro, il massimo aumento della frequenza cardiaca si osserva dopo il 15° battito cardiaco e una diminuzione dopo il 30°. Il rapporto tra gli intervalli RR al 15° e al 30° battito (ovvero l'intervallo più lungo e quello più breve) - il rapporto 30:15 - è normalmente pari a 1,4 (rapporto di Valsalva).
I test di sensibilità adrenergica periferica includono la misurazione della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa nel tilt test (test ortostatico passivo) e nel test di Valsalva. Durante il test ortostatico passivo, il volume ematico viene ridistribuito tra le parti del corpo sottostanti, causando risposte emodinamiche riflesse. Il test di Valsalva valuta le variazioni della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca a seguito di un aumento della pressione intratoracica (e di un ridotto afflusso venoso), causando alterazioni caratteristiche della pressione arteriosa e vasocostrizione riflessa. Normalmente, le variazioni dei parametri emodinamici si verificano nell'arco di 1,5-2 minuti e presentano 4 fasi, durante le quali la pressione arteriosa aumenta (fasi 1 e 4) o diminuisce dopo un rapido recupero (fasi 2 e 3). La frequenza cardiaca aumenta nei primi 10 secondi. Se il sistema simpatico è interessato, nella seconda fase si verifica un blocco della risposta.

