Esperto medico dell'articolo
Nuove pubblicazioni
Oneiroid
Ultima recensione: 04.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.
Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.
Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.
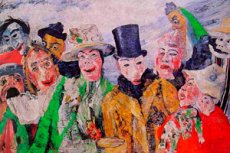
Il vero oneiroide è un disturbo mentale, una forma di alterazione della coscienza, il più delle volte di origine endogena-organica. È caratterizzato da sintomi produttivi pronunciati sotto forma di un afflusso di immagini vivide simili a scene, sensazioni, spesso di contenuto insolito, simili a sogni fantastici, solitamente collegate da un'unica trama, che si svolgono nello spazio mentale soggettivo del paziente. E se nel suo mondo fantastico-illusorio egli è un partecipante attivo a ciò che sta accadendo, allora in realtà il suo comportamento è dissonante con il contenuto delle pseudo-allucinazioni sperimentate. La stragrande maggioranza dei pazienti è spettatore passivo delle visioni, distaccato dagli eventi circostanti. Il paziente con oneiroide sviluppato è completamente disorientato, cioè non è in grado di percepire correttamente né se stesso né l'ambiente circostante. Il contatto con lui in questo momento è impossibile, ma dopo essere uscito dallo stato, il paziente può raccontare in modo abbastanza coerente gli eventi sognati, sebbene ciò che gli è accaduto nella realtà durante questo periodo rimanga al di fuori della sua percezione.
Epidemiologia
Non ci sono statistiche sulla frequenza di comparsa della sindrome oneiroide in varie malattie. Ci sono prove che si verifica più spesso nei pazienti con schizofrenia catatonica parossistica. [ 1 ] Per quanto riguarda l'età, nei bambini si possono osservare manifestazioni frammentarie che si adattano al quadro clinico della sindrome oneiroide. La vera sindrome oneiroide conclamata può essere diagnosticata con sicurezza già nell'adolescenza, principalmente negli stati di stupore. Nella vecchiaia, la sindrome oneiroide si sviluppa raramente.
Le cause oniroide
Il termine oneiroide si riferisce alle sindromi di alterazione della coscienza, si verifica nel quadro clinico di psicosi di varia origine e non indica direttamente la causa nosologica della patologia.
Può essere una manifestazione di malattie mentali endogene, il più delle volte la schizofrenia e, un po' meno frequentemente, il disturbo bipolare. Lo stato onirico è insito nella forma catatonica della schizofrenia; in precedenza, era persino considerato una variante dello stupore. Nella forma paranoica più comune, l'onirico è spesso accompagnato dalla sindrome dell'automatismo mentale (Kandinsky-Clerambault). Un vero e proprio onirico illusorio-fantastico prolungato, che si sviluppa per fasi, si osserva principalmente negli schizofrenici. Spesso è il culmine di un attacco di forma catatonica periodica o a pelo lungo della malattia, dopo il quale si verifica un periodo residuo. [ 2 ]
Fattori di rischio
La sindrome oneiroide potrebbe avere una genesi esogena-organica. I fattori di rischio per la sua insorgenza sono vari. La sindrome oneiroide è una delle tipiche reazioni esogene del cervello (secondo K. Bonhoeffer) a:
- lesioni alla testa;
- avvelenamento accidentale con sostanze tossiche o il loro uso intenzionale;
- patologie del sistema nervoso centrale - epilessia, tumori cerebrali, insufficienza cerebrovascolare;
- collagenosi - forme gravi di lupus eritematoso, sclerodermia, artrite reumatoide;
- cambiamenti nel metabolismo dei neurotrasmettitori in caso di scompenso epatico e renale, insufficienza cardiovascolare, diabete mellito, pellagra, anemia perniciosa, malattie infettive e altre gravi malattie somatiche che portano a un'intossicazione generale dell'organismo.
Patogenesi
La patogenesi dello sviluppo della sindrome oneiroide corrisponde al meccanismo di sviluppo della malattia sottostante. Questo tipo di alterazione della coscienza si riferisce a sintomi psicotici produttivi. I moderni metodi di neuroimaging hanno stabilito che la sua comparsa, in particolare nella schizofrenia, è causata dall'iperattività del sistema dopaminergico mesolimbico. L'aumento del rilascio di dopamina è associato a debolezza dei sistemi glutammatergico e GABAergico; tuttavia, tutti i sistemi neurotrasmettitoriali sono interconnessi e la loro influenza reciproca è ancora in fase di studio. La sindrome oneiroide è una conseguenza dell'interruzione di complessi meccanismi di interazione neurochimica correlati a cambiamenti nella velocità di biosintesi dei neurotrasmettitori, nel loro metabolismo, nella sensibilità e nella struttura dei corrispondenti recettori. Ad oggi, la psicopatologia della sindrome oneiroide non è ancora del tutto compresa, così come la sua patogenesi, e la relazione tra l'offuscamento della coscienza da sindrome oneiroide e altre psicosi non è stata ancora completamente chiarita. Molte questioni rimangono da risolvere in futuro.
Sintomi oniroide
L'oniroidismo è un disturbo qualitativo della coscienza caratterizzato da un afflusso di scene oniriche e immagini visive di contenuto fantastico, intrecciate con la realtà, in cui il paziente si sente al centro degli eventi, osservando scene oniriche che si svolgono davanti a lui, a volte senza prendervi parte attiva, pur sperimentando la propria passività, poiché si sente responsabile di ciò che sta accadendo, e a volte ne è un partecipante attivo e persino il protagonista. L'oggetto delle esperienze è favoloso e irreale: si tratta di sabba delle streghe, viaggi su altri pianeti, in paradiso o all'inferno, in fondo al mare, ecc. Il paziente non sempre si immagina nemmeno come persona, può trasformarsi in un animale, in oggetti inanimati, in una nuvola di gas.
I ricercatori descrivono anche un disturbo onirico con una componente prevalentemente sensoriale del disturbo della coscienza, quando le pseudoallucinazioni visive sono debolmente espresse o addirittura assenti. I pazienti con questo tipo di sindrome presentano disturbi tattili, uditivi e cinestetici che, insieme all'interpretazione delle sensazioni da parte dei pazienti, consentono di classificare l'attacco come onirico. I sintomi cinestetici sono rappresentati da voli nello spazio (i pazienti avvertivano la pressione di una tuta spaziale sul corpo); cadute dalle scale (non viste, ma percepite) negli inferi; la sensazione che l'intero appartamento, con mobili e parenti, si stesse trasferendo su un altro pianeta. I sintomi sensoriali si manifestavano nella sensazione di freddo o caldo di altri pianeti, movimento dell'aria, calore proveniente da fornaci infernali; sintomi uditivi: i pazienti udivano il rombo dei motori di astronavi, il divampare di un fuoco, il parlare degli alieni, il canto degli uccelli del paradiso. Avveniva anche la reincarnazione; i pazienti non la vedevano, ma sentivano come la loro pelle si trasformava in pelliccia o squame, come crescevano artigli, code o ali.
Il disturbo della percezione è di natura pseudo-allucinatoria, il paziente è disorientato nel tempo e nello spazio, così come nella propria personalità. Il contatto verbale con lui è impossibile nella maggior parte dei casi, gli eventi reali rimangono al di fuori della sua zona di percezione, sebbene coloro che lo circondano nella fase di oniroidismo orientato possano essere inclusi nella trama fantastica vissuta. Dopo essere uscito da questo stato, il paziente, di regola, ricorda e può raccontare le sue esperienze oniriche; il ricordo degli eventi reali è amnesico.
Il classico sviluppo graduale della sindrome oniroide si osserva negli schizofrenici, tanto da essere addirittura chiamato delirio schizofrenico. Secondo gli esperti, nella schizofrenia non esiste un vero e proprio delirio. La maggior parte dei casi di sindrome oniroide è caratterizzata dalla passività del paziente, che è spettatore di visioni fantastiche e dinamiche. Esteriormente, il paziente si trova in uno stato di torpore e non mostra espressioni facciali espressive né irrequietezza motoria. Per lungo tempo, l'annebbiamento oniroide della coscienza in psichiatria è stato considerato come malinconia con amnesia e, successivamente, come una variante dello stupore catatonico. Si ritiene che un paziente con sindrome oniroide possa raramente trovarsi in uno stato di agitazione psicomotoria.
La manifestazione principale dell'oniroidismo è lo stato di distacco del paziente, la depersonalizzazione e la derealizzazione marcate, visioni fantastiche simili a sogni, collegate a una trama specifica e che sostituiscono la realtà.
Le fasi di sviluppo del disturbo oneiroide sono state descritte da rappresentanti di diverse scuole psichiatriche e, in linea di principio, non vi sono grandi differenze in queste descrizioni.
I primi segni compaiono nei disturbi emotivi. Questi possono essere instabilità emotiva, dualità o un marcato cambiamento unilaterale nelle reazioni sensoriali, ad esempio uno stato di insoddisfazione o estasi relativamente stabile. Si possono osservare reazioni emotive inadeguate e la cosiddetta "incontinenza affettiva". I cambiamenti patologici nello stato emotivo sono accompagnati da disturbi somatici e vegetativi generali: attacchi di tachicardia, dolori cardiaci o gastrici, sudorazione, perdita di forza, disturbi del sonno, mal di testa e persino disturbi digestivi. Questi sintomi precedono l'oneiroide e possono essere osservati per un periodo molto lungo, per diverse settimane o addirittura mesi. Tuttavia, i disturbi emotivi di per sé non sono ancora oniroidi.
La fase successiva è l'umore delirante, precursore di un disturbo del pensiero, caratterizzato da confusione, premonizione di una minaccia imminente, sensazione di cambiamento in sé stessi e nella realtà circostante. Sullo sfondo di un umore elevato, si possono verificare la premonizione e l'aspettativa di qualcosa di gioioso, desiderabile e piacevole. Tale umore può durare diversi giorni, trasformandosi gradualmente in deliri di messa in scena, falso riconoscimento, trasformazione, reincarnazione. In questa fase, compaiono i primi disturbi del linguaggio, sotto forma di rallentamento o accelerazione del linguaggio e automatismi ideativi mentali. La fase delirante può durare da diversi giorni a diverse settimane. Lo psichiatra bulgaro S. Stoyanov ha definito questa fase depersonalizzazione/derealizzazione affettivo-delirante.
Segue la fase dell'oniroide orientato, in cui avviene ancora un orientamento parziale nella realtà circostante ed è possibile il contatto con il paziente, ma sullo sfondo di un annebbiamento superficiale della coscienza si aggiungono già pseudoallucinazioni fantastiche simili a scene, delirio introspettivo o manicheo (il paziente vede scene del passato o del futuro, diventa testimone della lotta degli angeli con i demoni o di battaglie con creature aliene).
Le fasi dell'oniroidismo possono durare da diverse ore a diversi giorni. Il culmine è un oniroidismo simile a un sogno, in cui il contatto con il paziente diventa impossibile. Il paziente è completamente in balia delle sue esperienze oniriche, il più delle volte caratterizzate da una trama insolita. Nonostante la vividezza degli eventi vissuti (cospirazioni, rivolte, catastrofi universali, guerre interplanetarie), vi è quasi sempre una dissonanza tra il comportamento reale e quello immaginario del paziente. L'agitazione psicomotoria si sviluppa estremamente raramente. Nella maggior parte dei casi, il paziente giace in uno stato di torpore, con un volto congelato e inespressivo, completamente distaccato da ciò che accade al di fuori delle sue esperienze soggettive. Solo nella sua immaginazione partecipa attivamente a eventi fantastici.
Se nella fase dell'oniroide orientato il paziente ha un'attenzione dispersa, ma almeno in qualche modo reagisce agli stimoli esterni, allora nella fase dell'oniroide onirico è impossibile attirare la sua attenzione.
La riduzione dei sintomi avviene in ordine inverso: l'oniroide onirico viene sostituito da uno orientato, quindi rimane solo il delirio, che gradualmente si attenua e il paziente esce dallo stato oniroide. Molti autori hanno segnalato disturbi della memoria, in particolare l'amnesia parziale. Il paziente non ricorda gli eventi reali accaduti durante l'oniroide, mentre il ricordo delle esperienze dolorose viene spesso preservato. Inoltre, l'amnesia nell'oniroide è meno evidente rispetto al delirio.
In base alla natura dell'affetto, si distinguono: oniroide espansivo con deliri di grandezza e fantasie megalomani, caratterizzati da un flusso temporale accelerato; oniroide depressivo con una trama tragica, malinconica e ansiosa di pseudoallucinazioni, con la sensazione di un lento scorrere del tempo, talvolta semplicemente interrotto. Si distingue anche l'oniroide misto, in cui lo stato depressivo è sostituito da uno stato di espansione.
Non è sempre possibile tracciare lo sviluppo fase per fase dell'oneroidismo. Nella sequenza classica, può svilupparsi nel disturbo bipolare e nelle psicosi senili.
La sindrome oneiroide di origine esogena-organica si sviluppa piuttosto rapidamente, di solito nella fase acuta, bypassando la lunga fase prodromica e delirante. Soprattutto in caso di intossicazioni acute e traumi cranici, lo sviluppo della sindrome oneiroide avviene in modo fulmineo, mentre la fase culminante si sviluppa quasi immediatamente, seguendo approssimativamente lo stesso schema della schizofrenia. Dura da poche ore a cinque o sei giorni.
Ad esempio, in caso di lesioni craniche chiuse (contusioni), la sindrome oneiroide si manifesta nei primi giorni successivi al trauma, ed è caratterizzata da un disorientamento assoluto, sia personale che oggettivo, nel comportamento della vittima, con prevalenza di stati euforici o estatici. Il decorso è misto: l'eccitazione caotica con grida individuali e patetiche viene sostituita da brevi periodi di immobilità esterna e mutismo. Manifestazioni tipiche della depersonalizzazione sono l'autometamorfopsia e la derealizzazione, ovvero esperienze di accelerazione o decelerazione del flusso del tempo.
In caso di avvelenamento da alcol, la vittima entra in uno stato di delirio onirico. Questo si manifesta nel fatto che diventa inibita, distaccata, smette di rispondere ai tentativi di stabilire un contatto con lui, cade in uno stato di torpore, che può evolvere in sopore e coma.
La sindrome oneiroide causata dal fumo o dall'inalazione di droghe (cannabinoidi, colla Moment) si manifesta come un decorso atipico di lieve intossicazione da droghe. Si manifesta come uno stato di stordimento, un'immersione in un mondo di fantasie deliranti, spesso di natura amoroso-erotica o retrospettiva (affiorano sensazioni di eventi passati reali che un tempo hanno causato forti esperienze emotive nel paziente). Sono caratteristiche le intense espressioni facciali: l'espressione passa dall'estasi alla completa disperazione, il paziente è perseguitato da pseudoallucinazioni, visive e uditive, di natura spaventosa. Il contatto con il mondo esterno è assente.
Stati oniroidi possono occasionalmente verificarsi in malattie infettive che si manifestano senza una tossicosi pronunciata (malaria, reumatismi, ecc.). Di solito durano diverse ore. Si manifestano sotto forma di un oniroide orientato con un annebbiamento della coscienza relativamente lieve. I pazienti riferiscono il contenuto delle loro esperienze dopo la risoluzione della psicosi. Si manifestano in modo tipico: immagini visive vivide, esperienze sceniche con un tema fiabesco, a cui i pazienti partecipano attivamente o "osservano" dall'esterno. Il comportamento del paziente è caratterizzato da inibizione e parziale distacco dall'ambiente.
L'epilessia onirica, a differenza della sindrome schizofrenica, si manifesta anche all'improvviso. Immagini oniriche fantastiche e allucinazioni verbali compaiono sullo sfondo di un marcato disturbo affettivo: piacere, orrore e rabbia raggiungono livelli di estasi. Il disorientamento personale è caratteristico degli epilettici. In questa forma, la compromissione della coscienza si manifesta con sintomi di stupore catatonico o eccitazione.
L'oniroidismo è una rara complicanza di origine esogena; il delirio è tipico.
Complicazioni e conseguenze
Se l'oneiroide nella schizofrenia è solo una parte dei sintomi positivi e, come notano gli esperti, ha un carattere prognosticamente favorevole, allora l'oneiroide esogeno-organico indica la gravità delle condizioni del paziente. Si tratta essenzialmente di una complicazione di traumi, intossicazioni o malattie, che si sviluppa nei casi gravi. Le conseguenze dipendono dalla profondità del danno cerebrale: il paziente può guarire completamente o rimanere disabile. L'oneiroide esogeno-organico di per sé non è un indicatore prognostico.
Diagnostica oniroide
Nella fase iniziale, persino delirante, nessuno oserebbe prevedere che la condizione si concluderà con un'oneiroide. Le fasi di sviluppo della sindrome sono state descritte sulla base di dati retrospettivi. Spesso il paziente ha già una diagnosi di schizofrenia, disturbo bipolare, oppure è a conoscenza, ad esempio, di un trauma cranico subito il giorno prima, di un tumore cerebrale o dell'uso di droghe. Se la causa della sindrome oneiroide è sconosciuta, il paziente necessita di un esame completo, di laboratorio e strumentale, utilizzando test di laboratorio e metodi strumentali. L'anamnesi personale e familiare viene presa in considerazione durante la diagnosi. [ 3 ]
La sindrome oneiroide viene diagnosticata direttamente in base al quadro clinico. Nella pratica psichiatrica, la presenza visibile di sintomi catatonici è più spesso notata; le manifestazioni di sintomi oneiroidi possono essere stabilite solo se vi è almeno un contatto parziale con il paziente. Se il paziente non è disponibile per il contatto, la diagnosi presuntiva viene formulata sulla base di un'indagine sui familiari.
Diagnosi differenziale
La diagnosi differenziale si effettua con i disturbi della coscienza: sindrome onirica, delirio, confusione, sonnolenza.
La sindrome onirica (onirismo) è una condizione in cui un individuo identifica il suo sogno con eventi reali, poiché al risveglio non ha la sensazione di aver dormito. Di conseguenza, il comportamento del paziente dopo il risveglio è determinato dal contenuto del sogno; egli continua a vivere nella realtà sognata. La critica alla sua condizione si manifesta in alcune persone dopo poco tempo (ore, giorni), mentre in altre non si manifesta affatto.
Il delirium si manifesta con una derealizzazione pronunciata, un disturbo dell'orientamento agli oggetti, mentre l'orientamento personale è preservato. Il cervello del paziente produce vivide allucinazioni vere e proprie (visive, uditive, tattili) e delirium sensoriale figurato, il cui contenuto corrisponde al comportamento del paziente. Le espressioni facciali del paziente riflettono il suo stato d'animo e, nel delirium, prevale l'effetto di paura, spesso accompagnato da agitazione psicomotoria. Quando si cerca di stabilire un contatto con il paziente, quest'ultimo non riesce a comprendere immediatamente l'essenza della domanda e spesso risponde in modo inappropriato, pur mantenendo la consapevolezza di sé. La differenza tra oniroide e delirium sta proprio nella preservazione dell'orientamento personale. Sebbene il comportamento nella maggior parte dei casi sia diverso, con l'oniroide la stragrande maggioranza dei pazienti si trova in uno stato di torpore stuporoso e con il delirium in uno stato di agitazione motoria e verbale, ma in alcuni casi queste condizioni non sono soddisfatte. Forme più gravi di delirium, che si sviluppano con un decorso sfavorevole della malattia di base, sono simili all'oniroide in assenza di contatto verbale con il paziente. Ma il comportamento in sé è significativamente diverso. Nel delirio professionale, il paziente esegue meccanicamente e silenziosamente le sue azioni abituali, non ha allucinazioni e deliri pronunciati, le esplosioni di eccitazione sono limitate spazialmente e vengono espresse verbalmente in parole o frasi separate. Il delirio mussificante (quieto) è caratterizzato da attività motoria scoordinata all'interno del letto. Di solito si tratta di movimenti di afferramento o scuotimento. Dopo un delirio esteso e nelle sue forme gravi, l'amnesia è sempre completa; se il delirio è limitato a una fase, possono permanere ricordi parziali della psicosi.
Inoltre, il delirium e l'oneiroide presentano una serie di altre differenze significative. In base al segno eziologico, le cause del delirium sono spesso esterne, mentre quelle dell'oneiroide sono interne. In termini di durata, i sintomi del delirium nella maggior parte dei casi si attenuano più rapidamente.
Il delirium ha un decorso ondulatorio: durante il giorno si alternano intervalli lucidi, di notte i sintomi psicopatologici si intensificano. I sintomi psicopatologici dell'oneiroide non dipendono dal momento della giornata, il suo decorso è stabile.
Nel delirio, il paziente ha vere e proprie allucinazioni che si manifestano al presente e riguardano argomenti quotidiani o professionali. Tipica è la percezione distorta delle dimensioni e delle forme degli oggetti circostanti (macropsia, micropsia). Il comportamento del paziente corrisponde a esperienze deliranti-allucinatorie. Nell'oniroidismo, il paziente vede fantastiche immagini panoramiche del passato o del futuro con l'occhio interiore, ma il suo comportamento e le sue espressioni facciali non corrispondono a tali esperienze.
Nel delirio il tono muscolare non è alterato, mentre nell'oniroide corrisponde spesso a un disturbo catatonico.
Nello stato di stordimento e sonnolenza, il comportamento dei pazienti può assomigliare esteriormente a quello di un oniroide orientato; sono inibiti, sedentari e difficilmente attirano la loro attenzione, ma non presentano tensione affettiva (poiché non c'è sintomatologia produttiva) e sintomi di disturbo catatonico.
Schizofrenia e sindrome oneiroide possono coesistere nello stesso paziente. Questa è una combinazione comune. Già a metà del secolo scorso si propose di introdurre il termine onirofrenia, distinguendo così dalla schizofrenia i pazienti affetti da annebbiamento della coscienza di tipo oneiroide. Ma questa proposta non ebbe successo. La sindrome oneiroide può anche, sebbene molto meno frequentemente, svilupparsi in altre psicosi. La diagnosi differenziale presenta alcune difficoltà; inoltre, la sindrome oneiroide nella schizofrenia, come ritengono gli psichiatri, spesso rimane non riconosciuta, il che è facilitato dal comportamento peculiare del paziente e dalla sua scarsa propensione a condividere le proprie esperienze con il medico.
Anche lo stato di memoria del paziente contribuisce a differenziare l'oneiroide da altri tipi di offuscamento della coscienza. Dopo l'uscita dall'oneiroide, si osserva solitamente un'amnesia limitata: il paziente non ha memoria di eventi reali, ma il ricordo delle esperienze patologiche vissute durante l'attacco viene preservato. Il paziente riesce a raccontare le sue "avventure" in modo abbastanza coerente e, quando la condizione migliora, il ricordo degli eventi precedenti all'oneiroide ritorna. Solo quella parte della realtà che il paziente non ha percepito, essendo in uno stato di distacco, scompare dalla memoria. In coloro che hanno sperimentato l'oneiroide, l'amnesia si manifesta in misura molto minore rispetto a disturbi della coscienza come il delirio o lo stordimento.
Chi contattare?
Trattamento oniroide
Poiché la sindrome oneiroide si sviluppa per varie cause, il trattamento principale è l'eliminazione del fattore eziologico. In caso di intossicazione, si esegue una terapia disintossicante; in caso di infezioni gravi, queste vengono trattate per prime; il metabolismo alterato viene ripristinato; in caso di lesioni, malattie cerebrovascolari e tumori, può essere necessario un intervento chirurgico.
I sintomi produttivi del disturbo onirico e catatonico vengono alleviati con i neurolettici. Questi stessi farmaci sono i principali farmaci per il trattamento della schizofrenia e di altre condizioni patopsicologiche in cui si sviluppa il disturbo onirico. Attualmente, la preferenza nella scelta del farmaco viene data ai neurolettici di seconda generazione o atipici, il cui uso, soprattutto nel parkinsonismo farmacologico a breve termine associato all'effetto sul sistema dopaminergico, si sviluppa meno frequentemente. Inoltre, molti degli atipici sono più potenti di quelli tipici e sono in grado di alleviare rapidamente i sintomi produttivi.
Ad esempio, il leponex (clozapina), il primo antipsicotico che non causa effetti collaterali extrapiramidali acuti, ha un potente effetto antidelirante e antiallucinatorio. Tuttavia, a seguito del suo utilizzo, si osservano spesso disturbi dell'ematopoiesi (agranulocitosi, neutropenia), possono verificarsi convulsioni e problemi cardiaci. I pazienti si sentono inibiti, assonnati e incapaci di rispondere adeguatamente.
L'olanzapina è altamente efficace nell'alleviare i sintomi produttivi e l'agitazione. Tuttavia, provoca anche una forte sedazione e aumenta l'appetito, con conseguente rapido aumento di peso. Risperidone e amisulpiride sono considerati farmaci ad azione moderata, ma il loro principale effetto collaterale è l'iperprolattinemia.
Oltre ai farmaci atipici, vengono utilizzati anche i neurolettici tradizionali. Aloperidolo e flufenazina hanno un'elevata attività antipsicotica. I principali effetti indesiderati dei neurolettici classici sono i sintomi del parkinsonismo. Inoltre, tutti i neurolettici riducono la pressione sanguigna, interferiscono con la funzionalità cardiaca, influenzano in misura maggiore o minore l'emopoiesi, il sistema endocrino ed epatobiliare e presentano anche una serie di altri effetti collaterali. Pertanto, l'approccio alla scelta e al dosaggio del farmaco è strettamente individuale. Ad esempio, per i pazienti con una predisposizione iniziale alla facile insorgenza di disturbi endocrini, cardiovascolari ed ematologici, sono preferibili i neurolettici classici (tipici), mentre ai pazienti con un'alta probabilità di sviluppare disturbi neurologici vengono prescritti neurolettici atipici. Il medico deve considerare e confrontare molti fattori: la compatibilità con i farmaci per il trattamento della patologia di base, la funzionalità degli organi escretori, la presenza di controindicazioni relative.
Per normalizzare i processi metabolici del cervello e migliorarne l'attività integrativa, vengono prescritti farmaci nootropici. Migliorano la nutrizione cellulare, in particolare l'assorbimento di glucosio e ossigeno; stimolano i processi metabolici cellulari; migliorano la conduttività colinergica e la sintesi di proteine e fosfolipidi. Possono essere prescritti cinnarizina, piracetam, cerebrolysin, l'antiipoxante actovegin e il preparato erboristico Memoplant a base di ginkgo biloba.
In caso di resistenza al farmaco si ricorre alla terapia elettroconvulsiva.
Prevenzione
La principale misura preventiva per lo sviluppo dell'oneiroide è uno stile di vita sano, in particolare l'assenza di dipendenza da alcol e droghe, che riduce significativamente il rischio di disturbi mentali e traumi cranici. Le persone responsabili della propria salute hanno solitamente una buona immunità, quindi tollerano più facilmente le malattie infettive, sono meno inclini a contrarre disturbi metabolici e altre patologie croniche, hanno un'elevata resistenza allo stress e consultano tempestivamente un medico per prevenire le complicazioni. [ 4 ]
I pazienti affetti da schizofrenia e disturbo bipolare devono seguire la terapia farmacologica e le restrizioni comportamentali e di stile di vita raccomandate dal medico.
Previsione
I moderni metodi di trattamento sono in grado di fornire una prognosi favorevole nella maggior parte dei casi di sindrome oneiroide con genesi esogena-organica del disturbo e di ripristinare completamente la salute mentale del paziente, sebbene in generale la prognosi dipenda dal decorso e dalla gravità della patologia di base. Anche la sindrome oneiroide endogena si risolve solitamente senza trattamento, tuttavia lo stato di salute mentale rimane solitamente compromesso a causa della patologia di base.

