Esperto medico dell'articolo
Nuove pubblicazioni
Lesioni del legamento crociato anteriore
Ultima recensione: 07.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.
Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.
Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.
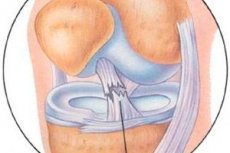
Da diversi decenni si studiano i risultati del trattamento artroscopico delle lesioni dell'apparato capsulo-legamentoso dell'articolazione del ginocchio.
Nonostante la varietà di metodi artroscopici per il trattamento dell'instabilità post-traumatica anteriore dell'articolazione del ginocchio, esiste ancora una percentuale significativa di risultati insoddisfacenti, la cui causa più importante è rappresentata dalle complicazioni derivanti da errori nelle fasi di diagnosi, trattamento chirurgico e riabilitazione dei pazienti con instabilità post-traumatica anteriore.
La letteratura tratta ampiamente le possibili complicanze dopo il trattamento artroscopico dell'instabilità post-traumatica anteriore. Tuttavia, scarsa attenzione è stata dedicata all'analisi delle loro cause e ai metodi di correzione.
Epidemiologia
Il problema del trattamento dei pazienti con patologie dell'articolazione del ginocchio rimane ancora oggi importante e uno dei più complessi in traumatologia. Il ginocchio è l'articolazione più frequentemente lesionata, rappresentando fino al 50% di tutte le lesioni articolari e fino al 24% delle lesioni degli arti inferiori.
Secondo diversi autori, le rotture dei legamenti crociati dell'articolazione del ginocchio si verificano con una frequenza che va dal 7,3 al 62% di tutte le lesioni dell'apparato capsulo-legamentoso dell'articolazione del ginocchio.
Diagnostica lesioni del legamento crociato anteriore
Tutti i pazienti vengono sottoposti a visita clinica e radiologica prima dell'intervento primario. Vengono eseguiti anamnesi, visita medica, palpazione, accertamenti clinici per la valutazione del danno strutturale dell'articolazione del ginocchio, radiografia, analisi generali del sangue e delle urine, esami biochimici del sangue e delle urine. In base alle indicazioni, vengono eseguiti i seguenti esami strumentali: test con CT-1000, TC, RM, ecografia. L'artroscopia diagnostica precede immediatamente il trattamento chirurgico.
La visita medica del paziente inizia con l'individuazione dei disturbi e la raccolta dell'anamnesi. È importante determinare il meccanismo di danno all'apparato legamentoso del ginocchio e raccogliere informazioni su precedenti interventi chirurgici sull'articolazione. Successivamente, si esegue l'esame obiettivo, la palpazione, si misura la circonferenza dell'articolazione, si determina l'ampiezza dei movimenti passivi e attivi e si utilizzano ampiamente le tabelle di valutazione del questionario di Lysholm per gli atleti e la scala a 100 punti sviluppata presso l'Istituto Centrale di Traumatologia e Ortopedia per i pazienti con minori esigenze fisiche.
Le funzioni degli arti inferiori vengono valutate in base ai seguenti parametri: disturbi dell'instabilità dell'articolazione, capacità di eliminare attivamente lo spostamento patologico passivamente imposto della tibia, capacità di supporto, zoppia, esecuzione di compiti motori speciali, forza massima dei muscoli periarticolari durante il lavoro prolungato, ipotrofia dei muscoli della coscia, tono muscolare, disturbi del dolore all'articolazione, presenza di sinovite, conformità delle capacità motorie con il livello delle aspirazioni funzionali.
Ogni segno viene valutato su una scala a 5 punti: 5 punti - nessuna alterazione patologica, compensazione delle funzioni; 4-3 punti - alterazioni moderate, subcompensazione; 2-0 punti - alterazioni marcate, scompenso.
La valutazione dei risultati del trattamento comprende tre gradi: buono (più di 77 punti), soddisfacente (67-76 punti) e insoddisfacente (meno di 66 punti).
Uno dei criteri per la valutazione soggettiva dei risultati del trattamento è la valutazione personale del paziente del proprio stato funzionale. La condizione per un buon risultato è il ripristino delle prestazioni funzionali. In assenza di ciò, i risultati del trattamento sono considerati soddisfacenti o insoddisfacenti.
Durante l'esame clinico, viene valutata l'ampiezza del movimento e vengono eseguiti test di stabilità. È sempre importante escludere il segno del cassetto anteriore.
I pazienti lamentano dolore e/o una sensazione di instabilità articolare. Il dolore può essere causato dall'instabilità stessa o da un danno associato alla cartilagine o al menisco. Alcuni pazienti non ricordano il precedente infortunio, accorgendosi improvvisamente dell'articolazione del ginocchio mesi o anni dopo. I pazienti raramente descrivono l'articolazione del ginocchio come instabile. Di solito descrivono incertezza, lassità e incapacità di controllare il movimento dell'articolazione lesionata.
Il crepitio sotto la rotula è caratteristico di una violazione della biomeccanica nell'articolazione femoro-rotulea.
Spesso diventano dominanti i sintomi secondari: versamento articolare cronico, alterazioni degenerative dell'articolazione o cisti di Baker.
Anche le condizioni delle strutture stabilizzanti attivo-dinamiche, sia prima che dopo l'intervento, sono considerate importanti. Ciò è dovuto al raggiungimento di un effetto stabilizzante sufficientemente affidabile grazie ai muscoli periarticolari.
Grande importanza è attribuita all'indicatore della forza muscolare.
Per diagnosticare l'instabilità anteriore e valutare i risultati a lungo termine del suo trattamento si utilizzano i test più informativi: il sintomo del "cassetto" anteriore in posizione neutra della tibia, il test di abduzione, il test di adduzione e il test di Lachman.
Un indicatore importante dello stato funzionale è la capacità di eliminare attivamente lo spostamento patologico imposto passivamente della tibia rispetto alla coscia.
Tra le attività motorie speciali utilizziamo camminare, correre, saltare, salire le scale, fare squat, ecc.
È fondamentale tenere conto della resistenza dei muscoli periarticolari durante un lavoro prolungato.
Il complesso di test passivi comprende il sintomo del “cassetto” anteriore in tre posizioni della tibia, test di abduzione e adduzione a 0 e 20° di flessione nell'articolazione, un test di recurvazione e un test di cambiamento laterale del punto di appoggio, il test di Lachman-Trillat e la misurazione della rotazione patologica della tibia.
Il complesso di test attivi comprende un test del “cassetto” anteriore attivo in tre posizioni della parte inferiore della gamba, test di abduzione e adduzione attivi a 0 e 20° di flessione nell'articolazione e un test di Lachman attivo.
Per determinare una lesione o un'insufficienza del legamento crociato anteriore, si utilizza il sintomo del "cassetto" anteriore: lo spostamento passivo della tibia (traslazione anteriore), anche con diverse posizioni di flessione della tibia. Si raccomanda di concentrarsi su una delle gradazioni di questo sintomo più accettate in letteratura: I grado (+) - 6-10 mm, II grado (++) - 11-15 mm, III grado (+++) - oltre 15 mm.
Inoltre, il sintomo del cassetto anteriore deve essere valutato con diverse posizioni di rotazione della tibia: 30°, rotazione esterna o interna.
Il segno di Lachman è riconosciuto come il test più patognomonico per rilevare danni al legamento crociato anteriore o al suo innesto. Si ritiene che fornisca la maggior parte delle informazioni sullo stato del legamento crociato anteriore nella lesione acuta del legamento crociato anteriore, poiché quando viene eseguito, non vi è quasi alcuna resistenza muscolare alla traslazione anteroposteriore (dislocazione) della tibia, così come nell'instabilità cronica del legamento crociato anteriore.
Il test di Lachman viene eseguito in posizione supina. La valutazione si basa sull'entità dello spostamento anteriore della tibia rispetto al femore. Alcuni autori utilizzano le seguenti gradazioni: Grado I (+) - 5 mm (3-6 mm), Grado II (++) - 8 mm (5-9 mm), Grado III (+++) - 13 mm (9-16 mm), Grado IV (++++) - 18 mm (fino a 20 mm). Nel tentativo di unificare il sistema di valutazione, utilizziamo una gradazione a tre stadi simile a quella precedentemente descritta per il sintomo del "cassetto" anteriore.
Anche il sintomo di un cambiamento del punto di rotazione, o sintomo di sublussazione dinamica anteriore della tibia (pivot shift-test), è considerato un sintomo patognomonico di una lesione del legamento crociato anteriore; in misura minore, è caratteristico di una combinazione con una rottura delle strutture legamentose laterali interne.
Il test viene eseguito in posizione supina, con i muscoli delle gambe rilassati. Una mano afferra il piede e ruota la tibia verso l'interno, mentre l'altra si posiziona nella zona del condilo femorale laterale. Con una lenta flessione del ginocchio a 140-150°, la mano percepisce la presenza di una sublussazione anteriore della tibia, che viene eliminata con un'ulteriore flessione.
Il test del pivot shift su Macintosh viene eseguito in una posizione simile del paziente. La rotazione interna della tibia viene eseguita con una mano e la deviazione in valgo con l'altra. In caso di test positivo, la parte laterale della superficie articolare della tibia (il piatto esterno) viene spostata in avanti, mentre con una lenta flessione del ginocchio a 30-40°, viene spostata all'indietro. Sebbene il test del pivot shift sia considerato patognomonico per la lesione del legamento crociato anteriore (ITT), può risultare negativo in caso di lesione del tratto ileo-tibiale (ITT), rottura longitudinale completa del menisco mediale o laterale con lussazione del suo corpo (rottura a "manico di annaffiatoio"), un processo degenerativo pronunciato nella parte laterale dell'articolazione, ipertrofia dei tubercoli dell'eminenza intercondiloidea della tibia, ecc.
Il test di Lachmann attivo può essere utilizzato sia durante l'esame clinico che durante l'esame radiografico. In caso di lesione del legamento crociato anteriore, lo spostamento anteriore della tibia raggiunge i 3-6 mm. Il test viene eseguito in posizione supina con le gambe completamente estese. Una mano viene posizionata sotto la coscia dell'arto esaminato, piegandola all'altezza dell'articolazione del ginocchio con un angolo di 20°, e l'articolazione tibiale dell'altra gamba viene afferrata con la mano in modo che la coscia dell'arto esaminato appoggi sull'avambraccio dell'esaminatore. L'altra mano viene posizionata sulla superficie anteriore dell'articolazione della caviglia del paziente, con il tallone premuto contro il tavolo. Quindi al paziente viene chiesto di contrarre il muscolo quadricipite della coscia e di monitorare attentamente il movimento in avanti della tuberosità tibiale. Se lo spostamento è superiore a 3 mm, il sintomo è considerato positivo, il che indica una lesione del legamento crociato anteriore. Per determinare le condizioni degli stabilizzatori mediali e laterali dell'articolazione, è possibile eseguire un test simile con rotazione interna ed esterna della tibia.
Raggi X
La radiografia viene eseguita utilizzando il metodo generalmente accettato in due proiezioni standard; vengono eseguite anche radiografie funzionali.
Nella valutazione delle immagini vengono presi in considerazione la posizione della rotula, l'angolo tibiofemorale, la convessità del piatto tibiale laterale, la concavità del piatto mediale e la posizione dorsale del perone rispetto alla tibia.
Le radiografie permettono di valutare le condizioni generali dell'articolazione del ginocchio, di individuare alterazioni degenerative, di determinare le condizioni delle ossa, il tipo e la posizione delle strutture metalliche, la posizione dei tunnel e la loro dilatazione dopo l'intervento chirurgico.
L'esperienza del medico è di grande importanza, poiché la valutazione delle immagini ottenute è piuttosto soggettiva.
Le radiografie laterali devono essere eseguite con l'articolazione in flessione di 45° per valutare correttamente il rapporto tra tibia e rotula. Per valutare oggettivamente la rotazione della tibia, è necessario sovrapporre i condili tibiali laterale e mediale. Viene valutata anche l'altezza della rotula.
L'estensione insufficiente è più facile da diagnosticare nella proiezione laterale, con il paziente sdraiato con la gamba pronata.
Per determinare l'asse dell'arto, sono necessarie ulteriori radiografie in proiezione diretta su lunghe cassette con il paziente in posizione eretta, poiché nell'artrosi deformante sono presenti deviazioni dalla norma. L'asse anatomico dell'arto, determinato dall'orientamento longitudinale della coscia rispetto a quello della tibia, è in media di 50-80°. Questo è il punto più importante nel corso di un ulteriore trattamento chirurgico (osteotomia correttiva, artroplastica, endoprotesi).
Il grado di spostamento della tibia rispetto al femore nelle direzioni anteroposteriore e medio-laterale viene determinato utilizzando radiografie funzionali con carico.
Nell'instabilità anteriore cronica dell'articolazione del ginocchio si notano segni radiografici caratteristici: restringimento della fossa intercondiloidea, restringimento dello spazio articolare, presenza di osteofiti periferici sulla tibia, sui poli superiore e inferiore della rotula, approfondimento del solco meniscale anteriore sul condilo laterale del femore, ipertrofia e appuntitura del tubercolo dell'eminenza intercondiloidea.
La radiografia laterale indica molto spesso la causa della limitazione del movimento. La radiografia laterale in massima estensione può indicare un'estensione insufficiente, mentre si valuta la posizione del tunnel tibiale rispetto all'arco intercondiloideo, che appare come un ispessimento lineare (linea di Blumensaat).
 [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ], [ 20 ]
[ 14 ], [ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ], [ 20 ]
Tomografia computerizzata
La TC non è considerata un esame di routine. Viene eseguita sui pazienti quando altri tipi di esame non sono sufficientemente informativi, soprattutto in caso di fratture da compressione dei condili tibiali.
La TC è utile per visualizzare i danni ossei e osteocondrali. La TC consente di eseguire vari test dinamici con flessione del ginocchio a diverse angolazioni.
 [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ], [ 24 ], [ 25 ]
[ 21 ], [ 22 ], [ 23 ], [ 24 ], [ 25 ]
KT-1000
Per misurare lo spostamento anteroposteriore della tibia viene utilizzato il dispositivo KT-1000.
Il dispositivo KT-1000 è un artrometro, costituito da un dispositivo vero e proprio per la misurazione dello spostamento anteroposteriore della tibia rispetto al femore e da supporti per i terzi inferiori delle cosce e dei piedi. Il dispositivo viene fissato alla tibia tramite cinghie in velcro e la piattaforma del sensore esistente preme la rotula sulla superficie anteriore del femore. In questo caso, lo spazio articolare dovrebbe coincidere con la linea sul dispositivo. L'arto inferiore posizionato sui supporti viene piegato all'altezza dell'articolazione del ginocchio di 15-30° per misurare lo spostamento anteriore della tibia e di 70° per misurare lo spostamento posteriore della tibia rispetto al femore.
Innanzitutto, viene esaminata l'articolazione del ginocchio lesionata. Per misurare lo spostamento anteriore della tibia, il medico tira verso di sé la maniglia situata nella parte antero-superiore del dispositivo e cerca di effettuare uno spostamento anteriore della tibia tenendo il cuscinetto sensoriale sulla rotula. In questo caso, viene applicata una forza di 6, 8 e 12 kg, controllata da segnali acustici. A ogni segnale acustico, il medico rileva la deviazione della freccia sulla scala e registra le letture del dispositivo. Lo spostamento della tibia rispetto al femore è espresso in millimetri. Successivamente, il medico verifica lo spostamento posteriore della tibia piegandola all'altezza dell'articolazione del ginocchio fino a un angolo di 70° e cerca di spostare la tibia all'indietro utilizzando la maniglia del dispositivo. Il segnale acustico che si verifica quando la freccia viene deviata indica l'entità dello spostamento posteriore della tibia rispetto al femore.
Test simili vengono eseguiti sull'articolazione del ginocchio sana. I dati corrispondenti ottenuti dalle articolazioni del ginocchio sano e danneggiato vengono quindi confrontati e sottratti. Questa differenza mostra l'entità dello spostamento anteriore della tibia rispetto al femore sotto un carico di 6, 8 e 12 kg.
Lo spostamento anteriore viene determinato con un angolo di flessione della tibia di 30°.
Se si rileva una differenza nell'entità dello spostamento anteriore a 67H e 89H delle articolazioni colpite e sane di oltre 2 mm, si sospetta una rottura del legamento crociato anteriore.
Esistono alcuni principi per i test strumentali per l'instabilità dell'articolazione del ginocchio. Devono essere presi in considerazione i seguenti parametri: il grado di rigidità del fissaggio dell'arto con le cinghie, la posizione dei sensori sensoriali sull'articolazione, il completo rilassamento dei muscoli della gamba, la posizione dell'artrometro rispetto allo spazio articolare, il grado di rotazione della parte inferiore della gamba, il peso della gamba, l'angolo di flessione dell'articolazione del ginocchio.
Nella fase acuta successiva a un infortunio, l'uso di un artrometro è inappropriato, poiché è impossibile rilassare completamente i muscoli periarticolari. È necessario scegliere correttamente la posizione neutra della tibia, tenendo conto che con lo spostamento anteriore della tibia si verifica una rotazione interna, con quello posteriore-esterno. In caso contrario, il valore della traslazione anteroposteriore sarà inferiore al valore reale. Per ottenere il massimo valore di spostamento patologico della tibia, è inoltre necessario consentirne la libera rotazione.
Il grado di traslazione dipende dall'entità della forza applicata, dal suo punto di attrazione e dalla sua direzione.
L'uso di poggiapiedi non deve limitare la rotazione della parte inferiore della gamba. È necessario posizionare i sensori rigorosamente orientati verso lo spazio articolare, poiché se sono spostati distalmente, le letture saranno inferiori al valore reale, se sono spostati prossimalmente, superiori.
Condizione imprescindibile per una valutazione obiettiva è la fissazione della rotula nel solco intercondiloideo. Per ottenere ciò, è necessario conferire alla tibia un angolo di flessione articolare di circa 25-30°. In caso di sublussazioni congenite e post-traumatiche della rotula, l'angolo di flessione viene aumentato a 40°. In caso di instabilità anteriore, l'angolo di flessione articolare è di 30°, in caso di instabilità posteriore di 90°.
Il test è accompagnato da due segnali audio: il primo a un carico di 67 N, il secondo a 89 N. A volte, è necessaria una forza maggiore per determinare una rottura del legamento crociato anteriore.
Normalmente, la differenza tra i due arti durante il test dello spostamento anteroposteriore non supera i 2 mm; talvolta viene indicato come limite normale un valore inferiore a 3 mm.
Si considera l'indice di compliance anteriore, ovvero la differenza tra lo spostamento a 67 N e quello a 89 N. Anche questo valore non dovrebbe normalmente superare i 2 mm.
Se lo spostamento è superiore a 2 mm, si può parlare di rottura del legamento crociato anteriore (innesto del legamento crociato anteriore).
È inoltre opportuno segnalare che in caso di instabilità di entrambe le articolazioni del ginocchio o di ipermobilità, l'uso dell'artrometro KT-1000 non è consigliabile.
In conclusione, va detto che l'utilizzo di questo artrometro comporta certamente un elemento di soggettività, che dipende da diversi parametri, tra cui il ricercatore. Pertanto, la visita dei pazienti dovrebbe essere effettuata (se possibile) da un solo medico.
Con l'ausilio del CT-1000 è possibile accertare solo lo spostamento anteroposteriore della tibia rispetto al femore, mentre non viene registrata l'instabilità laterale.
Risonanza magnetica
La risonanza magnetica è il metodo di ricerca non invasivo più informativo, poiché consente di visualizzare sia le strutture ossee che quelle dei tessuti molli dell'articolazione del ginocchio.
Un legamento crociato anteriore sano dovrebbe apparire a bassa intensità in tutte le immagini. Rispetto al legamento crociato posteriore, più denso, il legamento crociato anteriore può risultare leggermente disomogeneo. A causa del suo orientamento obliquo, molti preferiscono utilizzare immagini coronali oblique. In caso di lesione del legamento crociato anteriore, la risonanza magnetica può visualizzare la sede della lesione.
Il legamento crociato anteriore è ben visualizzato nelle sezioni laterali durante l'estensione e la rotazione esterna della tibia. Il legamento crociato anteriore è più luminoso del legamento crociato posteriore e le sue fibre sono contorte. L'assenza di continuità delle fibre o il loro orientamento caotico indica una rottura del legamento.
La rottura completa del legamento crociato anteriore viene diagnosticata più frequentemente tramite segni indiretti: spostamento anteriore della tibia, eccessiva inclinazione posteriore del legamento crociato posteriore, contorno ondulato del legamento crociato anteriore.
Esame ecografico
I vantaggi degli ultrasuoni sono il basso costo, la sicurezza, la velocità e la possibilità di ottenere immagini altamente informative dei tessuti molli.
L'ecografia consente di studiare le condizioni dei tessuti molli dell'articolazione del ginocchio, la superficie ossea e cartilaginea in base all'ecogenicità della struttura, e anche di individuare edemi tissutali, accumuli di liquidi nella cavità articolare o formazioni periarticolari in base alla riduzione dell'ecogenicità. L'ecografia viene utilizzata per rilevare danni al menisco dell'articolazione del ginocchio, ai legamenti collaterali e alle strutture dei tessuti molli che circondano l'articolazione del ginocchio.
Artroscopia
Nell'artroscopia diagnostica, gli autori utilizzano approcci standard: anterolaterale, anteromediale e laterale rotuleo superiore.
L'esame artroscopico del legamento crociato anteriore include la valutazione dell'aspetto del legamento crociato anteriore, dell'integrità della membrana sinoviale del legamento e dell'orientamento delle fibre collagene non solo a livello del sito di inserzione tibiale del legamento, ma anche lungo la sua lunghezza, in particolare nel sito di inserzione femorale. Se, in caso di lesione del legamento crociato anteriore lungo la sua lunghezza e a livello del sito di inserzione tibiale con rottura di un frammento osseo, la diagnosi artroscopica non presenta particolari difficoltà, la diagnosi di lesioni intrasinoviali (intrastruncali) recenti e pregresse del legamento crociato anteriore presenta notevoli difficoltà. Ciò è dovuto al fatto che esternamente, a prima vista, il legamento crociato anteriore sembra intatto: la membrana sinoviale è intatta, la palpazione del legamento crociato anteriore con un uncino artroscopico mostra la presenza di una struttura e di uno spessore completi del legamento, il sintomo artroscopico del "cassetto" anteriore mostra una sufficiente tensione delle fibre legamentose. Tuttavia, un esame più attento della rete capillare nelle porzioni media e femorale del legamento, nonché l'apertura della membrana sinoviale del legamento, permette di determinare un danno alle fibre legamentose e la presenza di emorragie o tessuto cicatriziale. Un segno secondario di una vecchia lesione intrasinoviale del legamento crociato anteriore è l'ipertrofia del tessuto sinoviale e adiposo sulla porzione femorale del legamento crociato posteriore e sulla volta dell'incisura intercondiloidea del femore (sintomo di "accrescimento tissutale").
Talvolta solo per via artroscopica è possibile rilevare i seguenti tipi di danni al legamento crociato anteriore:
- lesione del legamento crociato anteriore nel sito di attacco femorale con o senza formazione di un moncone;
- lesione intrasinoviale del legamento crociato anteriore;
- lesione del legamento crociato anteriore;
- in rari casi - lesione del legamento crociato anteriore nella zona dell'eminenza intercondiloidea con rottura di un frammento osseo.
Trattamento lesioni del legamento crociato anteriore
Nella forma compensata di instabilità anteriore dell'articolazione del ginocchio, il trattamento consiste nell'immobilizzazione seguita dal ripristino della mobilità articolare e delle funzioni degli stabilizzatori attivi (muscoli).
Nelle forme subcompensate e scompensate di instabilità anteriore, è necessario un intervento chirurgico volto a ripristinare l'integrità degli stabilizzatori principalmente statici. Il complesso terapeutico include necessariamente un trattamento funzionale per rafforzare gli stabilizzatori attivi.
Va inoltre notato che, come risultato delle misure terapeutiche, soprattutto nel caso di instabilità anteromediale, sono possibili transizioni dalla forma subcompensata a quella compensata, poiché questa regione anatomica presenta il maggior numero di stabilizzatori secondari, il che ha un effetto benefico sull'esito del trattamento.
La gestione dei pazienti con instabilità anteriore del ginocchio dipende da molti fattori: età, tipo di attività professionale, livello di allenamento sportivo, lesioni intra-articolari concomitanti, grado di instabilità, rischio di recidiva, tempo trascorso dall'infortunio. Innanzitutto, la ricostruzione plastica del legamento crociato anteriore in caso di rottura è indicata per gli atleti professionisti, soprattutto in caso di lesioni concomitanti ad altre strutture dell'articolazione del ginocchio. La ricostruzione del legamento crociato anteriore è raccomandata anche in caso di instabilità cronica del ginocchio.
Le indicazioni per la stabilizzazione statica artroscopica anteriore sono le forme e i tipi di instabilità anteromediale (A2M1, A2M2, AZM1, AZM2, AZM3) e anterolaterale (A2L1, A2L2, A2L3, AZL1, AZL2, AZL3), primarie e ricorrenti, subcompensate e scompensate, e l'incapacità di compensare la patologia con metodi di trattamento conservativi.
La decisione sulla ricostruzione plastica del legamento crociato anteriore nei pazienti di età superiore ai 50 anni viene presa in base all'età, al livello di attività fisica del paziente e al grado di artrosi deformante. La chirurgia plastica del legamento crociato anteriore è raccomandata in caso di grave limitazione dell'attività fisica dovuta all'instabilità dell'articolazione del ginocchio.
In ogni singolo caso, la decisione sul trattamento chirurgico viene presa tenendo conto delle caratteristiche individuali del paziente.
Le seguenti condizioni e patologie sono considerate controindicazioni alla stabilizzazione statica:
- presenza di gonartrosi di grado III-IV;
- grave ipotrofia dei muscoli della coscia;
- contrattura articolare;
- il periodo successivo all'infortunio è superiore a 3 giorni e inferiore a 3 settimane;
- malattie infettive;
- osteoporosi;
- trombosi dei vasi degli arti inferiori.
Nella fase di definizione delle indicazioni e controindicazioni per il trattamento chirurgico dell'instabilità post-traumatica anteriore, a volte si presenta un dilemma. Da un lato, le conseguenze dell'instabilità cronica (ipotrofia dei muscoli della coscia, artrosi deformante) diventano controindicazioni all'esecuzione della stabilizzazione statica, e la stabilizzazione artroscopica mediante trapianti con blocchi ossei porta a un aumento del carico sulla cartilagine articolare (con conseguente progressione dell'artrosi deformante). Dall'altro lato, i metodi conservativi non forniscono un effetto stabilizzante sufficiente, contribuendo ulteriormente allo sviluppo dell'artrosi deformante.
Talvolta si consiglia di posticipare l'operazione fino al ripristino dell'ampiezza di movimento dell'articolazione del ginocchio, un'operazione che può richiedere dalle 2 alle 3 settimane. Rinviare l'operazione in fase acuta riduce le complicanze durante le misure riabilitative associate al ripristino dell'ampiezza di movimento dell'articolazione del ginocchio dopo l'intervento chirurgico.
Selezione dell'autotrapianto e del metodo di fissazione
Gli autoinnesti più comunemente utilizzati per la ricostruzione del legamento crociato anteriore sono il tendine rotuleo, il semimembranoso e il tendine di Grace, e in rari casi il tendine di Achille e il tendine del quadricipite. Il terzo centrale del tendine rotuleo con due blocchi ossei rimane l'autoinnesto più comune per la ricostruzione del legamento crociato anteriore negli atleti. Il tendine del quadricipite con un blocco osseo o senza blocco osseo è sempre più utilizzato come autoinnesto per la sostituzione del legamento crociato anteriore. L'automateriale più comunemente utilizzato per il trapianto di legamento crociato anteriore presso il CITO è il terzo centrale del tendine rotuleo. Questo innesto presenta due blocchi ossei (provenienti dalla rotula e dalla tuberosità tibiale) per garantire una fissazione primaria rigida e affidabile, che facilita il carico precoce.
I vantaggi dell'autotrapianto del tendine rotuleo sono i seguenti.
- Normalmente, la larghezza del legamento rotuleo consente il prelievo di un autoinnesto di qualsiasi larghezza e spessore desiderati. In genere, l'innesto ha una larghezza di 8-10 mm, ma a volte, in caso di ricostruzioni ripetute, la larghezza richiesta può raggiungere i 12 mm.
- Il legamento rotuleo è sempre disponibile come materiale autologo e presenta minime variazioni anatomiche. Ciò consente un prelievo tecnicamente semplice del materiale autologo in qualsiasi momento.
- I blocchi ossei consentono di fissare saldamente l'innesto, ad esempio mediante viti a interferenza, avvitate tra il blocco osseo e la parete del tunnel osseo. Questo metodo garantisce un fissaggio primario molto elevato.
L'utilizzo di un autotrapianto di tendini del semitendinoso e dei muscoli crociati, secondo alcuni autori, aumenta la rotazione esterna patologica della tibia fino al 12%. Il successo della ricostruzione del legamento crociato anteriore dipende in modo significativo dal rimodellamento biologico del trapianto.
A causa della rimozione di una striscia di legamento con blocchi ossei dalla rotula e dalla tuberosità tibiale, quest'area diventa dolorosa. Sebbene il difetto osseo possa essere chiuso con osso spugnoso, non è sempre possibile chiuderlo adeguatamente con i tessuti molli, soprattutto se la lesione primaria ha causato la formazione di cicatrici attorno al tendine.
Poiché il blocco osseo viene prelevato dalla tuberosità tibiale, importante per il supporto del ginocchio, alcuni pazienti (lottatori, artisti, membri del clero, ecc.) possono lamentare dolore durante il carico diretto sull'articolazione del ginocchio o l'incapacità di sostenere il ginocchio. Si osservano casi in cui il paziente non lamenta instabilità dell'articolazione del ginocchio e insufficiente funzionalità dell'arto dopo l'intervento chirurgico, ma a causa di questa complicazione è costretto ad abbandonare o limitare la propria attività professionale abituale. Pertanto, un buon risultato non si basa solo sulla stabilità.
Nella clinica traumatologica sportiva e di danza dell'Istituto centrale di traumatologia e ortopedia si preferisce l'uso di autoinnesti del legamento rotuleo con due blocchi ossei e la loro fissazione con viti a interferenza.
Dopo un'artroscopia diagnostica, si esegue la stabilizzazione statica anteriore dell'articolazione del ginocchio con un autotrapianto libero dal legamento rotuleo per determinare l'ambito e i tipi di intervento.
L'autotrapianto viene solitamente prelevato dall'arto ipsilaterale per preservare l'arto controlaterale come supporto. Innanzitutto, viene prelevato un blocco osseo dalla tuberosità tibiale, quindi dalla rotula. Uno dei blocchi ossei deve essere sufficientemente grande da poter essere fissato nel tunnel femorale.
Per ridurre la probabilità di rottura del blocco osseo e l'entità del danno al sito donatore, vengono prelevati frammenti ossei autoinnestati di forma trapezoidale; tale blocco osseo è più facile da lavorare con una pinza crimpatrice, che conferisce all'innesto una forma arrotondata, riducendo al contempo il rischio di frattura della rotula.
Un autotrapianto di questo tipo è più facile da installare nei tunnel intraossei. L'autotrapianto viene prima tagliato dalla tuberosità tibiale, poi dalla rotula.
Utilizzando la compressione artroscopica, ai blocchi ossei viene conferita una forma arrotondata.
Contemporaneamente alla preparazione dell'autotrapianto, viene determinata la posizione ottimale (isometrica) del tunnel tibiale. A tale scopo, viene utilizzato uno speciale sistema stereoscopico (l'angolo del sistema stereoscopico è di 5,5°). Il tunnel viene centrato, concentrandosi sulla parte tibiale rimanente del legamento crociato anteriore e, in sua assenza, sull'area compresa tra i tubercoli dell'eminenza intercondiloidea o 1-2 mm dietro di essi.
Il suo diametro varia a seconda delle dimensioni dell'autotrapianto (dovrebbe essere 1 mm più grande del diametro del trapianto). Si utilizza una fresa di un diametro specifico per creare un tunnel intraosseo (rigorosamente lungo la linea di frattura, altrimenti il canale si allargherà). L'articolazione viene lavata accuratamente per rimuovere i frammenti ossei. Una raspa artroscopica viene utilizzata per levigare il bordo di uscita del canale tibiale.
Nella fase successiva, si utilizza una fresa per determinare il punto di inserzione femorale sul condilo femorale laterale (5-7 mm dal bordo posteriore) per l'articolazione del ginocchio destro a ore 11. Nelle ricostruzioni di revisione, il "vecchio" canale viene solitamente utilizzato con lievi variazioni nella sua posizione. Utilizzando una fresa cannulata, si fresa il canale femorale; la sua profondità non deve superare i 3 cm. Dopo aver completato la fresatura del canale, i bordi del canale femorale vengono lavorati con una raspa artroscopica.
In alcuni casi si esegue un intervento di chirurgia plastica dell'incisura intercondiloidea (arco gotico, rampa dell'incisura intercondiloidea).
Prima di inserire l'autotrapianto nei tunnel ossei, tutti i frammenti osso-cartilaginei vengono rimossi dalla cavità articolare utilizzando una pinza artroscopica e un accurato lavaggio dell'articolazione.
L'innesto suturato viene inserito nei tunnel intraossei e fissato nel tunnel femorale con una vite a interferenza.
Dopo aver fissato l'estremità femorale del trapianto, l'articolazione viene lavata con antisettici per prevenire complicazioni purulente.
Successivamente, l'arto inferiore operato viene completamente esteso e fissato nel canale tibiale, necessariamente con l'articolazione del ginocchio in completa estensione. I fili vengono tirati lungo l'asse del canale, l'artroscopio viene inserito nel portale tibiale inferiore e, utilizzando un ago da maglia (se il tessuto osseo in quest'area è duro, viene inserito un ago a lama), si determina il punto e la direzione di fissazione della vite. Durante l'avvitamento della vite, lo spostamento del blocco osseo viene monitorato in base alla posizione e alla tensione dei fili, in modo che non venga spinto fuori dal canale nella cavità articolare. Nella fase successiva, utilizzando un artroscopio, si visualizza se il blocco osseo sporge nell'articolazione a causa del suo spostamento lungo l'asse del canale durante il serraggio della vite (pertanto, è preferibile utilizzare una vite autoserrante), quindi, utilizzando un artroscopio, si valuta il grado di adesione del blocco osseo alla parete del tunnel osseo, dopodiché la vite viene serrata completamente.
Se la lunghezza iniziale dell'autotrapianto con blocchi ossei supera i 10 cm, esiste un'alta probabilità che il blocco osseo sporga dal canale tibiale.
Per evitare dolori all'articolazione femoro-rotulea nel periodo postoperatorio, dopo la fissazione la parte sporgente del blocco osseo viene morsa.
Prima di chiudere con i tessuti molli, i bordi e gli angoli ossei sporgenti e affilati vengono levigati con una raspa, quindi i tessuti molli vengono suturati.
Successivamente, esaminare attentamente la zona della vite tibiale per verificare la presenza di sanguinamento; se necessario, eseguire un'emostasi completa mediante coagulazione.
Le radiografie di controllo in due proiezioni vengono eseguite direttamente in sala operatoria.
Le ferite vengono suturate strettamente a strati; non è consigliabile installare un drenaggio, poiché diventa una porta di ingresso per le infezioni; se necessario (comparsa di versamento nell'articolazione), il giorno successivo viene eseguita una puntura articolare.
All'arto operato viene applicato un tutore postoperatorio con bloccaggio 0-180°.
Dopo l'operazione, all'articolazione viene applicato un sistema freddo che riduce significativamente il numero di complicazioni, come edemi paraarticolari e versamenti articolari.
Per la prima volta in Russia, l'Istituto Centrale di Traumatologia e Ortopedia ha iniziato a utilizzare un metodo più universale per il fissaggio degli autoinnesti con perni in acido polilattico Rigidfix e la vite a interferenza Mi-La-Gro di ultima generazione per innesti con blocchi ossei. L'universalità del metodo risiede nella sua applicazione sia agli innesti di tessuti molli che agli innesti con blocchi ossei. I vantaggi del metodo sono l'assenza del rischio di danneggiare la parte di tessuto molle dell'autoinnesto con blocchi ossei al momento della fissazione, la fissazione rigida e l'assenza di problemi nella rimozione dei perni di fissaggio dovuti al loro riassorbimento. La rigidità della fissazione primaria e la perfetta aderenza dei blocchi ossei dell'innesto sono garantite dal rigonfiamento dei perni e dalla conseguente compressione.

