Esperto medico dell'articolo
Nuove pubblicazioni
Epilessia generalizzata e focale idiopatica
Ultima recensione: 12.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.
Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.
Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.
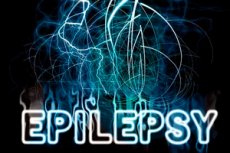
Malattia convulsiva, epilessia, sacra, lunare: ci sono molti nomi per la malattia che si manifesta con crisi periodiche spaventosamente inaspettate, durante le quali i pazienti cadono improvvisamente a terra, tremando per le convulsioni. Parleremo di epilessia, che la medicina moderna considera una malattia neurologica cronica progressiva, il cui segno specifico sono crisi non provocate e regolarmente ricorrenti, sia convulsive che non convulsive. Come risultato della malattia, possono svilupparsi particolari cambiamenti di personalità, che portano alla demenza e al completo distacco dalla vita in corso. Anche l'antico medico romano Claudio Galeno distinse due tipi di malattia: l'epilessia idiopatica, cioè ereditaria, primaria, i cui sintomi compaiono in età precoce, e secondaria (sintomatica), che si sviluppa più tardi, sotto l'influenza di determinati fattori. [ 1 ]
Nella classificazione aggiornata della International League Against Epilepsy, una delle sei categorie eziologiche identificate della malattia è quella genetica, ovvero una malattia primaria indipendente che comporta una predisposizione ereditaria o mutazioni genetiche insorte ex novo. In sostanza, si trattava dell'epilessia idiopatica nella precedente edizione. In questo caso, il paziente non presenta lesioni organiche delle strutture cerebrali che potrebbero causare crisi epilettiche ricorrenti periodicamente e non si osservano sintomi neurologici nel periodo interictale. Tra le forme note di epilessia, l'epilessia idiopatica ha la prognosi più favorevole. [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ]
Epidemiologia
Si stima che 50 milioni di persone in tutto il mondo soffrano di epilessia, la maggior parte delle quali non ha accesso all'assistenza sanitaria. [ 5 ], [ 6 ] Una revisione sistematica e una meta-analisi di studi in tutto il mondo hanno rilevato che la prevalenza puntuale dell'epilessia attiva era di 6,38 ogni 1000 persone e la prevalenza nel corso della vita era di 7,6 ogni 1000 persone. La prevalenza dell'epilessia non differiva tra i sessi o i gruppi di età. I tipi più comuni sono le crisi generalizzate e l'epilessia di eziologia sconosciuta. [ 7 ], [ 8 ]
In media, dallo 0,4 all'1% della popolazione mondiale necessita di un trattamento antiepilettico. Le statistiche sull'incidenza dell'epilessia nei paesi sviluppati registrano annualmente da 30 a 50 nuovi casi di sindromi epilettiche ogni 100.000 abitanti. Si presume che nei paesi con bassi livelli di sviluppo questa cifra sia doppia. Tra tutte le forme di epilessia, i casi di epilessia idiopatica rappresentano il 25-29%. [ 9 ]
Le cause epilessia idiopatica
La malattia si manifesta nella stragrande maggioranza dei casi in bambini e adolescenti. I pazienti non hanno una storia di malattie o lesioni pregresse che abbiano causato danni cerebrali. I moderni metodi di neuroimaging non determinano la presenza di alterazioni morfologiche nelle strutture cerebrali. La causa dell'epilessia idiopatica è considerata una predisposizione geneticamente ereditaria allo sviluppo della malattia (epilettogenicità cerebrale) e non un'ereditarietà diretta; i casi di epilessia sono semplicemente più comuni tra i parenti del paziente rispetto alla popolazione generale. [ 10 ]
Casi di epilessia idiopatica familiare sono rari, mentre la trasmissione autosomica dominante monogenica è attualmente determinata per cinque episindromi. Sono stati identificati geni la cui mutazione causa crisi epilettiche familiari benigne neonatali e infantili, epilessia generalizzata con convulsioni febbrili focali-frontali con crisi notturne e deficit uditivo. In altre episindromi, è presumibilmente ereditaria una tendenza allo sviluppo di un processo patologico. Ad esempio, alla sincronizzazione in tutte le gamme di frequenza dell'attività dei neuroni del cervello, chiamati epilettiche, ovvero dotate di una differenza di potenziale instabile sui lati interno ed esterno della loro membrana in uno stato di non eccitazione. In uno stato di eccitazione, il potenziale d'azione di un neurone epilettico supera significativamente la norma, il che porta allo sviluppo di una crisi epilettica, a seguito della quale le membrane cellulari dei neuroni soffrono sempre più e si forma uno scambio ionico patologico attraverso le membrane neuronali distrutte. Ciò determina un circolo vizioso: le crisi epilettiche, a seguito di ripetute scariche neurali iperintense, provocano profondi disturbi metabolici nelle cellule del tessuto cerebrale, che contribuiscono allo sviluppo della crisi successiva. [ 11 ]
Una caratteristica specifica di ogni epilessia è l'aggressività dei neuroni epilettici nei confronti delle cellule ancora inalterate del tessuto cerebrale, il che contribuisce alla diffusione diffusa dell'epilettogenicità e alla generalizzazione del processo.
Nell'epilessia idiopatica, la maggior parte dei pazienti presenta un'attività convulsiva generalizzata e non si riscontra alcun focus epilettico specifico. Attualmente sono noti diversi tipi di epilessie idiopatiche focali. [ 12 ]
Studi sull'epilessia mioclonica giovanile (CAE) hanno identificato i cromosomi 20q, 8q24.3 e 1p (la CAE è stata successivamente rinominata epilessia giovanile da assenza). Studi sull'epilessia mioclonica giovanile hanno dimostrato che i polimorfismi di suscettibilità BRD2 sul cromosoma 6p21.3 e Cx-36 sul cromosoma 15q14 sono associati a una maggiore suscettibilità all'epilessia mioclonica giovanile (JME).[ 13 ],[ 14 ],[ 15 ] Nonostante ciò, la mutazione genetica rimane rara quando a una persona viene diagnosticata l'epilessia.
Fattori di rischio
I fattori di rischio per lo sviluppo della malattia sono ipotetici. Il principale è la presenza di parenti stretti che hanno sofferto di epilessia. In questo caso, la probabilità di ammalarsi immediatamente aumenta di due o addirittura di quattro volte. La patogenesi dell'epilessia idiopatica deve ancora essere completamente chiarita. [ 16 ]
Si presume inoltre che il paziente possa ereditare una debolezza delle strutture che proteggono il cervello dalla sovraeccitazione. Si tratta dei segmenti del ponte, del nucleo cuneato o del nucleo caudato. Inoltre, lo sviluppo della malattia in una persona con predisposizione ereditaria può essere provocato da una patologia metabolica sistemica che porta a un aumento della concentrazione di ioni sodio o acetilcolina nei neuroni cerebrali. Le crisi epilettiche generalizzate possono svilupparsi in presenza di una carenza di vitamine del gruppo B, in particolare della vitamina B6. Gli epilettici hanno dimostrato una predisposizione alla neurogliosi (secondo studi patologici), ovvero una proliferazione eccessiva e diffusa di elementi gliali che sostituiscono i neuroni morti. Vengono periodicamente identificati altri fattori che provocano un aumento dell'eccitabilità e la comparsa di una predisposizione alle convulsioni.
Il fattore di rischio per lo sviluppo dell'epilessia genetica, come verrà ora chiamata, è la presenza di geni mutanti che provocano la patologia. Inoltre, la mutazione genetica non deve necessariamente essere ereditaria, può manifestarsi per la prima volta in un paziente specifico e si ritiene che il numero di questi casi sia in aumento.
Patogenesi
Il meccanismo di sviluppo dell'epilessia idiopatica si basa sulla reattività parossistica geneticamente determinata, ovvero sulla presenza di una comunità di neuroni con elettrogenesi alterata. Non si rilevano effetti dannosi esterni, né eventi che abbiano innescato l'insorgenza delle crisi. Tuttavia, la manifestazione della malattia si verifica in età diverse: in alcuni casi fin dalla nascita, in altri nella prima infanzia, in altri ancora nell'adolescenza e nella giovinezza, pertanto alcuni aspetti della patogenesi allo stadio attuale, a quanto pare, rimangono ancora sconosciuti.
Sintomi epilessia idiopatica
Il principale segno diagnostico della malattia è la presenza di crisi epilettiche, sia convulsive che non convulsive. In assenza di queste, tutti gli altri sintomi, come un elettroencefalogramma caratteristico, l'anamnesi, le caratteristiche cognitive e psicologiche del paziente, non sono sufficienti per stabilire la diagnosi di "epilessia". La manifestazione della malattia è solitamente associata alla prima crisi; quando si parla di epilessia, questa è la definizione più accurata. Un attacco è un termine più generale, che implica un improvviso e brusco peggioramento della salute di qualsiasi origine; una crisi è un caso particolare di attacco, la cui causa è una disfunzione transitoria del cervello o di una sua parte.
Gli epilettici possono manifestare vari disturbi dell'attività neuropsichiatrica: crisi convulsive maggiori e minori, disturbi mentali acuti e cronici (depressione, depersonalizzazione, allucinazioni, deliri), trasformazioni persistenti della personalità (inibizione, distacco).
Tuttavia, ripeto, i primi segni che permettono di diagnosticare l'epilessia sono le crisi convulsive. L'attacco più impressionante dell'epilessia idiopatica, impossibile da ignorare, è la sua manifestazione generalizzata: la crisi di grande male. Premetto subito che tutte le componenti del complesso sintomatologico che descriveremo di seguito non sono obbligatorie, nemmeno nella forma generalizzata. Un paziente specifico potrebbe presentare solo alcune delle manifestazioni.
Inoltre, solitamente alla vigilia di un attacco, si manifestano i primi sintomi. Il paziente inizia a sentirsi peggio, ad esempio, con un aumento del battito cardiaco, mal di testa, ansia immotivata, rabbia e irritabilità, eccitazione o depressione, malinconia e silenzio. Alla vigilia di un attacco, alcuni pazienti trascorrono la notte insonne. Di solito, col tempo, il paziente riesce già a intuire l'avvicinarsi di un attacco in base alle sue condizioni.
Lo sviluppo di una crisi epilettica si divide nelle seguenti fasi: aura, crisi tonico-cloniche e annebbiamento della coscienza.
L'aura si riferisce già all'inizio di una crisi epilettica e può manifestarsi con la comparsa di ogni sorta di sensazione: formicolio, dolore, tocchi caldi o freddi, una leggera brezza in diverse parti del corpo (sensoriali); lampi, abbagliamenti, fulmini, fuoco davanti agli occhi (allucinatori); sudorazione, brividi, vampate di calore, vertigini, secchezza delle fauci, emicrania, tosse, mancanza di respiro, ecc. (vegetativi). L'aura può manifestarsi in automatismi motori (motori): il paziente si lancia a correre da qualche parte, inizia a girare su se stesso, agitare le braccia, urlare. A volte vengono compiuti movimenti unilaterali (con la mano sinistra, la gamba sinistra, metà del corpo). L'aura mentale può manifestarsi in attacchi di ansia, derealizzazione, più complessi rispetto alle allucinazioni allucinatorie, uditive, sensoriali o visive. Potrebbe non esserci alcuna aura.
Poi si sviluppa immediatamente la seconda fase: la crisi vera e propria. Il paziente perde conoscenza, i muscoli del corpo si rilassano completamente (atonia), cade. La caduta avviene inaspettatamente per chi gli sta intorno (l'aura spesso non viene notata). Il più delle volte, la persona cade in avanti, un po' meno spesso all'indietro o di lato. Dopo la caduta, inizia la fase di tensione tonica: i muscoli di tutto il corpo o di una sua parte si irrigidiscono, il paziente si distende, la pressione sanguigna aumenta, la frequenza cardiaca accelera, le labbra diventano blu. La fase del tono muscolare dura circa mezzo minuto, poi iniziano contrazioni ritmiche e continue: la fase tonica viene sostituita da quella clonica, con movimenti intermittenti e caotici crescenti degli arti (flessione-estensione sempre più brusca), della testa, dei muscoli facciali, a volte degli occhi (rotazione, nistagmo). Gli spasmi mandibolari spesso portano a mordersi la lingua durante una crisi: una classica manifestazione dell'epilessia, nota a quasi tutti. L'ipersalivazione si manifesta con la formazione di schiuma alla bocca, spesso macchiata di sangue quando ci si morde la lingua. Gli spasmi clonici dei muscoli della laringe causano fenomeni sonori durante la crisi: muggiti, gemiti. Durante la crisi, i muscoli dello sfintere della vescica e dell'ano spesso si rilassano, il che porta a minzione e defecazione involontarie. Gli spasmi clonici durano uno o due minuti. Durante la crisi, il paziente non ha riflessi cutanei e tendinei. La fase tonico-clonica della crisi termina con un graduale rilassamento muscolare e la scomparsa dell'attività convulsiva. Inizialmente, il paziente è in uno stato di annebbiamento della coscienza: disorientamento, difficoltà di comunicazione (parla con difficoltà, dimentica le parole). Ha ancora tremori, alcuni spasmi muscolari, ma gradualmente tutto torna alla normalità. Dopo la crisi, il paziente si sente completamente esausto e di solito si addormenta per diverse ore; al risveglio, persistono sintomi astenici: debolezza, malessere, cattivo umore, problemi di vista.
L'epilessia idiopatica può manifestarsi anche con crisi minori. Queste includono assenze, semplici o tipiche. Le assenze atipiche complesse non sono caratteristiche dell'epilessia idiopatica. Quelle tipiche sono crisi generalizzate di breve durata durante le quali il paziente si blocca con lo sguardo fisso. La durata di un'assenza non supera solitamente un minuto, durante il quale la coscienza del paziente si spegne, non cade, ma lascia cadere tutto ciò che tiene in mano. Non ricorda l'attacco e spesso continua l'attività interrotta. Le assenze semplici si verificano senza aura e annebbiamento della coscienza dopo l'attacco, solitamente accompagnate da spasmi dei muscoli facciali, che coinvolgono principalmente le palpebre e la bocca e/o automatismi orali: schiocchi, masticazione, leccamento delle labbra. A volte si verificano assenze non convulsive, così brevi che il paziente non se ne accorge nemmeno. Il paziente lamenta che la sua vista si è improvvisamente oscurata. In questo caso, l'oggetto caduto dalle sue mani potrebbe essere l'unica prova di una crisi epilettica.
Crisi propulsive - annuire, beccare, "crisi salam" e altri movimenti della testa o di tutto il corpo, diretti in avanti, sono causati dall'indebolimento del tono posturale dei muscoli. I pazienti non cadono. Si riscontrano principalmente nei bambini di età inferiore ai quattro anni, più spesso nei maschi. Sono caratteristiche degli attacchi notturni della malattia. In età avanzata, vengono sostituite da crisi epilettiche più gravi.
Il mioclono è una rapida contrazione riflessa dei muscoli che si manifesta con spasmi muscolari. Le convulsioni possono essere osservate in tutto il corpo o interessare solo un determinato gruppo muscolare. Un elettroencefalogramma eseguito al momento di una crisi mioclonica mostra la presenza di scariche epilettiche.
Tonico – contrazioni prolungate di un qualsiasi gruppo muscolare o dell’intera muscolatura del corpo, durante le quali una determinata posizione viene mantenuta per lungo tempo.
Atonica: perdita frammentaria o completa del tono muscolare. L'atonia generalizzata con caduta e perdita di coscienza è talvolta l'unico sintomo di una crisi epilettica.
Le crisi convulsive sono spesso di natura mista: le assenze si combinano con crisi tonico-cloniche generalizzate, miocloniche con atoniche, ecc. Possono verificarsi anche forme non convulsive di crisi convulsive: coscienza crepuscolare con allucinazioni e delirio, vari automatismi e trance.
Forme
La stragrande maggioranza dei casi correlati all'epilessia idiopatica si manifesta nell'infanzia e nell'adolescenza. Questo gruppo include sindromi epilettiche che sono per lo più relativamente benigne, ovvero rispondono bene alla terapia o non ne richiedono affatto e non presentano conseguenze per lo stato neurologico, che è normale al di fuori delle crisi. Inoltre, in termini di sviluppo intellettivo, i bambini non sono in ritardo rispetto ai coetanei sani. Presentano un ritmo di base conservato all'elettroencefalogramma e i moderni metodi di neuroimaging non rilevano anomalie strutturali del cervello, sebbene ciò non significhi che non siano effettivamente presenti. Talvolta vengono rilevate in seguito e non è ancora chiaro se siano state "trascurate" o se abbiano provocato le crisi.
L'epilessia idiopatica ha un esordio dipendente dall'età e, in generale, una prognosi favorevole. Tuttavia, a volte una forma della malattia si trasforma in un'altra, ad esempio l'epilessia con assenze infantili in epilessia mioclonica giovanile. La probabilità di tale trasformazione e di crisi convulsive in età avanzata aumenta nei bambini i cui parenti stretti hanno sofferto di epilessia sia durante l'infanzia che in età adulta.
I tipi di epilessia idiopatica non sono definiti chiaramente, ci sono discrepanze nei classificatori, alcune forme non hanno criteri diagnostici rigorosi, come l'epilessia con assenze infantili.
Epilessia generalizzata idiopatica
La forma più precoce della malattia, con crisi epilettiche neonatali/infantili familiari benigne e non familiari, viene rilevata nei neonati a termine letteralmente il secondo o il terzo giorno dopo la nascita. Inoltre, i bambini nascono principalmente da donne che hanno portato a termine una gravidanza e partorito con successo senza complicazioni significative. L'età media di sviluppo delle forme familiari è di 6,5 mesi, quella non familiare di nove. Attualmente, sono stati identificati geni (braccio lungo dei cromosomi 8 e 20) la cui mutazione è associata allo sviluppo della forma familiare della malattia. Altri fattori scatenanti, a parte il fatto che ci fossero casi di crisi epilettiche nella storia familiare, sono assenti. In un neonato con questa forma della malattia, si osservano crisi epilettiche brevi, da uno a due minuti, molto frequenti (fino a 30 al giorno), generalizzate, focali o con l'aggiunta di crisi tonico-cloniche focali, accompagnate da episodi di apnea. [ 17 ]
L'epilessia mioclonica idiopatica dell'infanzia si manifesta nella maggior parte dei pazienti, a partire dall'età di quattro mesi fino a tre anni. È caratterizzata esclusivamente da mioclono con conservazione della coscienza, che si manifesta con una serie di propulsioni: rapidi movimenti del capo con abduzione dei bulbi oculari. In alcuni casi, le convulsioni si diffondono ai muscoli del cingolo scapolare. Se una crisi propulsiva inizia durante la deambulazione, si verifica una caduta fulminea. L'insorgenza di una crisi può essere provocata da un suono acuto, un tocco inaspettato e sgradevole, l'interruzione del sonno o il risveglio, in rari casi da fotostimolazione ritmica (guardare la TV, accendere/spegnere la luce).
L'epilessia infantile con crisi miocloniche-atoniche è un'altra forma di malattia idiopatica generalizzata (genetica). L'età di manifestazione è compresa tra i dieci mesi e i cinque anni. La maggior parte delle persone sviluppa immediatamente crisi generalizzate della durata di 30-120 secondi. Un sintomo specifico è il cosiddetto "calcio di ginocchio", conseguenza del mioclono degli arti, ovvero movimenti propulsivi del tronco. La coscienza è solitamente preservata durante una crisi. Il mioclono con componente atonica è spesso accompagnato da assenze tipiche, durante le quali la coscienza viene interrotta. Le assenze si osservano al mattino dopo il risveglio, hanno un'elevata frequenza e sono talvolta integrate da una componente mioclonica. Inoltre, circa un terzo dei bambini con epilessia miocloniche-atonica generalizzata sviluppa anche crisi motorie parziali. In questo caso, la prognosi peggiora, soprattutto nei casi in cui si osservano molto spesso. Questo potrebbe essere un segno dello sviluppo della sindrome di Lennox-Gastaut.
L'epilessia idiopatica generalizzata nei bambini comprende anche le forme di assenza della malattia.
L'epilessia con assenza dell'infanzia si manifesta nei primi quattro anni di vita ed è più comune nei bambini di sesso maschile. Si manifesta principalmente con assenze semplici. In circa 2/5 casi, le assenze sono associate a componenti miocloniche e/o astatiche. In 2/3 dei casi, la malattia esordisce con crisi tonico-cloniche generalizzate. I bambini possono presentare un certo ritardo dello sviluppo.
La picnolessia (epilessia con assenze infantili) si manifesta più frequentemente nei bambini dai cinque ai sette anni, con una maggiore predisposizione delle femmine. È caratterizzata da un'improvvisa perdita di coscienza o da un significativo stato confusionale della durata di 2-30 secondi e da una ripetizione molto frequente di crisi epilettiche, che possono essere circa un centinaio al giorno. Le manifestazioni motorie delle crisi epilettiche sono minime o del tutto assenti, ma se le assenze tipiche sono precedute da un'aura e si osserva un offuscamento della coscienza post-crisi, tali crisi sono classificate come pseudo-assenze.
La picnolessia può causare assenze atipiche con varie componenti: mioclono, convulsioni toniche, stati atonici, a volte si osservano automatismi. Vari eventi possono stimolare un aumento della frequenza delle crisi: risvegli improvvisi, respiro accelerato, bruschi cambiamenti di illuminazione. In un terzo dei pazienti, crisi convulsive generalizzate possono manifestarsi nel secondo o terzo anno di malattia.
L'epilessia giovanile con assenza si sviluppa nell'adolescenza e nella giovinezza (dai nove ai ventuno anni), esordisce con assenze in circa la metà dei casi e può esordire con crisi convulsive generalizzate, che spesso si verificano al momento dell'interruzione del sonno, del risveglio o dell'addormentamento. La frequenza delle crisi è di una ogni due o tre giorni. Il fattore stimolante per lo sviluppo dell'assenza è l'iperventilazione. Gli stati di assenza sono accompagnati da contrazioni dei muscoli facciali o da automatismi faringei e orali. Nel 15% dei pazienti, anche i parenti stretti soffrivano di epilessia giovanile con assenza.
L'epilessia con assenze miocloniche (sindrome di Tassinari) si distingue separatamente. Si manifesta da uno a sette anni ed è caratterizzata da frequenti assenze, soprattutto al mattino, associate a massicce contrazioni muscolari del cingolo scapolare e degli arti superiori (mioclono). La fotosensibilità non è tipica di questa forma; la causa scatenante dell'attacco è l'iperventilazione. Nella metà dei bambini affetti, si osservano disturbi neurologici, associati a comportamento iperattivo e calo dell'intelligenza.
L'epilessia generalizzata idiopatica negli adulti rappresenta circa il 10% di tutti i casi di epilessia in età adulta. Gli esperti ritengono che tali riscontri diagnostici in pazienti di età superiore ai 20 e persino ai 30 anni siano il risultato di una diagnosi tardiva, dovuta al fatto che i pazienti e i loro familiari hanno ignorato assenze e crisi miocloniche nell'infanzia, la cui recidiva si è verificata per un lungo periodo di tempo (oltre 5 anni). Si presume inoltre che una manifestazione insolitamente tardiva della malattia possa verificarsi molto raramente.
Inoltre, le cause delle manifestazioni tardive della malattia sono indicate come diagnosi errata e terapia inadeguata associata, resistenza alla terapia adeguata delle crisi epilettiche, ricadute dell'epilessia idiopatica dopo l'interruzione del trattamento.
Epilessia focale idiopatica
In questo caso, il sintomo principale e spesso unico della malattia sono le crisi epilettiche parziali (localizzate, focali). In alcune forme di questa malattia, sono stati mappati i geni associati a ciascuna di esse. Si tratta dell'epilessia occipitale idiopatica, delle crisi parziali con crisi affettive, dell'epilessia temporale familiare e dell'epilessia essenziale della lettura.
In altri casi, si sa solo che l'epilessia idiopatica localizzata si verifica a causa di mutazioni genetiche, ma i geni esatti responsabili non sono stati identificati. Si tratta dell'epilessia notturna autosomica dominante del lobo frontale e dell'epilessia focale con sintomi uditivi.
La malattia localizzata più comune è l'epilessia rolandica (il 15% di tutti i casi di epilessia si manifesta prima dei 15 anni). La malattia si manifesta nei bambini dai 3 ai 14 anni, con un picco tra i 5 e gli 8 anni. Un segno diagnostico caratteristico sono i cosiddetti "picchi rolandici", complessi elettroencefalografici registrati nel periodo intraictale (interictale). Sono anche chiamati parossismi epilettici benigni dell'infanzia. La localizzazione dei focolai epilettici in questa forma di epilessia è nella regione peri-rolandica del cervello e nelle sue regioni inferiori. L'epilessia rolandica si sviluppa nella maggior parte dei casi in bambini con uno stato neurologico normale (idiopatica), ma sono possibili anche casi sintomatici, quando vengono rilevate lesioni organiche del sistema nervoso centrale.
Nella stragrande maggioranza dei pazienti (fino all'80%), la malattia si manifesta principalmente con rare (due o tre volte al mese) crisi focali semplici che iniziano durante il sonno. Al risveglio o durante una crisi durante il giorno, i pazienti notano che inizia con un'aura somatosensoriale - parestesie unilaterali che coinvolgono la cavità orale (lingua, gengive) o la faringe. Successivamente si sviluppa una crisi focale. Contrazioni convulsive dei muscoli facciali si verificano nel 37% dei casi, dei muscoli della bocca e della faringe nel 53%, accompagnate da grave ipersalivazione. Durante il sonno, i pazienti vocalizzano - suoni gorgoglianti e brontolanti. In un quinto dei pazienti, i muscoli della spalla e del braccio sono coinvolti nelle contrazioni muscolari (crisi brachiofasciali) e due volte più raramente possono estendersi agli arti inferiori (monolaterali). Nel tempo, la localizzazione delle contrazioni muscolari può cambiare, spostandosi all'altro lato del corpo. Talvolta, in circa un quarto dei casi, più spesso nei bambini più piccoli, le crisi epilettiche generalizzate secondarie si sviluppano durante il sonno. Fino all'età di 15 anni, il 97% dei pazienti raggiunge una remissione terapeutica completa.
Molto meno comune è l'epilessia occipitale idiopatica a esordio tardivo (tipo Gastaut). Si tratta di una malattia distinta, che si manifesta dai tre ai 15 anni, con un picco all'età di otto anni. Le crisi non convulsive si verificano frequentemente, espresse in allucinazioni visive elementari che si sviluppano rapidamente e durano da pochi secondi a tre minuti, più spesso durante il giorno o dopo il risveglio. In media, la frequenza delle crisi è di una volta a settimana. Nella stragrande maggioranza dei casi, il paziente non riesce a stabilire contatti durante lo stato parossistico. Le crisi possono progredire con la comparsa di sintomi come ammiccamento, illusioni di dolore, cecità. Il vomito è raro. Può essere accompagnato da cefalea. Alcuni sviluppano allucinazioni visive complesse, altri sintomi e una crisi generalizzata secondaria. Entro i 15 anni, l'82% dei pazienti a cui viene diagnosticata la sindrome di Gastaut raggiunge la remissione terapeutica.
La sindrome di Panagiotopoulos si distingue anche come una variante della forma precedente. Si verifica dieci volte più frequentemente della classica sindrome di Gastaut. L'epilessia occipitale idiopatica di questo tipo può avere un esordio precoce. Il picco di manifestazione si verifica tra i 3 e i 6 anni, ma la sindrome può svilupparsi in un bambino di un anno e in uno di otto anni. Inoltre, il rischio più elevato di crisi epilettiche ripetute è associato a un esordio più precoce. Si presume che alcuni casi non vengano diagnosticati, poiché gli attacchi presentano principalmente manifestazioni vegetative, con il sintomo dominante rappresentato da un attacco di vomito. La coscienza del bambino non è compromessa, lamenta cattive condizioni di salute e forte nausea, che si risolve con vomito grave e altre manifestazioni fino a perdita di coscienza e convulsioni. Un'altra forma di crisi epilettiche della sindrome di Panagiotopoulos è la sincope o lo svenimento. Lo svenimento si manifesta con componenti toniche o miocloniche, talvolta con incontinenza urinaria e fecale, e si conclude con uno stato di astenia e sonno. Le crisi sono lunghe, da mezz'ora a sette ore, e di solito iniziano di notte. La frequenza è bassa. Talvolta si verifica una sola crisi durante l'intero periodo della malattia. Nel 92% dei pazienti, la remissione della sindrome di Panayopoulos si osserva fino a 9 anni.
Si presume che l'epilessia infantile benigna con crisi affettive (sindrome di Dall-Bernardine) sia anch'essa una variante dell'epilessia occipitale o rolandica. L'esordio si registra tra i due e i nove anni. Le crisi si manifestano con attacchi di terrore, pianto, urla, con manifestazioni di pallore, aumento della sudorazione, salivazione, dolore addominale, automatismi e confusione. Le crisi si sviluppano spesso nel sonno, subito dopo essersi addormentati, ma possono verificarsi anche durante il giorno. Si verificano spontaneamente, durante conversazioni o qualsiasi attività senza stimolazione visibile. Nella maggior parte dei casi, la remissione si verifica prima dei 18 anni.
Le forme di epilessia idiopatica parziale sopra descritte si manifestano solo durante l'infanzia. Le altre possono svilupparsi in qualsiasi momento.
L'epilessia idiopatica localizzata fotosensibile si riferisce alle manifestazioni dell'occipitale. Le crisi sono identiche a quelle spontanee, possono essere integrate da sintomi vegetativi e talvolta evolvere in crisi tonico-cloniche generalizzate secondarie. Il fattore che ne provoca l'insorgenza è la frequente esposizione a luci lampeggianti; in particolare, le crisi si verificano spesso durante i videogiochi o la visione della TV. Si manifestano tra i 15 mesi e i 19 anni.
L'epilessia parziale idiopatica con sintomi uditivi (temporale laterale, familiare) inizia con la comparsa di un'aura con fenomeni uditivi. Il paziente percepisce colpi, fruscii, sibili, tintinnii, altri suoni intrusivi, allucinazioni uditive complesse (musica, canto), sullo sfondo delle quali può svilupparsi una crisi epilettica secondariamente generalizzata. La manifestazione si verifica tra i tre e i 51 anni. Una caratteristica di questa forma è la scarsa frequenza delle crisi e una prognosi favorevole.
L'epilessia parziale idiopatica con crisi pseudogeneralizzate, ovvero assenze atipiche, crisi atoniche e mioclono palpebrale in combinazione con crisi motorie parziali, può assomigliare alle encefalopatie epilettiche all'elettroencefalogramma. Tuttavia, nei bambini non si riscontrano deficit neurologici e le tecniche di neuroimaging non rivelano difetti strutturali.
Esiste anche un'epilessia frontale autosomica dominante familiare geneticamente determinata con parossismi notturni. L'intervallo di tempo di insorgenza è molto ampio, le crisi possono svilupparsi da due a 56 anni; la sua prevalenza esatta è sconosciuta, ma il numero di famiglie è in crescita in tutto il mondo. Le crisi ipermotorie si verificano quasi ogni notte. La loro durata varia da mezz'ora a 50 minuti. Spesso si aggiungono convulsioni cloniche: i pazienti, riprendendo i sensi, si ritrovano sdraiati sul pavimento o in una posizione o luogo insolito. Al momento della crisi, si verifica un brusco risveglio, la coscienza è preservata, dopo la crisi il paziente si riaddormenta. L'insorgenza di una crisi è sempre associata al sonno: prima, durante o dopo. Le crisi sono solitamente permanenti, diventando meno frequenti in età avanzata.
Epilessia da lettura (grafogena, indotta dal linguaggio), una rara forma idiopatica. L'esordio avviene nella tarda adolescenza (12-19 anni) ed è molto più comune tra i ragazzi adolescenti. La crisi inizia subito dopo l'inizio della lettura, della scrittura o del linguaggio: lo stimolo provocatorio è il linguaggio, non solo scritto ma anche orale. Si verifica un breve mioclono, in cui sono coinvolti i muscoli della bocca e della laringe. Se il paziente continua a leggere, la crisi spesso si sviluppa ulteriormente in crisi tonico-cloniche generalizzate. In rari casi, possono comparire allucinazioni visive. Possono verificarsi crisi lunghe con disturbi del linguaggio. Se il comportamento del paziente è strutturato correttamente, non si sviluppano crisi gravi. Una forma prognosticamente favorevole.
Complicazioni e conseguenze
L'epilessia idiopatica legata all'età è generalmente curabile e talvolta non richiede alcun trattamento e non presenta conseguenze. Tuttavia, non vale la pena ignorarne i sintomi e sperare che la malattia si risolva spontaneamente. L'attività epilettiforme, soprattutto durante l'infanzia e l'adolescenza, quando il cervello matura e si sviluppa la personalità, è una delle cause dello sviluppo di alcuni deficit neurologici, che portano al deterioramento delle capacità cognitive e complicano l'adattamento sociale futuro. Inoltre, in alcuni pazienti, le crisi epilettiche si trasformano e si osservano già in età adulta, riducendo significativamente la loro qualità di vita. Tali casi sono associati sia alla predisposizione ereditaria che all'interruzione precoce del trattamento o alla sua assenza.
Inoltre, le encefalopatie epilettiche possono manifestarsi anche in età infantile, i cui sintomi spesso assomigliano a quelli delle forme idiopatiche benigne nella fase iniziale. Pertanto, è urgente un esame approfondito del paziente e il successivo trattamento.
Diagnostica epilessia idiopatica
Il criterio diagnostico per questa malattia è la presenza di crisi epilettiche. In questo caso, il paziente deve essere sottoposto a un esame completo. Oltre a un'accurata raccolta anamnestica non solo del paziente stesso, ma anche della famiglia, vengono eseguiti esami di laboratorio e test di laboratorio. Attualmente è impossibile stabilire una diagnosi di epilessia con metodi di laboratorio, ma gli esami clinici sono obbligatori per accertare lo stato di salute generale del paziente.
Inoltre, per determinare l'origine delle crisi, viene prescritta la diagnostica strumentale. Il principale metodo hardware è l'elettroencefalografia nel periodo interictale e, se possibile, durante le crisi. La decodifica dell'elettroencefalogramma viene eseguita secondo i criteri ILAE (International League Against Epileptics).
Viene utilizzato anche il monitoraggio video, che consente di osservare crisi di breve durata, la cui insorgenza è molto difficile da prevedere o stimolare.
L'epilessia idiopatica viene diagnosticata in assenza di danni organici alle strutture cerebrali, per i quali vengono utilizzati moderni metodi di neuroimaging: risonanza magnetica e computerizzata. L'elettrocardiografia e l'ecocardiografia vengono prescritte per valutare la funzione cardiaca, spesso in dinamica e sotto carico. La pressione sanguigna viene monitorata regolarmente. [ 18 ]
Al paziente viene inoltre prescritta una visita neuropsicologica, otoneurologica e neuro-oftalmologica; altri esami potranno essere prescritti secondo le indicazioni.
Diagnosi differenziale
La diagnosi differenziale dell'epilessia idiopatica è piuttosto complessa. In primo luogo, in questo caso, le trasformazioni strutturali della materia cerebrale non vengono rilevate; in secondo luogo, l'età di manifestazione spesso non consente di interrogare il paziente; in terzo luogo, le crisi epilettiche sono spesso mascherate da svenimenti, crisi psicogene, disturbi del sonno e altri sintomi causati da malattie neurologiche e somatiche.
Le crisi epilettiche si distinguono da diverse condizioni: crisi vegetative e psicogene, miodistonia, mioplegia parossistica, sincope, crisi epilettiformi in accidenti cerebrovascolari acuti, disturbi del sonno, ecc. Bisogna essere allertati dalla presenza di un fattore che provoca un attacco, come la posizione eretta, l'eccesso di cibo, un bagno caldo, l'afa; una componente emotiva pronunciata; un quadro clinico e una durata anomali; l'assenza di alcuni sintomi, ad esempio l'annebbiamento della coscienza e del sonno nel periodo post-crisi, l'assenza di parenti stretti affetti da epilessia e altre incongruenze. Data la gravità della malattia e la tossicità degli anticonvulsivanti, non solo la prognosi per la guarigione, ma anche la vita del paziente dipendono spesso dalla diagnosi corretta. [ 19 ]
Chi contattare?
Trattamento epilessia idiopatica
In sostanza, diverse forme di epilessia idiopatica richiedono una terapia farmacologica a lungo termine per ottenere una remissione duratura e l'assenza di ricadute, soprattutto nei casi di epilessia giovanile assente e mioclonica. In alcuni casi, è necessario assumere farmaci per tutta la vita. Sebbene, ad esempio, le crisi neonatali familiari benigne siano nella maggior parte dei casi autolimitanti, la terapia anticonvulsivante non è sempre considerata giustificata; tuttavia, a volte il trattamento farmacologico viene prescritto per brevi cicli. In ogni caso, la questione dell'appropriatezza, della scelta del farmaco e della durata del trattamento deve essere valutata individualmente dal medico dopo un'accurata visita medica del paziente.
Nell'epilessia generalizzata idiopatica (varie forme, compresi gli spasmi infantili), così come nelle crisi focali, i valproati si sono dimostrati i più efficaci. Con la monoterapia con il farmaco, l'effetto del trattamento viene raggiunto nel 75% dei casi. Può essere utilizzato in combinazione con altri anticonvulsivanti. [ 20 ]
I farmaci a base del principio attivo valproato di sodio (acido valproico), come Depakine o Convulex, prevengono lo sviluppo delle tipiche crisi di assenza, nonché delle crisi miocloniche, tonico-cloniche e atoniche. Eliminano la fotostimolazione e correggono le deviazioni comportamentali e cognitive nei pazienti con epilessia. L'effetto anticonvulsivante dei valproati si esplica presumibilmente in due modi. Il principale, dose-dipendente, è un aumento diretto della concentrazione del principio attivo nel sangue e, di conseguenza, nel tessuto cerebrale, che contribuisce all'aumento del contenuto di acido γ-amminobutirrico, attivando i processi di inibizione. Il secondo, ulteriore meccanismo d'azione, può ipoteticamente essere associato all'accumulo di metaboliti del valproato di sodio nei tessuti cerebrali o ad alterazioni dei neurotrasmettitori. È possibile che il farmaco abbia un effetto diretto sulle membrane dei neuroni. Controindicato in caso di ipersensibilità ai derivati dell'acido valproico, pazienti con epatite cronica anche in anamnesi familiare e porfiria epatica, con deficit di enzimi coinvolti nella scomposizione dei componenti ausiliari del farmaco. Lo sviluppo di un'ampia gamma di effetti collaterali è inoltre dose-dipendente. Possono verificarsi reazioni avverse a carico dell'emopoiesi, del sistema nervoso centrale, degli organi digestivi ed escretori, del sistema immunitario. L'acido valproico ha proprietà teratogene. La terapia di associazione con lamotrigina non è raccomandata a causa dell'elevato rischio di sviluppare dermatite allergica fino alla sindrome di Lyell. L'associazione di valproati con preparazioni erboristiche contenenti iperico è controindicata. Questi farmaci devono essere associati con cautela a farmaci neuropsicotropi, se necessario, aggiustandone la dose. [ 21 ]
Il clonazepam, che potenzia gli effetti inibitori dell'acido γ-amminobutirrico, è un rimedio efficace per le crisi generalizzate di tutti i tipi. Viene utilizzato in cicli di trattamento brevi e a basse dosi terapeuticamente efficaci. I cicli prolungati nell'epilessia idiopatica sono indesiderabili, l'uso del farmaco è limitato dagli effetti collaterali (inclusi quelli paradossi - aumento delle crisi e delle convulsioni), nonché da un rapido sviluppo di dipendenza. Controindicato nei pazienti inclini ad arresto respiratorio durante il sonno, debolezza muscolare e annebbiamento della coscienza. Non prescritto a soggetti sensibilizzati e a pazienti con grave insufficienza epatica/renale. Ha proprietà teratogene.
La lamotrigina aiuta a controllare le crisi di assenza generalizzate e le crisi tonico-cloniche. Il farmaco non è solitamente prescritto per controllare le crisi miocloniche a causa dell'imprevedibilità della sua azione. Il principale effetto anticonvulsivante del farmaco è associato alla capacità di bloccare il flusso di ioni sodio attraverso i canali delle membrane presinaptiche dei neuroni, rallentando così il rilascio eccessivo di neurotrasmettitori eccitatori, principalmente l'acido glutammico, il più comune e significativo nello sviluppo delle crisi epilettiche. Ulteriori effetti sono associati all'impatto sui canali del calcio, sul GABA e sui meccanismi serotoninergici.
La lamotrigina ha effetti collaterali meno significativi rispetto ai classici anticonvulsivanti. Il suo uso è consentito, se necessario, anche nelle pazienti in gravidanza. È considerata il farmaco di scelta per l'epilessia idiopatica generalizzata e focale.
L'etosuccimide è il farmaco di scelta per le assenze semplici (epilessia infantile). Tuttavia, è meno efficace per il mioclono e non ha praticamente alcun controllo sulle crisi tonico-cloniche generalizzate. Pertanto, non è più prescritto per l'epilessia giovanile con un alto rischio di sviluppare crisi tonico-cloniche generalizzate. Gli effetti collaterali più comuni sono limitati a sintomi dispeptici, rash cutaneo e mal di testa; tuttavia, a volte si possono osservare alterazioni del quadro ematico e tremore degli arti. In rari casi, si sviluppano effetti paradossi: crisi epilettiche maggiori.
Il nuovo anticonvulsivante Topiramato, un derivato del fruttosio, è raccomandato anche per il controllo delle crisi generalizzate e locali dell'epilessia idiopatica. A differenza della Lamotrigina e degli anticonvulsivanti classici, non è in grado di alleviare i sintomi affettivi. Il farmaco è ancora in fase di studio, ma il controllo delle crisi epilettiche è già stato dimostrato. Il suo meccanismo d'azione si basa sul blocco dei canali del sodio potenziale-dipendenti, che inibisce la comparsa di potenziali di eccitazione ripetuti. Promuove inoltre l'attivazione del mediatore inibitorio acido γ-amminobutirrico. Non ci sono ancora informazioni sulla comparsa di dipendenza durante l'assunzione di Topiramato. È controindicato nei bambini di età inferiore ai sei anni, nelle donne in gravidanza e in allattamento e anche nei soggetti ipersensibili ai componenti del farmaco. Il Topiramato ha molti effetti collaterali, come altri farmaci con azione anticonvulsivante centrale.
Un altro nuovo farmaco utilizzato nel trattamento dell'epilessia idiopatica è il Levetiracetam. Il suo meccanismo d'azione è poco compreso, ma il farmaco non blocca i canali del sodio e del calcio T e non potenzia la trasmissione GABAergica. Si presume che l'effetto anticonvulsivante si realizzi quando il principio attivo si lega alla proteina vescicolare sinaptica SV2A. Il Levetiracetam mostra anche moderati effetti ansiolitici e antimaniacali.
Negli studi clinici in corso, il farmaco si è dimostrato efficace nel controllo delle crisi parziali e come farmaco aggiuntivo nella terapia complessa delle crisi miocloniche generalizzate e tonico-cloniche. Tuttavia, gli studi sull'effetto antiepilettico del levetiracetam continueranno.
Oggi, i farmaci di scelta per il trattamento dell'epilessia generalizzata idiopatica con crisi di assenza sono la monoterapia di prima linea con valproati, etosuccimide, lamotrigina o una combinazione di valproati ed etosuccimide. I farmaci di seconda linea per la monoterapia sono topiramato, clonazepam e levetiracetam. Nei casi resistenti, si utilizza la politerapia. [ 22 ]
Si raccomanda di trattare l'epilessia generalizzata idiopatica con crisi miocloniche come segue: prima linea: valproato o levetiracetam; seconda linea: topiramato o clonazepam; terza linea: piracetam o politerapia.
Le crisi tonico-cloniche generalizzate vengono trattate con monoterapia con valproati, topiramato, lamotrigina; i farmaci di seconda linea sono barbiturici, clonazepam, carbamazepina; politerapia.
Nell'epilessia idiopatica generalizzata è preferibile evitare di prescrivere i classici farmaci anticonvulsivanti (carbamazepina, apabentina, fenitoina e altri) che possono aumentare la frequenza delle crisi fino allo sviluppo dello stato epilettico.
Si raccomanda comunque il controllo delle crisi focali con farmaci classici a base di carbamazepina, fenitoina o valproati. In caso di epilessia rolandica, si ricorre alla monoterapia, prescrivendo anticonvulsivanti al dosaggio minimo efficace (valproati, carbamazepine, difenina). Non si ricorre alla terapia complessa e ai barbiturici.
Nelle epilessie parziali idiopatiche, i disturbi intellettivi e della memoria sono solitamente assenti, pertanto gli specialisti non ritengono giustificata una politerapia antiepilettica aggressiva. Viene utilizzata la monoterapia con anticonvulsivanti classici.
La durata della terapia, la frequenza di somministrazione e le dosi sono determinate individualmente. Si raccomanda di prescrivere il trattamento farmacologico solo dopo una crisi ripetuta e, a due anni dall'ultima, si può già prendere in considerazione la sospensione del farmaco.
Nella patogenesi delle crisi convulsive, si riscontra spesso una carenza di vitamine del gruppo B, in particolare B1 e B6, di selenio e magnesio. Nei pazienti sottoposti a terapia anticonvulsivante, diminuisce anche il contenuto di vitamine e componenti minerali, come la biotina (B7) o la vitamina E. Con l'assunzione di valproati, la levocarnitina riduce l'attività convulsiva. Può svilupparsi una carenza di vitamina D, che causa malassorbimento del calcio e fragilità ossea. Nei neonati, le crisi convulsive possono essere causate da carenza di acido folico; se la madre ha assunto anticonvulsivanti, può svilupparsi una carenza di vitamina K, che compromette la coagulazione del sangue. Vitamine e minerali possono essere necessari per l'epilessia idiopatica, tuttavia, l'opportunità del loro utilizzo è valutata dal medico. L'uso incontrollato può portare a conseguenze indesiderate e aggravare il decorso della malattia. [ 23 ]
La fisioterapia non viene utilizzata per le crisi epilettiche in corso. Fisioterapia, esercizi terapeutici e massaggi vengono prescritti dopo sei mesi dall'inizio della remissione. Nel periodo di riabilitazione precoce (da sei mesi a due anni), vengono utilizzati vari tipi di intervento fisico, ad eccezione di tutti gli interventi sulla zona della testa, idromassaggio, fangoterapia, stimolazione elettrica cutanea dei muscoli e proiezioni dei nervi periferici. In caso di remissione superiore a 2 anni, le misure riabilitative dopo il trattamento dell'epilessia idiopatica includono l'intera gamma di procedure fisioterapiche. In alcuni casi, ad esempio se l'elettroencefalogramma mostra segni di attività epilettiforme, la possibilità di ricorrere alla fisioterapia viene valutata individualmente. Le procedure vengono prescritte tenendo conto del sintomo patologico principale.
Rimedi popolari
L'epilessia è una malattia molto grave e trattarla con rimedi popolari oggigiorno, quando sono comparsi farmaci che controllano le crisi, è quantomeno irragionevole. È possibile utilizzare rimedi popolari, ma solo dopo aver ottenuto l'approvazione del medico. Purtroppo, non possono sostituire farmaci accuratamente selezionati e, inoltre, possono ridurne l'efficacia.
Probabilmente è abbastanza sicuro fare un bagno con un decotto di fieno ricavato da erbe che crescevano nella foresta. Era così che venivano curati gli epilettici un tempo.
Un altro metodo popolare che può essere sperimentato in estate, per chi vive in città, ad esempio, in dacia. Si consiglia di uscire la mattina presto, prima che la rugiada mattutina si sia asciugata, e stendere sull'erba un grande asciugamano, un lenzuolo o una coperta di tessuto naturale (cotone o lino). Dovrebbe essere imbevuto di rugiada. Quindi avvolgere il paziente nel telo, sdraiarlo o farlo sedere, non rimuoverlo finché non si asciuga sul suo corpo (il metodo può causare ipotermia e raffreddori).
L'aroma della resina dell'albero di mirra (mirra) ha un effetto molto benefico sul sistema nervoso. Si credeva che un paziente epilettico dovesse inalare l'aroma di mirra 24 ore su 24 per un mese. Per farlo, è possibile riempire una lampada aromatica con olio di mirra (poche gocce) o portare pezzi di resina dalla chiesa e spargerne una sospensione nella stanza del paziente. Tenete presente che qualsiasi odore può causare una reazione allergica.
Bere succhi freschi spremuti colmerà la carenza di vitamine e microelementi durante il periodo di assunzione di farmaci anticonvulsivanti.
Si consiglia il succo di ciliegia fresco, un terzo di bicchiere due volte al giorno. Questa bevanda ha effetti antinfiammatori e battericidi, lenisce, allevia gli spasmi vascolari ed è un anestetico. È in grado di legare i radicali liberi. Migliora la composizione del sangue, previene lo sviluppo di anemia ed elimina le tossine. Il succo di ciliegia è uno dei più salutari, contiene vitamine del gruppo B, tra cui acido folico e nicotinico, vitamine A ed E, acido ascorbico, ferro, magnesio, potassio, calcio, zuccheri, pectine e molte altre sostanze preziose.
Inoltre, come tonico generale, si può assumere il succo di germogli d'avena verdi e delle loro spighette nella fase di maturazione lattiginosa. Questo succo, come altri, si beve prima dei pasti, un terzo di bicchiere due o tre volte al giorno. I germogli d'avena giovani hanno una composizione molto preziosa: vitamine A, B, C, E, enzimi, ferro e magnesio. Il succo purifica il sangue e ne ripristina la composizione, rafforza il sistema immunitario e normalizza il metabolismo.
Dalle piante medicinali si possono anche ricavare decotti, infusi e tisane, utili per rafforzare il sistema immunitario, il sistema nervoso e l'organismo nel suo complesso. I trattamenti a base di erbe non possono sostituire gli anticonvulsivanti, ma possono integrarne l'effetto. Si utilizzano piante con proprietà calmanti: peonia, erba cardiaca e valeriana. L'iperico, secondo i guaritori tradizionali, può ridurre la frequenza delle crisi convulsive e l'ansia. È un ansiolitico naturale, tuttavia non è compatibile con i valproati.
L'infuso di fiori di arnica montana si assume in una dose singola di 2-3 cucchiai prima dei pasti, da tre a cinque volte al giorno. Lasciare in infusione un cucchiaio di fiori secchi, versare in un bicchiere di acqua bollente e lasciare riposare per un'ora o due. Quindi filtrare.
I rizomi di angelica vengono essiccati, tritati e assunti come infuso di mezzo bicchiere prima dei pasti, tre o quattro volte al giorno. La dose giornaliera si prepara come segue: 400 ml di acqua bollente vengono versati su due cucchiai di materiale vegetale. Dopo due o tre ore, l'infuso viene filtrato e bevuto caldo, riscaldandolo leggermente ogni volta prima di ingerirlo.
Omeopatia
Il trattamento omeopatico dell'epilessia idiopatica deve essere supervisionato da un medico omeopata. Esistono rimedi omeopatici per il trattamento di questa malattia: Belladonna.
La belladonna viene utilizzata per le crisi atoniche e le convulsioni; il farmaco può essere efficace anche per l'epilessia parziale con sintomi uditivi.
Bufo rana è efficace per bloccare le crisi notturne, indipendentemente dal fatto che il paziente si svegli o meno, e Cocculus indicus è efficace per bloccare le crisi che si verificano al mattino al risveglio.
Mercurius e Laurocerasus sono indicati per le crisi con componente atonica e le convulsioni tonico-cloniche.
Esistono molti altri farmaci utilizzati nel trattamento delle sindromi epilettiche. Quando si prescrivono farmaci omeopatici, si tiene conto non solo dei sintomi principali della malattia, ma anche della costituzione, delle abitudini, dei tratti caratteriali e delle preferenze del paziente.
Inoltre, l'omeopatia può aiutare a riprendersi in modo rapido ed efficace dopo un ciclo di trattamento con anticonvulsivanti.
Trattamento chirurgico
Un metodo radicale per il trattamento dell'epilessia è l'intervento chirurgico. Viene eseguito in caso di resistenza alla terapia farmacologica, crisi focali frequenti e gravi che causano danni irreparabili alla salute dei pazienti e complicano significativamente la loro vita sociale. Nell'epilessia idiopatica, il trattamento chirurgico viene eseguito solo in rari casi, poiché risponde bene alla terapia conservativa.
Gli interventi chirurgici sono altamente efficaci. Talvolta il trattamento chirurgico viene eseguito nella prima infanzia e consente di evitare il deterioramento cognitivo.
L'esame preoperatorio è di fondamentale importanza per stabilire una reale farmacoresistenza. Successivamente, la localizzazione del focolaio epilettogeno e l'entità dell'intervento chirurgico vengono determinati con la massima precisione possibile. Le aree epilettogene della corteccia cerebrale nell'epilessia focale vengono rimosse o disconnesse mediante incisioni multiple. Nell'epilessia generalizzata, si raccomanda l'emisferotomia, una procedura chirurgica che determina l'interruzione degli impulsi patologici che causano crisi epilettiche tra gli emisferi cerebrali.
Viene inoltre impiantato nella zona della clavicola uno stimolatore che agisce sul nervo vago e aiuta a ridurre l'attività patologica del cervello e la frequenza delle crisi convulsive. [ 24 ]
Prevenzione
È quasi impossibile prevenire lo sviluppo dell'epilessia idiopatica, tuttavia anche le donne con epilessia hanno il 97% di probabilità di partorire un bambino sano. Questa probabilità aumenta con uno stile di vita sano di entrambi i genitori, una gravidanza portata a termine con successo e un parto naturale.
Previsione
La stragrande maggioranza dei casi di epilessia idiopatica è benigna e ha una prognosi favorevole. La remissione terapeutica completa si ottiene in media in oltre l'80% dei pazienti, sebbene alcune forme della malattia, soprattutto quelle che si sviluppano negli adolescenti, richiedano una terapia antiepilettica a lungo termine. A volte è per tutta la vita. [ 25 ] Tuttavia, i farmaci moderni consentono generalmente di controllare le crisi e di fornire ai pazienti una normale qualità di vita.

