Esperto medico dell'articolo
Nuove pubblicazioni
Sindrome linfoproliferativa autoimmune
Ultima recensione: 04.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.
Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.
Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.
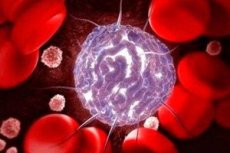
La sindrome linfoproliferativa autoimmune (ALPS) è una malattia causata da difetti congeniti nell'apoptosi mediata da Fas. È stata descritta nel 1995, ma dagli anni '60 è nota una malattia con un fenotipo simile, nota come sindrome di CanaLe-Smith.
La malattia è caratterizzata da linfoproliferazione cronica non maligna e ipergammaglobulinemia, che possono essere associate a vari disturbi autoimmuni.
Patogenesi
L'apoptosi, o morte cellulare fisiologica, è uno dei meccanismi fondamentali per il mantenimento dell'omeostasi dell'organismo. L'apoptosi si sviluppa a seguito dell'attivazione di vari meccanismi di segnalazione. L'apoptosi mediata dall'attivazione dei recettori Fas (CD95) durante la loro interazione con il corrispondente ligando (ligando di Fas, FasL) svolge un ruolo fondamentale nella regolazione del sistema emopoietico e del sistema immunitario. Fas è presente in diverse cellule emopoietiche; un'elevata espressione del recettore Fas è caratteristica dei linfociti attivati. FasL è espresso principalmente dai linfociti T CD8+.
L'attivazione del recettore Fas comporta una serie di processi intracellulari sequenziali che provocano la disorganizzazione del nucleo cellulare, la denaturazione del DNA e alterazioni della membrana cellulare che ne portano alla disintegrazione in numerosi frammenti, senza il rilascio di enzimi lisosomiali nell'ambiente extracellulare e senza indurre infiammazione. Diversi enzimi chiamati caspasi, tra cui la caspasi 8 e la caspasi 10, partecipano alla trasmissione del segnale apoptotico al nucleo.
L'apoptosi mediata da Fas svolge un ruolo importante nell'eliminazione delle cellule con mutazioni somatiche, dei linfociti autoreattivi e dei linfociti che hanno svolto il loro ruolo nella normale risposta immunitaria. Un'apoptosi compromessa dei linfociti T porta all'espansione dei linfociti T attivati, così come dei cosiddetti linfociti T doppio-negativi che esprimono il recettore dei linfociti T con catene a/b (TCRa/b), ma non possiedono né molecole CD4 né CD8. Una morte cellulare programmata difettosa dei linfociti B, in combinazione con livelli elevati di interleuchina 10 (IL-10), porta a ipergammaglobulinemia e a una maggiore sopravvivenza dei linfociti B autoreattivi. Le conseguenze cliniche includono un accumulo eccessivo di linfociti nel sangue e negli organi linfoidi, un aumento del rischio di reazioni autoimmuni e di crescita tumorale.
Ad oggi, sono stati identificati diversi difetti molecolari che portano al fallimento dell'apoptosi e allo sviluppo della leucemia linfoblastica acuta (LLA). Si tratta di mutazioni nei geni Fas, FasL, caspasi 8 e caspasi 10.
Sintomi sindrome linfoproliferativa autoimmune.
L'ALPS è caratterizzata da un'ampia variabilità nello spettro delle manifestazioni cliniche e nella gravità del decorso, e l'età della manifestazione clinica può anch'essa variare a seconda della gravità dei sintomi. Sono noti casi di esordio di manifestazioni autoimmuni in età adulta, al momento della diagnosi di ALPS. Le manifestazioni della sindrome linfoproliferativa sono presenti fin dalla nascita sotto forma di ingrossamento di tutti i gruppi di linfonodi (periferici, intratoracici, intra-addominali), aumento delle dimensioni della milza e spesso del fegato. Le dimensioni degli organi linfoidi possono variare nel corso della vita, talvolta con un aumento in concomitanza con infezioni intercorrenti. I linfonodi hanno una consistenza normale, a volte densi; non sono dolenti. Sono noti casi di gravi manifestazioni di sindrome iperplastica, che imitano il linfoma, con ingrossamento dei linfonodi periferici, che porta a deformazione del collo, iperplasia dei linfonodi intratoracici fino allo sviluppo di sindrome da compressione e insufficienza respiratoria. Sono stati descritti infiltrati linfoidi nei polmoni. Tuttavia, in molti casi le manifestazioni della sindrome iperplastica non sono così drammatiche e passano inosservate a medici e genitori. Anche il grado di splenomegalia è piuttosto variabile.
La gravità della malattia è determinata principalmente dalle manifestazioni autoimmuni che possono svilupparsi a qualsiasi età. Il più delle volte si riscontrano diverse emopatie immunitarie: neutropenia, trombocitopenia, anemia emolitica, che possono essere combinate in forma di citopenia a due e tre linee. Può verificarsi un singolo episodio di citopenia immune, ma spesso è cronico o ricorrente.
Altre manifestazioni autoimmuni più rare possono includere epatite autoimmune, artrite, scialoadenite, malattie infiammatorie intestinali, eritema nodoso, pannicolite, uveite e sindrome di Guillain-Barré. Inoltre, si possono osservare diverse eruzioni cutanee, principalmente orticarioidi, subfebbrili o febbre, senza correlazione con un processo infettivo.
I pazienti con sindrome linfoproliferativa autoimmune presentano un'incidenza maggiore di tumori maligni rispetto alla popolazione generale. Sono stati descritti casi di emoblastosi, linfomi e tumori solidi (carcinoma del fegato e dello stomaco).
 [ 8 ]
[ 8 ]
Forme
Nel 1999 è stata proposta una classificazione operativa della sindrome linfoproliferativa autoimmune basata sul tipo di difetto di apoptosi:
- ALP5 0 - carenza completa di CD95, risultante da una mutazione omozigote null (mutazione omozigote nuLl) nel gene Fas/CD95;
- ALPS I - difetto nella trasduzione del segnale attraverso il recettore Fas.
- In questo caso, l'ALPS la è una conseguenza di un difetto nel recettore Fas (mutazione eterozigote nel gene Fas);
- L'ALPS lb è una conseguenza di un difetto nel ligando Fas (FasL) associato a una mutazione nel gene corrispondente - FASLG/CD178;
- ALPS Ic è il risultato di una mutazione omozigote recentemente identificata nel gene FA5LG/CD178;
- ALPS II - difetto nella trasmissione del segnale intracellulare (mutazione nel gene della caspasi 10 - ALPS IIa, nel gene della caspasi 8 - ALPS IIb);
- ALPS III - difetto molecolare non identificato.
Tipo di eredità
L'ALPS di tipo 0, una carenza completa di CD95, è stata descritta solo in pochi pazienti. Poiché i membri eterozigoti della famiglia non presentano il fenotipo ALPS, è stato proposto un modello di ereditarietà autosomica recessiva. Tuttavia, dati non pubblicati relativi a una famiglia con ALPS di tipo 0 non sono del tutto coerenti con questa ipotesi. Gli scienziati hanno scoperto che molte, se non tutte, le mutazioni sono dominanti e che, quando sono omozigoti, determinano un fenotipo della malattia più grave.
Nella forma ALPS di tipo I, il modello di ereditarietà è autosomico dominante, con penetranza incompleta ed espressività variabile. In particolare, nella forma ALPS1a, sono stati descritti casi di omozigosi o eterozigosi combinata, in cui diverse mutazioni del gene Fas sono determinate in entrambi gli alleli. Questi casi erano caratterizzati da un decorso grave con manifestazioni prenatali o neonatali (idrope fetale, epatosplenomegalia, anemia, trombocitopenia). Inoltre, è stata riscontrata una correlazione tra la gravità dei sintomi clinici e il tipo di mutazione nel gene Fas; un decorso più grave è caratteristico di una mutazione nel dominio intracellulare. In totale, sono stati descritti più di 70 pazienti con ALPS 1a in tutto il mondo. La mutazione FasL è stata descritta per la prima volta in un paziente con manifestazioni cliniche di lupus eritematoso sistemico e linfoproliferazione cronica. È stata classificata come ALPS lb, sebbene il fenotipo non soddisfacesse pienamente i criteri per la sindrome linfoproliferativa autoimmune classica (assenza di linfociti T doppi negativi e splenomegalia). La prima mutazione omozigote A247E nel gene FasL (dominio extracellulare) è stata descritta recentemente, nel 2006, da Del-Rey M et al. in un paziente con ALPS non letale, il che indica un ruolo importante del dominio terminale di FasL C0OH nell'interazione Fas/FasL. Gli autori propongono di includere il sottogruppo ALPS Ic nell'attuale classificazione della sindrome linfoproliferativa autoimmune.
L'ALPS di tipo II è ereditata in maniera autosomica recessiva e molti pazienti affetti da questo tipo di malattia presentano le tipiche caratteristiche cliniche e immunologiche dell'ALPS, tra cui un'apoptosi mediata da Fas alterata, nella cui attuazione sono coinvolte sia la caspasi 8 (coinvolta nelle fasi iniziali della segnalazione intercellulare a livello delle interazioni TCR e BCR) sia la caspasi 10 (coinvolta nella cascata apoptotica a livello di tutti i recettori noti che inducono l'apoptosi dei linfociti).
Oltre 30 pazienti presentavano un quadro clinico moderato di ALPS, con ipergammaglobulinemia e livelli elevati di cellule T doppio-negative nel sangue, e i linfociti attivati di pazienti con ALPS di tipo III (come veniva chiamata questa sindrome) mostravano una normale attivazione della via mediata da Fas in vitro, senza difetti molecolari. È possibile che la malattia sia causata da alterazioni di altre vie apoptotiche, come quelle mediate da Trail-R, DR3 o DR6. Di interesse è l'osservazione da parte di R. Qementi della mutazione N252S nel gene della perforina (PRF1) in un paziente con ALPS di tipo III, che presentava una significativa riduzione dell'attività delle cellule NK. L'autore osserva che la differenza significativa tra la frequenza di rilevamento di N252S nei pazienti con ALPS (2 su 25) e la frequenza del suo rilevamento nel gruppo di controllo (1 su 330) suggerisce la sua connessione con lo sviluppo di ALPS nella popolazione italiana. D'altra parte, F. Rieux-Laucat osserva di aver rilevato questa variante della mutazione PRF1 nel 18% degli individui sani e nel 10% dei pazienti con ALPS (dati non pubblicati). Inoltre, oltre al polimorfismo N252S, ha trovato una mutazione del gene Fas in un paziente con ALPS e nel suo padre sano, il che, secondo F. Rieux-Laucat, indica la non patogenicità della mutazione eterozigote N252S nel gene della perforina, descritta in precedenza da R. Qementi in un paziente con ALPS (mutazione Fas) e linfoma B a grandi cellule. Pertanto, la questione delle cause dell'ALPS di tipo III rimane ancora aperta.
Diagnostica sindrome linfoproliferativa autoimmune.
Uno dei segni della sindrome linfoproliferativa può essere la presenza di linfociti assoluti nel sangue periferico e nel midollo osseo. Il contenuto linfocitario aumenta a causa dei linfociti B e T, in alcuni casi solo a causa di una delle sottopopolazioni.
Caratteristico è l'aumento del contenuto di linfociti doppio-negativi con fenotipo CD3+CD4-CD8-TCRa/b nel sangue periferico. Queste stesse cellule si trovano nel midollo osseo, nei linfonodi e negli infiltrati linfocitari degli organi.
Una ridotta espressione di CD95 (recettore Fas) sui linfociti non è un criterio diagnostico per la sindrome linfoproliferativa autoimmune, poiché il suo livello può rimanere entro il range normale in alcuni difetti di Fas con mutazione nel dominio intracellulare, così come nei tipi ALPS II e III.
Un segno tipico della sindrome linfoproliferativa autoimmune è l'iperimmunoglobulinemia, dovuta a un aumento dei livelli di tutte le immunoglobuline e di singole classi di immunoglobuline. L'entità dell'aumento può variare.
Esistono casi isolati di sindrome linfoproliferativa autoimmune con ipoimmunoglobulinemia, la cui natura non è chiara. L'immunodeficienza è più tipica dei pazienti con ALPS IIb, sebbene sia stata descritta anche in ALPS di tipo 1a.
I pazienti possono presentare vari autoanticorpi: anticorpi contro le cellule del sangue, ANF, anticorpi contro il DNA nativo, anti-RNP, anti-SM, anti-SSB, RF, anticorpi contro il fattore VIII della coagulazione.
Livelli elevati di trigliceridi sierici sono stati segnalati in pazienti con sindrome linfoproliferativa autoimmune; si ritiene che l'ipertrigliceridemia sia secondaria all'aumentata produzione di citochine che influenzano il metabolismo lipidico, in particolare del fattore di necrosi tumorale (TNF). Aumenti significativi dei livelli di TNF si riscontrano nella maggior parte dei pazienti con sindrome linfoproliferativa autoimmune. In alcuni pazienti, i livelli di ipertrigliceridemia sono correlati al decorso della malattia, aumentando durante le riacutizzazioni.
La necessità di una diagnosi differenziale con i linfomi maligni determina le indicazioni alla biopsia a cielo aperto del linfonodo. L'esame morfologico e immunoistochimico del linfonodo rivela iperplasia delle zone paracorticali e, in alcuni casi, dei follicoli, infiltrazione di linfociti T e B, immunoblasti, plasmacellule. In alcuni casi si riscontrano istiociti. La struttura del linfonodo è generalmente conservata, in alcuni casi può essere parzialmente cancellata a causa di una pronunciata infiltrazione cellulare mista.
Nei pazienti sottoposti a splenectomia per ematopatie immunitarie croniche, viene rilevata un'infiltrazione linfoide mista, comprendente cellule della popolazione doppio-negativa.
Un metodo specifico per la diagnosi di sindrome linfoproliferativa autoimmune è lo studio dell'apoptosi delle cellule mononucleate periferiche (PMN) del paziente in vitro, con induzione mediante anticorpi monoclonali diretti contro il recettore Fas. Nella sindrome linfoproliferativa autoimmune (ALPS), non si osserva alcun aumento del numero di cellule apoptotiche quando i PMN vengono incubati con anticorpi anti-FasR.
I metodi diagnostici molecolari mirano a identificare mutazioni nei geni Fas, caspasi 8 e caspasi 10. In caso di risultati normali di apoptosi dei PMN e presenza di un quadro fenotipico di ALPS, è indicato lo studio del gene FasL.
Cosa c'è da esaminare?
Diagnosi differenziale
La diagnosi differenziale della sindrome linfoproliferativa autoimmune viene effettuata con le seguenti patologie:
- Malattie infettive (infezioni virali, tubercolosi, leishmaniosi, ecc.)
- Linfomi maligni.
- Linfoistiocitosi emofagocitica.
- Malattie da accumulo (malattia di Gaucher).
- Sarcoidosi.
- Linfadenopatia nelle invasioni sistemiche del tessuto connettivo.
- Altri stati di immunodeficienza (immunodeficienza comune variabile, sindrome di Wiskott-Aldrich).
Trattamento sindrome linfoproliferativa autoimmune.
Nella sindrome linfoproliferativa isolata, la terapia non è solitamente necessaria, tranne nei casi di grave iperplasia con sindrome da compressione mediastinica e sviluppo di infiltrati linfoidi negli organi. In questo caso, si utilizza la terapia immunosoppressiva (glucocorticoidi, ciclosporina A, ciclofosfamide).
Il trattamento delle complicanze autoimmuni viene effettuato secondo i principi generali di terapia delle relative patologie: in caso di emopatie, il (metil)prednisolone viene prescritto alla dose di 1-2 mg/kg, oppure in terapia pulsata con successivo passaggio a dosi di mantenimento; in caso di effetto insufficiente o instabile, si utilizza una combinazione di corticosteroidi con altri immunosoppressori, ad esempio: micofenolato mofetile, ciclosporina A, azatioprina, anticorpi monoclonali anti-CD20 (rituximab). La terapia con alte dosi di immunoglobuline per via endovenosa (IVIG), di norma, produce un effetto insoddisfacente o instabile. Data la tendenza al decorso cronico o recidivante, è necessaria una terapia a lungo termine con dosi di mantenimento, selezionate individualmente. In caso di effetto insufficiente della terapia farmacologica, che richiede alte dosi di farmaco, può essere efficace la splenectomia.
In caso di decorso grave o di progressione prevista della malattia, è indicato il trapianto di cellule staminali emopoietiche; tuttavia, l'esperienza con il trapianto nella sindrome linfoproliferativa autoimmune è limitata a livello mondiale.
Previsione
La prognosi dipende dalla gravità della malattia, che è spesso determinata dalla gravità delle manifestazioni autoimmuni. Nelle emopatie gravi e resistenti alla terapia, è probabile un esito sfavorevole.
Con l'età, la gravità della sindrome linfoproliferativa può diminuire, ma ciò non esclude il rischio di comparsa di gravi complicanze autoimmuni. In ogni caso, una prognosi adeguata contribuisce a sviluppare un approccio terapeutico ottimale per ciascun paziente.
 [ 13 ]
[ 13 ]
Использованная литература

