Esperto medico dell'articolo
Nuove pubblicazioni
Sindrome postcoccigea in adulti e bambini
Ultima recensione: 12.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.
Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.
Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.
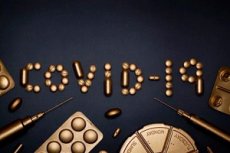
Oggi, persino un bambino sa cos'è l'infezione da coronavirus COVID-19. Ma non molti conoscono la sindrome post-COVID. In realtà, si tratta di una condizione patologica piuttosto comune dopo l'infezione da coronavirus, che non presenta sintomi specifici, ma può protrarsi a lungo, compromettendo la capacità lavorativa e ritardando la guarigione dei pazienti.
Sindrome post-Covid: questa diagnosi solleva molti interrogativi. Di solito, si pensa: ho superato l'infezione, sono guarito e non c'è più bisogno di preoccuparsi. Ma il coronavirus è più insidioso di quanto i medici pensassero: può ripresentarsi a lungo con vari segni patologici, sotto forma di sindrome della voce.
Epidemiologia
Secondo diversi articoli scientifici sul tema della sindrome post-Covid, si possono trarre le seguenti statistiche: circa il 15% dei pazienti che hanno contratto il COVID-19 riferisce di avere una salute precaria e una sensazione di guarigione incompleta per oltre 20 giorni dopo la malattia. Circa il 2% manifesta sintomi spiacevoli per oltre tre mesi. Tuttavia, numerose indagini condotte su persone guarite dalla malattia indicano che queste cifre sono in realtà molto più elevate. Dopotutto, molti pazienti vengono trasferiti a cure domiciliari prima che i sintomi siano completamente scomparsi e non tutti cercano assistenza medica quando si sviluppa la sindrome post-Covid. [ 1 ]
Uno studio ha coinvolto oltre 380 persone con infezione da coronavirus, con un'età media di 69-70 anni. È stato osservato che la maggior parte di loro non poteva parlare di una completa guarigione fino a tre mesi dopo la comparsa della lesione infettiva. Oltre il 50% di queste persone lamentava difficoltà respiratorie, oltre il 30% tosse, circa il 70% indicava grave affaticamento e il 14% sviluppava depressione. Al termine dell'esperimento, i pazienti sono stati sottoposti a ripetute radiografie: è emerso che solo il 60% di loro presentava un quadro completamente "sano".
Inoltre, i medici americani hanno avviato un sondaggio telefonico, durante il quale sono state raccolte le seguenti informazioni: almeno il 35% dei pazienti ha riferito che entro 2-3 settimane dalla malattia non si sentiva ancora bene come prima dell'infezione. Tra i giovani di età compresa tra 18 e 34 anni, una persona su cinque ha manifestato sintomi patologici per diverse settimane.
Le cause sindrome post-coitale
La sindrome post-Covid è una conseguenza di una malattia come il COVID-19, un'infezione acuta da coronavirus che colpisce principalmente l'apparato respiratorio e il tratto digerente. Per la sua origine, il coronavirus è un'infezione zoonotica. [ 2 ]
La maggior parte delle persone infette dal patogeno COVID-19, il coronavirus, presenta sintomi moderati o lievi e la guarigione avviene senza ricorrere a specifiche misure terapeutiche. Particolarmente rischioso è il decorso grave della malattia, che è più tipico nei pazienti anziani e debilitati con patologie pregresse, come diabete mellito, malattie respiratorie o cardiovascolari croniche e tumori.
Tuttavia, la sindrome post-COVID può svilupparsi in qualsiasi paziente guarito dal COVID-19, indipendentemente da come sia progredita l'infezione: se latente o grave.
Oggi, gli specialisti hanno diverse teorie per spiegare l'insorgenza della sindrome. Secondo una di queste, le manifestazioni dolorose dopo la guarigione sono una conseguenza dello sviluppo di trombovasculite cronica.
Infatti, l'infezione da coronavirus colpisce non solo le vie respiratorie, ma anche i vasi sanguigni, incluso il cervello. Le pareti vascolari si infiammano e questo processo può continuare per un certo periodo dopo la guarigione.
Questa teoria ha il diritto di esistere, ma non spiega tutti i sintomi della sindrome post-Covid. Pertanto, gli scienziati hanno ancora molto lavoro da fare per scoprire le cause di questa complicanza.
Fattori di rischio
I medici non sono ancora in grado di rispondere alla domanda sul perché alcuni pazienti contraggano l'infezione da coronavirus senza conseguenze, mentre altri sviluppino la sindrome post-COVID. Tuttavia, è stato osservato che il COVID-19 lascia più spesso sintomi spiacevoli in coloro che sono guariti dalla malattia e appartengono a gruppi a rischio:
- pazienti anziani;
- soffre di ipertensione, patologie cardiovascolari;
- che soffrono di malattie respiratorie croniche, diabete, obesità;
- persone con sistema immunitario inizialmente indebolito, oncopatologie, disturbi cerebrovascolari.
Gli anziani sono uno dei primi gruppi a rischio ad essere identificati. La sindrome post-Covid è particolarmente pericolosa per le persone di età superiore ai 60 anni. La causa principale di questo pericolo è il graduale indebolimento del sistema immunitario, dovuto alla contemporanea presenza di diverse malattie di base. Durante il COVID-19, il numero di singole cellule immunitarie diminuisce, in particolare di cellule T-killer e cellule NK. Se l'immunità di una persona è già compromessa, le conseguenze della patologia possono essere completamente disastrose. [ 3 ], [ 4 ]
Le persone con malattie cardiovascolari presentano un rischio elevato non solo di sviluppare la sindrome post-COVID, ma anche altre complicazioni, incluso il decesso. Le persone con diabete presentano nella maggior parte dei casi alterazioni funzionali del tessuto polmonare, ridotta circolazione dell'aria e disturbi respiratori generali, che contribuiscono all'ulteriore sviluppo di effetti avversi.
Patogenesi
La maggior parte dei pazienti infettati da COVID-19 guarisce dalla malattia entro poche settimane. Tuttavia, a volte i segni patologici scompaiono solo parzialmente o compaiono altri sintomi residui dopo una forma lieve di infezione da coronavirus. In tali situazioni, si parla di sindrome post-COVID, che consiste nella comparsa di vari disturbi per oltre 3-4 settimane dopo la guarigione. [ 5 ]
Gli esatti meccanismi patogenetici per lo sviluppo della sindrome post-Covid non sono ancora chiari. Esistono diverse possibilità che si verifichi una conseguenza imprevista, ad esempio:
- L'infezione da coronavirus colpisce direttamente gli organi umani: polmoni, cuore, vasi sanguigni, reni, stomaco, intestino e cervello sono "sotto attacco".
- Il coronavirus provoca lo sviluppo di un processo infiammatorio nel rivestimento interno dei vasi sanguigni. Il paziente sviluppa vasculite ed endoteliite, che a loro volta causano disturbi della coagulazione del sangue. La presenza di microscopici coaguli di sangue nel flusso sanguigno influisce negativamente sull'afflusso di sangue a diversi organi, in particolare cuore, reni, ghiandole surrenali, tiroide, cervello, ghiandole sessuali, ecc.
- Il coronavirus può colpire le cellule nervose del cervello e i grandi tronchi nervosi, provocando un'ampia gamma di sintomi, che vanno dai disturbi del sonno alla depressione, fino all'aritmia e alla mancanza di respiro.
- L'infezione stimola un'iperreazione del sistema immunitario, si innesca una serie di risposte autoimmuni e si sviluppa un processo infiammatorio cronico, causato dall'attivazione dei mastociti che rilasciano numerosi mediatori.
La sindrome post-COVID è una conseguenza multifattoriale che, come il COVID-19, non è stata ancora sufficientemente studiata.
Sintomi sindrome post-coitale
Il quadro clinico della sindrome post-Covid, riportato da chi è guarito dal COVID-19, è piuttosto eterogeneo. Può includere i seguenti sintomi:
- febbre, dolore al petto, all'addome e/o alle articolazioni, grave stanchezza;
- difficoltà respiratorie, tosse;
- sensazione di pesantezza e dolore al petto, battito cardiaco accelerato;
- compromissione neurocognitiva, annebbiamento mentale, diminuzione della concentrazione, compromissione della memoria, mal di testa, insonnia o sonnolenza, intorpidimento delle estremità, formicolio alle dita delle mani e dei piedi, vertigini;
- dolori addominali, nausea periodica, diarrea, disturbi dell'appetito (inclusa possibile anoressia);
- dolori muscolari e articolari;
- disturbi d'ansia, depressione;
- dolore all'orecchio, sensazione di rumore nelle orecchie, mal di gola, perdita dell'olfatto, alterazione della percezione del gusto, comparsa di sapori aggiuntivi;
- eruzioni cutanee.
Inoltre, durante la sindrome post-COVID, sono stati spesso notati disturbi del sistema di coagulazione del sangue e disturbi metabolici. [ 6 ]
I primi segnali più comuni dello sviluppo della sindrome post-COVID sono:
- debolezza parossistica, spesso grave, che impedisce di svolgere le normali faccende domestiche o addirittura di alzarsi dal letto;
- un forte calo della resistenza, l'incapacità di svolgere anche un'attività fisica moderata;
- interruzione dei ritmi circadiani, quando l'insonnia notturna viene sostituita dalla sonnolenza diurna (inversione del sonno);
- dolori muscolari causati da una diminuzione della componente proteica dei muscoli durante la fase acuta del COVID-19.
I disturbi psicoemotivi si riscontrano nei pazienti ovunque:
- depressione, umore pessimistico, depressione, ansia, nei casi gravi – pensieri suicidi;
- labilità emotiva, sbalzi d'umore improvvisi, perdita dell'autocontrollo comportamentale;
- attacchi di panico accompagnati da alterazioni della pressione sanguigna, nausea e vertigini.
La cosiddetta sindrome asteno-vegetativa post-Covid è più tipica delle pazienti di sesso femminile predisposte a disturbi vegetativi e vascolari. I segni tipici di tale disturbo sono:
- cambiamenti nella pressione sanguigna (solitamente aumento, ma a volte ipotensione);
- sensazione di difficoltà respiratoria;
- vertigini parossistiche, perdita di equilibrio;
- nausea parossistica (vomito – raro);
- l'insorgenza di varie paure (tra cui la paura della morte);
- una sensazione improvvisa di freddo o di caldo.
Anche l'apparato respiratorio può cedere, anche in pazienti che non hanno manifestato evidenti problemi respiratori durante la fase acuta del COVID-19. Con lo sviluppo della sindrome post-COVID, compaiono i seguenti sintomi:
- sensazione di mancanza d'aria;
- pesantezza al petto, sensazione di inspirazione incompleta;
- spasmi periodici dei bronchi, che possono essere accompagnati da grave mancanza di respiro, tachicardia e vertigini.
Un'immagine simile può durare da una settimana a sei mesi o anche di più.
Spesso, nella sindrome post-COVID, viene colpito anche il sistema nervoso, che si manifesta con i seguenti sintomi patologici:
- mal di testa, costanti o parossistici, fastidiosi a periodi;
- guasti termoregolatori (aumento prolungato della temperatura o, al contrario, diminuzione);
- brividi frequenti, tremori muscolari (anche con temperatura corporea normale);
- disturbi sensoriali sotto forma di parestesia, formicolio, bruciore, prurito sulla pelle;
- cambiamenti nel gusto e nell'olfatto (fino a sei mesi o più). [ 7 ]
Quanto può durare la febbre con la sindrome post-Covid? Nella maggior parte dei casi, le temperature non superano i valori subfebbrili, attestandosi intorno ai 37,3 °C (soprattutto la sera) per non più di una settimana, in assenza di altre patologie di base. Alcuni pazienti presentano febbre per 1-2 settimane, che si ripresenta per diversi giorni dopo un breve intervallo di “leggero”. Ma una temperatura bassa (solitamente 36,5 °C) può durare un po' più a lungo, fino a diverse settimane. [ 8 ]
Danni specifici al sistema cardiovascolare durante il COVID-19 si manifestano anche durante la sindrome post-COVID. In circa il 20% dei casi, le persone guarite manifestano disturbi del ritmo cardiaco e sviluppo di insufficienza cardiaca acuta o cronica. I sintomi più comuni sono:
- fluttuazioni della pressione sanguigna (aumento o diminuzione), nei casi gravi si sviluppa il collasso ortostatico, caratterizzato da un forte calo della pressione fino allo stato di svenimento;
- vasculite, angioite, che sono accompagnate dalla comparsa di eruzioni cutanee, emorragie ed ematomi sulla pelle;
- aritmie, tachicardia, bradicardia.
La sindrome post-Covid si manifesta spesso con disturbi digestivi associati sia a lesioni infettive del tratto gastrointestinale, sia alla terapia antibiotica e all'uso di altri farmaci. I pazienti lamentano spesso:
- in caso di deterioramento della peristalsi intestinale, comparsa periodica di stitichezza o diarrea;
- cambiamento dell'appetito (il più delle volte: perdita del desiderio di cibo).
Se non si prendono misure, la disbatteriosi intestinale può causare un indebolimento del sistema immunitario, lo sviluppo di anemia e processi allergici. [ 9 ]
Altri possibili segni della sindrome post-Covid possono includere malattie infiammatorie urogenitali, nelle donne dismenorrea e malattie endocrine. Il più delle volte, i primi "campanelli" si notano in organi precedentemente colpiti da patologie croniche. A volte, disturbi di cui il paziente non era a conoscenza "si manifestano". Per prevenire l'insorgenza di gravi problemi di salute, si raccomanda di ascoltare attentamente le proprie sensazioni e di consultare immediatamente un medico in caso di sintomi sospetti.
Sindrome post-Covid nei bambini
La sindrome post-Covid si manifesta anche durante l'infanzia, anche se il bambino ha contratto una forma lieve della malattia. Proprio come negli adulti, anche i bambini sono a rischio di danni agli organi interni, all'apparato respiratorio e cardiovascolare.
Quali sono i sintomi? Il più delle volte, i pazienti lamentano mancanza di respiro, tachicardia, attacchi d'ansia, disturbi digestivi, disturbi del sonno e letargia. Si riscontrano anche deficit del sistema immunitario. I bambini possono essere disturbati da attacchi di paura, persino di panico.
È noto che i bambini tollerano il COVID-19 più facilmente degli adulti. Hanno meno probabilità di sviluppare polmonite e altre complicazioni. Tuttavia, la sindrome post-COVID è tipica anche dei pazienti più piccoli. Ad esempio, i neonati di età inferiore a 1 anno presentano un appetito significativamente ridotto, che li porta a perdere peso. La qualità del sonno peggiora: i neonati hanno difficoltà ad addormentarsi, dormono in modo irrequieto, sebbene siano letargici e assonnati durante il giorno.
I pediatri segnalano numerosi casi di sviluppo di infiammazione multisistemica, o sindrome di Kawasaki, nei bambini. In questo caso, si tratta di una grave complicanza con una prognosi sfavorevole, che può arrivare fino alla morte. I pazienti che hanno manifestato tale sindrome presentano un rischio elevato di sviluppare patologie coronariche in futuro.
Per prevenire sviluppi sfavorevoli, i genitori dovrebbero monitorare attentamente i propri figli anche dopo la guarigione dal COVID-19. Dopo qualsiasi patologia, è necessaria una fase di recupero, che preveda la riduzione dello stress mentale e fisico, l'assunzione di liquidi in abbondanza e un'alimentazione di qualità. In caso di segni sospetti, è opportuno consultare un medico il prima possibile e, se necessario, sottoporsi a una serie di ulteriori accertamenti.
Fasi
Nel 2020, il National Institute for Health and Care Excellence del Regno Unito, insieme alla Scottish Intercollegiate Organisation e al Royal College of General Practitioners, ha raccomandato di distinguere i seguenti stadi della malattia:
- Fase acuta: i disturbi e i segni patologici sono presenti fino a 3-4 settimane.
- Fase sintomatica prolungata: i disturbi e i segni patologici sono presenti per quattro-dodici settimane.
- Fase immediata della sindrome post-Covid: i disturbi e i segni patologici persistono per più di 12 settimane, senza essere conseguenza di altre patologie.
Forme
La diagnosi di “sindrome post-COVID” non è ancora entrata nell’uso medico ufficiale e non è considerata un termine generalmente accettato, ma è già spesso utilizzata per caratterizzare il fenomeno di un lungo periodo di recupero dopo il COVID-19.
A causa della mancanza di un termine ufficialmente riconosciuto, gli esperti hanno proposto di suddividere la patologia nei seguenti tipi:
- COVID-19 a lungo termine: se i sintomi persistono per più di 3 settimane dopo la manifestazione infettiva;
- forma cronica di COVID-19: se i sintomi persistono per più di 12 settimane dopo che sono stati rilevati i primi segni di infezione.
Gli esperti ritengono inoltre che i criteri di conferma di laboratorio per l’infezione da coronavirus non siano un prerequisito per l’identificazione di una malattia di tipo cronico o a lungo termine. [ 10 ]
Complicazioni e conseguenze
La sindrome post-COVID è di per sé una complicanza dell'infezione da coronavirus COVID-19. Tuttavia, può anche portare allo sviluppo di effetti avversi: in particolare, molti pazienti hanno manifestato disturbi del sistema di coagulazione del sangue e disturbi metabolici. Ad esempio, i pazienti diabetici hanno spesso difficoltà a tenere sotto controllo la malattia.
Inoltre, sono documentate evidenze di conseguenze patologiche come infiammazione del muscolo cardiaco e insufficienza cardiovascolare, aritmie cardiache e complicanze trombotiche. Alcuni pazienti hanno sviluppato encefalite post-infettiva.
Problemi simili possono verificarsi anche a livello dell'apparato respiratorio, muscolo-scheletrico e nervoso. Le cause di tali sviluppi sono sconosciute, ma molti specialisti associano l'insorgenza di complicanze a diversi meccanismi patofisiologici, tra cui il danno vascolare (vasculite).
Altre possibili conseguenze negative della sindrome post-COVID includono il deterioramento della vista e l’artrite. [ 11 ]
Per prevenire le complicazioni, i medici raccomandano di adottare un approccio multiforme a tutti i pazienti COVID-19, prestando attenzione non solo alle loro condizioni fisiche ma anche a quelle psicologiche.
Diagnostica sindrome post-coitale
Per diagnosticare la sindrome post-COVID, i medici utilizzano le seguenti tattiche, che prevedono una visita di controllo al paziente guarito dal COVID-19:
- determinazione dei sintomi esistenti e della cronologia della loro comparsa;
- valutazione della presenza di complicanze associate alla sindrome post-COVID;
- valutazione della gravità dei sintomi;
- determinazione delle patologie concomitanti e del grado di probabilità dell’influenza dell’infezione da coronavirus sul loro decorso.
Dopo aver raccolto le informazioni necessarie, il medico inizia un esame fisico, misura la temperatura, la pressione sanguigna, conta il polso e controlla il grado di saturazione dell'ossigeno nel sangue. [ 12 ]
Poi prescrive degli esami di laboratorio:
- esame del sangue generale (esteso);
- livelli di elettroliti, enzimi epatici, indicatori della funzionalità renale;
- troponina, creatina chinasi, ferritina, proteina C-reattiva, D-dimeri, peptide natriuretico di tipo B BNP, ormone stimolante la tiroide, ormoni tiroidei;
- livello di vitamina D (la carenza o bassi livelli di questa vitamina determinano la complessità e la durata della sindrome post-COVID);
- esame generale delle urine, analisi delle proteine totali, urea, potassio, sodio.
La diagnostica strumentale per la sindrome post-COVID include necessariamente radiografia ed elettrocardiografia. Inoltre, possono essere prescritti spirografia, ecografia cardiaca, monitoraggio giornaliero del ritmo cardiaco e della pressione arteriosa, ecografia degli organi addominali e dello spazio retroperitoneale.
Se il paziente necessita di ossigenoterapia durante la fase acuta della malattia, vengono prescritti ulteriori esami circa 5 settimane dopo il completamento del trattamento ospedaliero. Dopo 3 mesi vengono eseguite radiografie e viene valutata anche la probabilità di trombosi.
Se una persona presenta segni gravi di sindrome post-COVID, è necessario indirizzarla a una diagnosi urgente, per escludere lo sviluppo di complicazioni potenzialmente pericolose (ipossiemia grave, sindrome infiammatoria multisistemica, ecc.). Se viene rilevata una mancanza di respiro regolare, il paziente viene indirizzato a una diagnosi di ipossia latente. [ 13 ]
Per alcune persone guarite, è consigliabile l'automonitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue utilizzando un pulsossimetro per diversi giorni. Inoltre, è possibile eseguire un test misurando il polso e registrando il ritmo respiratorio a riposo e dopo un minuto di esercizio fisico.
Quando viene rilevata una tachicardia ortostatica, la pressione sanguigna viene misurata in diverse posizioni del corpo (in piedi, sdraiato).
In base alle violazioni accertate, vengono prescritte ulteriori consulenze con specialisti specializzati.
Diagnosi differenziale
La diagnosi differenziale della sindrome post-COVID deve essere effettuata con altre patologie e complicanze patologiche, con disturbi respiratori e cardiovascolari, patologie dell'apparato digerente e nervoso.
Chi contattare?
Trattamento sindrome post-coitale
Le strategie terapeutiche per la sindrome post-COVID dipendono dalle alterazioni patologiche e dai sintomi rilevati. A condizione che vengano escluse gravi complicanze dell'infezione da coronavirus, il regime terapeutico si basa sull'uso di farmaci sintomatici e di supporto che migliorano il benessere del paziente. Nei casi gravi, potrebbe essere necessaria la riabilitazione respiratoria.
I principi terapeutici generali includono il riposo a letto, un'alimentazione calorica sufficiente e un regime di bevande adeguato, il controllo dell'equilibrio idrico-elettrolitico e dell'emostasi, la correzione dei disturbi respiratori e di altro tipo. [ 14 ]
Raccomandazioni cliniche basate su sintomi specifici:
Tosse di lunga durata |
Se è stata accertata un'infezione batterica, vengono prescritti antibiotici e, in altri casi, sono consigliati esercizi di respirazione. |
Dispnea |
Si consiglia di eseguire esercizi di respirazione volti ad aumentare l'efficienza dei muscoli respiratori. |
Sensazione costante di stanchezza |
Adottano un approccio attendista, raccomandando riposo e rilassamento con un ritorno graduale all'attività fisica. Non vengono prescritti farmaci specifici per il trattamento. È possibile assumere preparati vitaminici sotto la supervisione di un medico. |
Temperatura elevata |
Vengono prescritti farmaci antipiretici, principalmente il paracetamolo. |
Sintomi neurologici |
Per il mal di testa si usa il paracetamolo, per altri disturbi si usano farmaci sintomatici. |
Raccomandazioni riguardanti l'attività fisica per chi è guarito dalla malattia:
Nessun segno di sindrome post-Covid |
Mantenere un'adeguata attività fisica. |
Sintomi lievi della sindrome post-Covid |
Mantenere un'attività fisica moderata, limitando i periodi sedentari. Evitare carichi prolungati ed estenuanti con un'intensità di allenamento elevata. |
Precedente infezione da coronavirus con decorso da lieve a moderato |
Aumentare gradualmente il carico, iniziando con esercizi di stretching (settimana 1) e allenamenti a bassa intensità. Se i sintomi peggiorano, prolungare il periodo di sospensione dell'esercizio. |
Il decorso del COVID-19 è accompagnato da dolori alle ossa e ai muscoli, alla gola e al petto, con tosse e febbre. |
Evitare allenamenti intensi per 3 settimane dopo la risoluzione dei sintomi. |
Linfopenia e necessità di ossigenazione |
Eseguire diagnosi di laboratorio e consulenze specialistiche prima di riprendere l'attività fisica. |
Complicazioni cardiovascolari |
Eseguire diagnosi di laboratorio e consulenze specialistiche prima di riprendere l'attività fisica. |
È molto importante stabilire una routine quotidiana adeguata per una persona che soffre di sindrome post-Covid. Il medico dovrebbe fornire consigli appropriati:
- interrompere l'uso di psicostimolanti (caffè, nicotina, alcol);
- sulla normalizzazione dell’alimentazione, sulla necessità di un graduale aumento dell’attività fisica e sulla garanzia dell’insolazione;
- sulle pratiche di gestione dello stress (riposo, sonno adeguato, rilassamento).
A molti pazienti viene consigliata una consulenza psicologica basata sulla terapia cognitivo-comportamentale.
Medicinali
In caso di sindrome post-Covid, i farmaci sintomatici vengono prescritti in base alle indicazioni individuali. In caso di febbre elevata che causa disagio, si prescrive Paracetamolo o Ibuprofene (1 compressa 2-3 volte al giorno). L'uso regolare di farmaci antipiretici è sconsigliato (può influire negativamente sulla salute del tratto digerente); la somministrazione ripetuta viene effettuata solo dopo il successivo aumento della temperatura. Sia Paracetamolo che Ibuprofene possono essere assunti sotto forma di compresse o supposte rettali. I medici consigliano di dare la preferenza a uno di questi farmaci e di non alternarli. Acido acetilsalicilico, Metamizolo e Nimesulide non devono essere utilizzati per abbassare la temperatura. [ 15 ]
In presenza di espettorato viscoso e difficile da espellere, si prescrivono agenti mucolitici ed espettoranti. Sono indicati ambroxolo, carbocisteina e acetilcisteina.
Ambroxolo |
La dose per adulti è di ½ compressa 2-3 volte al giorno, dopo i pasti. Il farmaco non deve essere assunto senza consultare un medico. Possibili effetti collaterali: diarrea, nausea, secchezza delle fauci, bruciore di stomaco. |
Carbocisteina |
Assumere 750 mg per via orale tre volte al giorno. Il farmaco è controindicato nei pazienti con ulcera gastrica e duodenale o glomerulonefrite cronica. Possibili effetti collaterali: dolore addominale, diarrea, nausea, reazioni allergiche. |
Acetilcisteina |
Assunto in una dose di 400-600 mg al giorno (bambini dai 2 anni in su: 200-300 mg al giorno), dopo i pasti. I possibili effetti collaterali includono nausea, diarrea, mal di testa, tachicardia, reazioni allergiche, broncospasmo. In caso di sindrome post-Covid, il farmaco deve essere assunto sotto stretto controllo medico. |
In caso di ostruzione bronchiale, si possono utilizzare broncodilatatori (ad esempio, salbutamolo). È preferibile praticare inalazioni a dosaggio, ma i nebulizzatori non devono essere utilizzati se non in caso di assoluta necessità.
La maggior parte delle persone guarite, comprese quelle con sindrome post-COVID, ha bisogno di ripristinare la microflora corporea. A tal fine, vengono prescritti probiotici, farmaci che contengono diversi ceppi di lattobatteri e bifidobatteri. Questi batteri benefici si trovano in qualsiasi prodotto a base di latte fresco fermentato, ma è possibile assumere probiotici aggiuntivi, ad esempio Linex, Bificol, Bactisubtil, Floristin. Anche la vitamina D è necessaria: si assume in dosi di 3-5 mila UI al giorno. [ 16 ]
In caso di disturbi neurologici, disturbi psico-emotivi, sono indicati sedativi e preparati contenenti aminoacidi essenziali. In particolare, viene prescritto il farmaco L-triptofano, che contiene un aminoacido necessario per la produzione di niacina, che a sua volta attiva la produzione di serotonina. Nonostante la relativa sicurezza di questo farmaco, solo un medico può prescriverlo. È sconsigliato assumere triptofano in caso di trattamento con inibitori delle monoamino ossidasi, poiché la combinazione di tali farmaci aumenta il rischio di eccitazione del sistema nervoso centrale. Si raccomanda cautela anche in caso di patologie renali ed epatiche. [ 17 ]
Prevenzione
Gli esperti raccomandano di non trascurare una visita medica dopo le dimissioni dall'ospedale, o dopo essersi sentiti meglio in caso di trattamento ambulatoriale. È inoltre sconsigliato tentare di riabilitarsi autonomamente. La quantità di aiuto necessaria può dipendere dalla gravità del COVID-19, dal rispetto delle raccomandazioni del medico curante e dalle caratteristiche individuali dell'organismo.
Anche dopo la prevista guarigione, non si dovrebbe evitare di eseguire esami clinici di controllo e analisi del sangue biochimiche. È fondamentale eseguire un coagulogramma e determinare l'indicatore del D-dimero. È importante ricordare che le complicanze più comuni dell'infezione da coronavirus sono le trombosi. Per questo motivo, è fondamentale conoscere e monitorare gli indicatori dell'emostasi, soprattutto se il paziente continua il trattamento con anticoagulanti.
Gli esami di laboratorio minimi richiesti dopo la guarigione includono anche la valutazione dei livelli di urea e creatinina, dell'equilibrio elettrolitico, dell'albumina, delle proteine (totali), delle transaminasi epatiche, della ferritina, della glicemia e della proteina C-reattiva. Naturalmente, un esame del sangue biochimico non sarà in grado di caratterizzare specificamente una malattia infettiva. Tuttavia, l'identificazione di eventuali anomalie consentirà al medico di individuare tempestivamente un malfunzionamento di determinati organi e valutare la probabilità di complicanze.
Se possibile, i medici raccomandano di sottoporsi a esami del sangue per valutare i livelli di vitamina D. Molti esperti parlano della relazione tra una carenza di questa vitamina e un alto rischio di sviluppare effetti avversi, tra cui la sindrome post-COVID. [ 18 ], [ 19 ], [ 20 ]
Previsione
Per valutare la prognosi della sindrome post-Covid, i risultati degli esami di laboratorio e della diagnostica strumentale sono importanti. Se al paziente vengono diagnosticate altre patologie (respiratorie, digestive, neurologiche, cerebrovascolari, cardiovascolari), la qualità della prognosi è notevolmente compromessa: tale paziente viene attentamente monitorato per il peggioramento delle sue condizioni. Anche le persone con uno o più fattori di rischio sono necessariamente monitorate. La decisione su dove verrà effettuata l'osservazione - in ospedale, in un istituto comunale o a domicilio - viene presa dal medico curante su base individuale per ogni specifico caso. Tale decisione può anche dipendere dai sintomi clinici, dalla necessità di un trattamento di supporto, dai fattori di rischio e dalla qualità delle condizioni ambulatoriali, ecc. Anche i bambini e le donne in gravidanza, le giovani madri nel periodo postpartum richiedono un monitoraggio speciale. [ 21 ]
Se la sindrome post-COVID procede con dinamiche positive, senza complicazioni evidenti, allora potremo parlare di un esito favorevole della patologia.

