Esperto medico dell'articolo
Nuove pubblicazioni
Metodi di ricerca del sistema nervoso autonomo
Ultima recensione: 07.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.
Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.
Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.

Nello studio del sistema nervoso autonomo, è importante determinarne lo stato funzionale. I principi dello studio dovrebbero basarsi su un approccio clinico e sperimentale, la cui essenza risiede nello studio funzionale e dinamico del tono, della reattività autonomica e del supporto autonomo all'attività. Il tono e la reattività autonomici forniscono un'idea delle capacità omeostatiche dell'organismo, mentre il supporto autonomo all'attività fornisce un'idea dei meccanismi adattativi. In presenza di disturbi autonomici, è necessario chiarire l'eziologia e la natura della lesione in ogni caso specifico. Determinare il livello di danno al sistema nervoso autonomo: soprasegmentale, segmentale; l'interesse predominante delle strutture cerebrali: LRC (rinencefalo, ipotalamo, tronco encefalico), altre strutture cerebrali, midollo spinale; formazioni vegetative parasimpatiche e simpatiche - catena simpatica, gangli, plessi, gangli parasimpatici; danno alle fibre simpatiche e parasimpatiche, in particolare ai loro segmenti pre- e postganglionari.
Studio del tono vegetativo
Per tono vegetativo (iniziale) intendiamo le caratteristiche più o meno stabili dello stato degli indicatori vegetativi durante il periodo di "riposo relativo", ovvero di veglia rilassata. Gli apparati regolatori che mantengono l'equilibrio metabolico, ovvero il rapporto tra il sistema simpatico e parasimpatico, contribuiscono attivamente a fornire tono.
Metodi di ricerca:
- questionari speciali;
- tabelle che registrano gli indicatori vegetativi oggettivi,
- una combinazione di questionari e dati oggettivi derivanti da uno studio dello stato vegetativo.
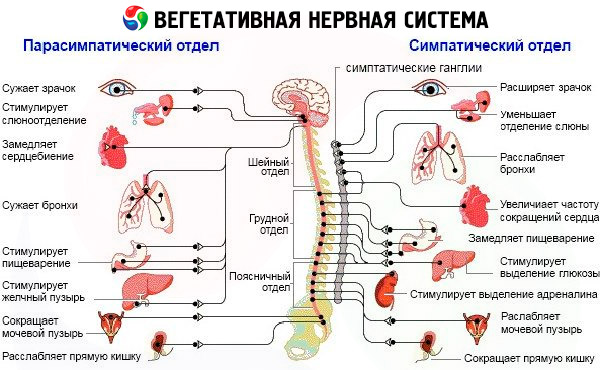
Studio della reattività autonomica
Le reazioni vegetative che si verificano in risposta a stimoli esterni e interni caratterizzano la reattività vegetativa. L'intensità della reazione (l'intervallo di fluttuazioni degli indicatori vegetativi) e la sua durata (il ritorno degli indicatori vegetativi al livello iniziale) sono significative.
Nello studio della reattività vegetativa, è necessario tenere conto della "legge del livello iniziale", secondo la quale quanto più alto è il livello iniziale, tanto più attivo e teso è il sistema o l'organo, tanto minore è la risposta possibile sotto l'azione di stimoli perturbatori. Se il livello iniziale subisce una brusca variazione, l'agente perturbatore può causare una reazione "paradossale" o antagonista di segno opposto, ovvero l'entità dell'attivazione è probabilmente correlata al livello pre-stimolo.
Metodi per lo studio della reattività vegetativa: farmacologica - somministrazione di una soluzione di adrenalina, insulina, mesatone, pilocarpina, atropina, istamina, ecc.; fisica - prove di freddo e caldo; azione sulle zone riflesse (pressione): riflesso oculocardico (Dagnini - Aschner), seno-carotideo (Tschermak, Hering), solare (Thomas, Roux), ecc.
Test farmacologici
Metodologia per l'esecuzione dei test con adrenalina e insulina. Lo studio viene condotto al mattino. In posizione orizzontale, dopo 15 minuti di riposo, vengono misurati la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca, ecc. del soggetto. Successivamente, vengono iniettati sottocute nella spalla 0,3 ml di una soluzione allo 0,1% di adrenalina o insulina alla dose di 0,15 U/kg. La pressione sanguigna, il polso e la respirazione vengono registrati 3; 10; 20; 30 e 40 minuti dopo l'iniezione di adrenalina e, dopo la somministrazione di insulina, gli stessi indicatori vengono registrati ogni 10 minuti per 1,5 ore. Abbiamo considerato fluttuazioni superiori a 10 mmHg come variazione della pressione sistolica e diastolica, un aumento o una diminuzione di 8-10 o più battiti al minuto come variazione della frequenza cardiaca e una variazione della respirazione di 3 o più al minuto.
Valutazione dei campioni. Sono stati identificati tre gradi di reattività autonomica: normale, aumentata, diminuita. Nel gruppo di individui sani, è stato riscontrato quanto segue:
- mancanza di risposta alla somministrazione di una sostanza farmacologica in 1/3 dei soggetti esaminati;
- reazione vegetativa parziale (debole), caratterizzata da una modifica di uno o due indicatori oggettivi (pressione sanguigna, polso o respirazione), talvolta in combinazione con lievi sensazioni soggettive o una modifica di tre indicatori oggettivi senza sensazioni soggettive - in 1/3 dei soggetti esaminati;
- reazione vegetativa pronunciata (aumentata), in cui si verifica un cambiamento in tutti e tre gli indicatori oggettivi registrati in combinazione con la manifestazione di disturbi soggettivi (sensazione di battito cardiaco, brividi, sensazione di tensione interna o, al contrario, debolezza, sonnolenza, vertigini, ecc.) - in 1/3 dei soggetti esaminati.
A seconda della natura dei cambiamenti vegetativi e delle sensazioni soggettive, si distinguono reazioni simpatico-surrenali, vago-insulari, miste e bifasiche (in queste ultime, la prima fase può essere simpatico-surrenale e la seconda parasimpatica, o viceversa).
Attività fisica
Metodologia per l'esecuzione del test del freddo. La pressione sanguigna e la frequenza cardiaca vengono misurate in posizione sdraiata. Quindi il soggetto immerge la mano dell'altra mano fino al polso in acqua a una temperatura di +4 °C e la mantiene per 1 minuto. La pressione sanguigna e la frequenza cardiaca vengono registrate immediatamente dopo l'immersione della mano in acqua, 0,5 e 1 minuto dopo l'immersione, e poi - dopo che la mano viene estratta dall'acqua - la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca vengono registrate fino al raggiungimento del livello iniziale. Se la frequenza cardiaca viene esaminata tramite ECG, viene contato il numero di onde R o intervalli RR negli intervalli di tempo specificati e il tutto viene ricalcolato in base alla frequenza cardiaca in 1 minuto.
Valutazione del test. Reattività vegetativa normale: aumento della pressione sistolica di 20 mmHg, diastolica di 10-20 mmHg dopo 0,5-1 min. Aumento massimo della pressione arteriosa: 30 sec dopo l'inizio del raffreddamento. Ritorno della pressione arteriosa al livello iniziale: dopo 2-3 min.
Deviazioni patologiche:
- ipereccitabilità dei vasi sanguigni (iperreattività) - forte aumento della pressione sanguigna sistolica e diastolica, cioè marcata reazione simpatica (aumento della reattività autonomica);
- diminuzione dell'eccitabilità dei vasi sanguigni (iporeattività) - leggero aumento della pressione sanguigna (aumento della pressione diastolica inferiore a 10 mm Hg), debole reazione simpatica (ridotta reattività autonomica);
- diminuzione della pressione sistolica e diastolica - reazione parasimpatica (o reazione perversa).
Pressione sulle zone riflesse
Riflesso oculocardiaco (Dagnini-Aschner). Tecnica di test: dopo 15 minuti di riposo, registrare l'ECG per 1 minuto con successivo conteggio della frequenza cardiaca per 1 minuto (rumore di fondo iniziale). Quindi premere su entrambi i bulbi oculari con la punta delle dita fino a quando non compare una leggera sensazione di dolore. È possibile utilizzare un oculocompressore di Barré (pressione 300-400 g). Dopo 15-25 secondi dall'inizio della pressione, registrare la frequenza cardiaca per 10-15 secondi utilizzando l'ECG. Contare il numero di onde R per 10 secondi e ricalcolare per 1 minuto.
È possibile registrare la frequenza cardiaca dopo che la pressione è cessata per altri 1-2 minuti. In questo caso, la frequenza cardiaca viene calcolata come l'aumento percentuale dell'intervallo RR durante gli ultimi 10 secondi di pressione sui bulbi oculari rispetto al valore medio degli intervalli RR calcolati su cinque segmenti RR di 10 secondi prima dell'inizio della pressione.
È anche possibile calcolare la frequenza cardiaca non tramite la registrazione ECG, ma tramite palpazione ogni 10 secondi per 30 secondi.
Interpretazione: rallentamento normale della frequenza cardiaca - reattività autonomica normale; forte rallentamento (reazione parasimpatica, vagale) - aumento della reattività autonomica; rallentamento debole - diminuzione della reattività autonomica; nessun rallentamento - reattività autonomica perversa (reazione simpatica).
Normalmente, dopo pochi secondi dall'inizio della pressione, la frequenza cardiaca rallenta di 6-12 battiti in un minuto. L'ECG mostra un rallentamento del ritmo sinusale.
Tutte le valutazioni dei test indicano sia l'intensità che la natura della reazione. Tuttavia, i dati digitali ottenuti durante l'esame di persone sane non sono gli stessi per i diversi autori, probabilmente per una serie di motivi (diversa frequenza cardiaca iniziale, diversi metodi di registrazione ed elaborazione). A causa della diversa frequenza cardiaca iniziale (più o meno di 70-72 battiti al minuto), è possibile calcolare utilizzando la formula di Galyu:
X = FCsp/FCsi x 100,
Dove HRsp è la frequenza cardiaca nel campione; HRsi è la frequenza cardiaca iniziale; 100 è il numero FC convenzionale.
Il rallentamento dell'impulso secondo la formula di Galu è uguale a: 100 - X.
Riteniamo opportuno assumere il valore M±a come norma, dove M è il valore medio della frequenza cardiaca in 1 minuto nel gruppo di studio; o è la deviazione standard da M. Se il valore è superiore a M+g, dovremmo parlare di aumento della reattività vegetativa (simpatica o parasimpatica), se il valore è inferiore, dovremmo parlare di diminuzione della reattività vegetativa. Riteniamo necessario eseguire calcoli in questo modo per altri test di reattività vegetativa.
Risultati dello studio della frequenza cardiaca in campioni di individui sani
Tentativo |
M±a |
Riflesso oculocardiaco |
-3,95 ± 3,77 |
Riflesso del seno carotideo |
4,9 ± 2,69 |
Riflesso solare |
-2,75 ± 2,74 |
Riflesso seno-articolare carotideo (Tschermak-Gering). Tecnica di prova: dopo 15 minuti di adattamento (riposo) in posizione supina, contare la frequenza cardiaca in 1 minuto (registrazione ECG - 1 minuto) - il valore iniziale. Quindi, alternativamente (dopo 1,5-2 secondi), premere con le dita (indice e pollice) sulla zona del terzo superiore del muscolo sternoclaidomastoideo, leggermente al di sotto dell'angolo della mandibola, fino a percepire la pulsazione dell'arteria carotide. Si raccomanda di iniziare la pressione sul lato destro, poiché l'effetto irritativo a destra è più forte che a sinistra. La pressione deve essere leggera, non dolorosa, per 15-20 secondi; dal 15° secondo, iniziare a registrare la frequenza cardiaca tramite ECG per 10-15 secondi. Quindi interrompere la pressione e calcolare la frequenza cardiaca al minuto in base alla frequenza delle onde R dell'ECG. Il calcolo può essere effettuato in base all'intervallo RR, come nello studio del riflesso oculocardiaco. Lo stato di post-effetto può essere registrato anche a 3 e 5 minuti dalla sospensione della pressione. A volte vengono registrati anche la pressione arteriosa e la frequenza respiratoria.
Interpretazione: i valori ottenuti da soggetti sani sono considerati normali variazioni della frequenza cardiaca, cioè normale reattività autonomica.
Valori superiori a questo valore indicano un aumento della reattività vegetativa, ovvero un'attività parasimpatica aumentata o un'attività simpatica insufficiente, mentre valori inferiori indicano una diminuzione della reattività vegetativa. Un aumento della frequenza cardiaca indica una reazione distorta. Secondo altri autori [Rusetsky II, 1958; Birkmayer W., 1976 e altri], la norma è considerata un rallentamento della frequenza cardiaca dopo 10 secondi - 12 battiti al minuto, una diminuzione della pressione arteriosa fino a 10 mm, un rallentamento della frequenza respiratoria e talvolta un aumento dell'onda T sull'ECG di almeno 1 mm.
Deviazioni patologiche: rallentamento improvviso e significativo della frequenza cardiaca senza calo della pressione sanguigna (tipo vagocardico); forte calo della pressione sanguigna (superiore a 10 mm Hg) senza rallentamento del polso (tipo depressore); vertigini, svenimenti senza variazione della pressione sanguigna o del polso o con variazioni di questi indicatori (tipo cerebrale) - aumento della pressione sanguigna [Birkmayer W., 1976]. Pertanto, è consigliabile calcolare i valori di M±a.
Riflesso solare - riflesso epigastrico (Toma, Roux). Tecnica del test: a riposo, in posizione supina con muscoli addominali rilassati, si registra l'ECG prima del test (sfondo); la frequenza cardiaca viene determinata dagli intervalli RR dell'ECG. È possibile anche esaminare la pressione arteriosa (indicatori di sfondo iniziali). Si esercita una pressione sul plesso solare con una mano fino a percepire la pulsazione dell'aorta addominale.
A 20-30 secondi dall'inizio della pressione, la frequenza cardiaca viene nuovamente registrata per 10-15 secondi tramite un ECG. La frequenza cardiaca viene calcolata in base al numero di onde R sull'ECG per 10 secondi e ricalcolata al minuto. Il calcolo può essere effettuato in base all'intervallo RR, come per lo studio del riflesso oculocardiaco (vedi sopra).
Interpretazione: il valore M±o viene considerato come norma. Si determina il grado di espressione - normale, aumentata o espressa, diminuita o alterata - e la natura della reazione - simpatica, vagale o parasimpatica.
Secondo II Rusetsky (1958), W. Birkmayer (1976), si notano diversi tipi di reazione:
- il riflesso è assente o invertito (il polso non viene rallentato o accelerato a sufficienza) - reazione di tipo simpatico;
- riflesso positivo - rallentamento di oltre 12 battiti al minuto - tipo parasimpatico;
- rallentamento di 4-12 battiti al minuto - tipo normale.
Nei test di reattività è possibile calcolare i coefficienti indicati nello studio del tono vegetativo. I risultati ottenuti nei test forniscono un'idea dell'intensità, del carattere e della durata delle reazioni vegetative, ovvero della reattività delle divisioni simpatica e parasimpatica del SNA.
Ricerca del supporto vegetativo dell'attività
Lo studio del supporto vegetativo di varie forme di attività fornisce anche informazioni importanti sullo stato del sistema nervoso vegetativo, poiché le componenti vegetative sono un accompagnamento obbligatorio di qualsiasi attività. Chiamiamo la loro registrazione "studio del supporto vegetativo dell'attività".
Gli indicatori di supporto vegetativo ci permettono di valutare l'adeguatezza del supporto vegetativo di un comportamento. Normalmente, è strettamente correlato alla forma, all'intensità e alla durata dell'azione.
Metodi di studio del supporto vegetativo dell'attività
In fisiologia clinica, lo studio del supporto vegetativo viene effettuato utilizzando la modellazione sperimentale dell'attività:
- attività fisica dosata: cicloergometro, camminata dosata, sollevamento delle gambe in posizione orizzontale a 30-40° per un certo numero di volte in un certo lasso di tempo, test Master in due fasi, squat dosati, distensione su panca dinamometrica fino a 10-20 kg, ecc.;
- test di posizione - passaggio dalla posizione orizzontale a quella verticale e viceversa (test ortoclinostatico);
- mentale - aritmetica mentale (semplice - sottrarre 7 da 200 e complessa - moltiplicare numeri di due cifre per numeri di due cifre), composizione di parole, ad esempio 7 parole con 7 lettere, ecc.;
- emotivo - modellazione delle emozioni negative: minaccia di scossa elettrica, riproduzione di situazioni emotive negative vissute in passato o induzione speciale di emozioni negative associate alla malattia, induzione di stress emotivo utilizzando il metodo Kurt Lewin, ecc. Modellazione delle emozioni positive in diversi modi, ad esempio, parlando di un buon esito della malattia, ecc. Per registrare i turni vegetativi, vengono utilizzati i seguenti parametri: sistema cardiovascolare: frequenza cardiaca, variabilità PC, pressione sanguigna, indicatori REG, pletismografia, ecc.; sistema respiratorio - frequenza respiratoria, ecc.; vengono studiati il riflesso galvanico cutaneo (GSR), il profilo ormonale e altri parametri.
I parametri studiati vengono misurati a riposo (tono vegetativo iniziale) e durante l'attività. L'aumento del parametro durante questo periodo viene valutato come supporto vegetativo II all'attività. Interpretazione: i dati ottenuti vengono interpretati come supporto vegetativo normale (gli sbalzi sono gli stessi del gruppo di controllo), eccessivo (gli sbalzi sono più intensi rispetto al gruppo di controllo), insufficiente (gli sbalzi sono meno pronunciati rispetto al gruppo di controllo).
L'attività è fornita principalmente dal sistema ergotropico. Pertanto, lo stato dei dispositivi ergotropici è stato valutato in base al grado di deviazione dai dati iniziali.
Studio del supporto vegetativo nel test ortoclinostatico. Questo test è stato descritto da molti autori [Rusetsky II, 1958; Chetverikov NS, 1968 e altri] e presenta diverse modifiche basate sul test emodinamico di Shelong. Ne forniremo solo due varianti. La prima variante (classica) è descritta nel manuale di W. Birkmayer (1976); la seconda variante, a cui abbiamo aderito di recente, consiste nell'eseguire il test ed elaborare i risultati ottenuti utilizzando il metodo proposto da Z. Servit (1948).
Consideriamo i test ortoclinostatici, eseguiti attivamente e non con l'ausilio di un giradischi, non solo come test emodinamici, ma anche come test di supporto vegetativo dell'attività, cioè spostamenti vegetativi che assicurano il passaggio da una posizione all'altra e poi il mantenimento della nuova posizione.
Metodo della prima variante. A riposo e in posizione orizzontale, vengono misurate la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna. Quindi il paziente si alza lentamente, senza movimenti inutili, e si posiziona in una posizione comoda vicino al letto. Immediatamente in posizione verticale, vengono misurati il polso e la pressione sanguigna, e questa misurazione viene ripetuta a intervalli di un minuto per 10 minuti. Il soggetto può rimanere in posizione verticale da 3 a 10 minuti. Se al termine del test compaiono alterazioni patologiche, è necessario continuare le misurazioni. Al paziente viene chiesto di sdraiarsi nuovamente; subito dopo, la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca vengono misurate a intervalli di un minuto fino al raggiungimento del valore iniziale.
Interpretazione. Reazioni normali (normale supporto vegetativo dell'attività): in posizione eretta - un aumento a breve termine della pressione sistolica a 20 mmHg, in misura minore della pressione diastolica e un aumento transitorio della frequenza cardiaca a 30 al minuto. In posizione eretta, la pressione sistolica può talvolta diminuire (di 15 mmHg al di sotto del livello iniziale o rimanere invariata), la pressione diastolica rimane invariata o aumenta leggermente, cosicché l'ampiezza della pressione rispetto al livello iniziale può diminuire. La frequenza cardiaca in posizione eretta può aumentare fino a 40 al minuto rispetto al livello iniziale. Dopo il ritorno alla posizione iniziale (orizzontale), la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca dovrebbero tornare al livello iniziale in 3 minuti. Un aumento a breve termine della pressione può verificarsi subito dopo la posizione sdraiata. Non ci sono disturbi soggettivi.
La violazione del supporto vegetativo dell'attività si manifesta con i seguenti sintomi:
- Un aumento della pressione sistolica superiore a 20 mm Hg.
- Anche la pressione diastolica aumenta, a volte in modo più significativo della pressione sistolica, in altri casi diminuisce o rimane allo stesso livello;
- Aumento indipendente della sola pressione diastolica in posizione eretta;
- Aumento della frequenza cardiaca in posizione eretta di oltre 30 al minuto;
- Quando ti alzi in piedi, potresti avvertire un afflusso di sangue alla testa e un offuscamento della vista.
Tutti i cambiamenti sopra descritti indicano un eccessivo supporto vegetativo.
- Calo transitorio della pressione sistolica di oltre 10-15 mmHg subito dopo essersi alzati in piedi. Contemporaneamente, la pressione diastolica può aumentare o diminuire contemporaneamente, riducendo significativamente l'ampiezza della pressione (pressione pulsatoria). Disturbi: barcollamento e sensazione di debolezza quando ci si alza in piedi. Questi fenomeni sono interpretati come un supporto vegetativo insufficiente.
- In posizione eretta, la pressione sistolica scende di oltre 15-20 mm Hg rispetto al livello iniziale. La pressione diastolica rimane invariata o aumenta leggermente: un disturbo della regolazione ipotonica, che può anche essere considerato un supporto vegetativo insufficiente, può essere considerato un disturbo dell'adattamento. Anche un calo della pressione diastolica (regolazione ipodinamica secondo W. Birkmayer, 1976) può essere considerato allo stesso modo. Una riduzione dell'ampiezza della pressione arteriosa rispetto al livello iniziale di oltre 2 volte indica non solo disturbi della regolazione, ma anche, a nostro avviso, un disturbo del supporto vegetativo.
- Un aumento della frequenza cardiaca in stazione eretta di oltre 30-40 battiti al minuto a pressione arteriosa relativamente invariata rappresenta un supporto vegetativo eccessivo (disturbo regolatorio tachicardico secondo W. Birkmayer, 1976). Può verificarsi tachipnea ortostatica.
Alterazioni dell'ECG durante il test ortoclinostatico: aumento della frequenza sinusale, aumento dell'onda P nelle derivazioni standard II e III, riduzione dell'intervallo ST e appiattimento o onda T negativa nelle derivazioni II e III. Questi fenomeni possono verificarsi immediatamente dopo la stazione eretta o durante una stazione eretta prolungata. Le alterazioni ortostatiche possono essere osservate in persone sane. Non indicano un difetto cardiaco: si tratta di una violazione dell'apporto vegetativo associata a simpaticotonia (irrorazione eccessiva).
Le regole per passare alla posizione sdraiata e per rimanere nella posizione sdraiata sono le stesse.
Metodo della seconda variante. Dopo 15 minuti di riposo in posizione orizzontale, si misura la pressione arteriosa del soggetto e si registra la frequenza cardiaca registrando l'ECG per 1 minuto. Il soggetto si alza con calma in posizione verticale, operazione che richiede circa 8-10 secondi. Successivamente, si registra nuovamente l'ECG in posizione verticale per 1 minuto, registrando la pressione arteriosa. Quindi, al 3° e 5° minuto di stazione eretta, si registra l'ECG per 20 secondi e, agli stessi intervalli di tempo, si misura la pressione arteriosa. Quindi il soggetto si sdraia (test clinostatico) e si registrano nuovamente gli stessi indici vegetativi secondo il metodo sopra descritto, negli stessi intervalli di tempo. La frequenza cardiaca viene registrata contando le onde R dell'ECG a intervalli di 10 secondi.
I dati ottenuti durante l'intervallo di minuti dei test ortostatici e clinostatici vengono elaborati secondo Z. Servit (1948). Vengono calcolati i seguenti indicatori:
1. Accelerazione ortostatica media al minuto (AOA). È pari alla somma dell'aumento relativo alla frequenza cardiaca iniziale nei primi 10 secondi del minuto, nel secondo e nel sesto, diviso per 3:
SOU = 1 + 2 + 6 / 3
L'indice di labilità ortostatica (OLI) è la differenza tra la frequenza cardiaca più alta e quella più bassa nella posizione ortostatica per 1 minuto (selezionato tra sei intervalli di 10 secondi del primo minuto), ovvero l'intervallo minimo di fluttuazioni della frequenza cardiaca nel test ortostatico.
La decelerazione clinostatica (CD) è la massima decelerazione della frequenza cardiaca entro 1 minuto in posizione sdraiata dopo essere passati da una posizione verticale.
La differenza ortoclinostatica (OCD) è la differenza tra la massima accelerazione e la massima decelerazione durante i test orto- e clinostatici (il calcolo viene eseguito anche per sei intervalli di 10 secondi in 1 minuto del test).
L'indice di labilità clinostatica (CIL) è la differenza tra il massimo e il minimo rallentamento della frequenza cardiaca durante un test clinostatico (selezionato su intervalli di 10 secondi di 1 minuto in posizione orizzontale). L'intero calcolo viene eseguito entro 1 minuto in posizione eretta e sdraiata, quindi vengono calcolati la frequenza cardiaca al 3° e 5° minuto e il valore della pressione arteriosa. I valori di M±a ottenuti in soggetti sani a diversi intervalli di tempo dei test specificati sono considerati come valori normali.
Uno studio dinamico dello stato del sistema nervoso autonomo fornisce un'idea del suo tono autonomo iniziale (determinato dallo stato delle formazioni autonome periferiche), della reattività autonoma e del supporto autonomo all'attività, che è determinato dallo stato dei sistemi soprasegmentali del cervello che organizzano il comportamento adattivo.
Oltre al metodo funzionale-dinamico sopra descritto, ampiamente utilizzato dai medici con la registrazione di parametri specifici per caratterizzare lo stato del sistema nervoso autonomo a riposo e sotto carico, viene utilizzato il REG, che fornisce informazioni indirette sull'entità del riempimento sanguigno pulsatile, sullo stato della parete vascolare dei vasi principali, sulla velocità relativa del flusso sanguigno e sul rapporto tra circolazione arteriosa e venosa. Gli stessi problemi vengono risolti con l'aiuto della pletismografia: un aumento dell'oscillazione, ovvero la dilatazione dei vasi sanguigni, viene valutato come una diminuzione delle influenze simpatiche; una diminuzione dell'oscillazione, ovvero una tendenza alla costrizione, come un loro aumento. L'ecografia dopplerologica (USDG) indica lo stato del letto vascolare, che riflette anch'esso indirettamente lo stato del sistema nervoso autonomo.
Studio dell'eccitabilità neuromuscolare
I test oggettivi più comunemente utilizzati sono:
Indurre la sintomatologia di Chvostek a riposo e dopo 5 minuti di iperventilazione. L'induzione della sintomatologia di Chvostek si effettua colpendo il martello neurologico nel punto lungo la linea mediana che collega l'angolo della bocca al lobo dell'orecchio. Il grado di espressione viene misurato:
- I grado - riduzione della commessura labiale;
- II grado - aggiunta di riduzione dell'ala del naso;
- III grado - oltre ai fenomeni sopra descritti, si contrae il muscolo orbicolare dell'occhio;
- Grado IV: forte contrazione dei muscoli dell'intera metà del viso.
L'iperventilazione per 5 minuti porta a un chiaro aumento del grado di espressione [Аlаjouianine Th. et al., 1958; Klotz HD, 1958]. Tra le persone sane, un sintomo di Chvostek positivo si verifica nel 3-29%. Nella tetania neurogena, è positivo nel 73% dei casi.
Test del manicotto (sintomo di Trousseau). Tecnica: un laccio emostatico arterioso o un manicotto pneumatico viene applicato alla spalla del paziente per 5-10 minuti. La pressione nel manicotto deve essere mantenuta a 5-10 mmHg al di sopra della pressione sistolica del paziente. Quando la compressione viene rimossa nella fase postischemica, si verificano spasmi carpo-podalici, il fenomeno della "mano dell'ostetrico". La frequenza del sintomo di Trousseau nella tetania varia dal 15 al 65%. Indica un elevato livello di eccitabilità neuromuscolare periferica.
Test di Trousseau-Bonsdorff. Tecnica: un manicotto pneumatico viene posizionato sulla spalla del paziente e la pressione viene mantenuta per 10 minuti a un livello di 10-15 mmHg superiore alla pressione sistolica del paziente, causando ischemia del braccio. Nella seconda metà del periodo ischemico, si aggiunge iperventilazione (massime inspirazioni ed espirazioni profonde a una frequenza di 18-20 al minuto) per 5 minuti. Risultati del test: debolmente positivo: comparsa di fascicolazioni visibili nei muscoli interossei, soprattutto nell'area del primo spazio interfalangeo, alterazione della forma della mano (tendenza a sviluppare una "mano da ostetrico"); positivo: quadro pronunciato di spasmo carpo-podalico; negativo: assenza dei fenomeni sopra descritti.
Studio elettromiografico. Durante lo studio EMG, viene registrato un certo tipo di attività elettrica dei muscoli coinvolti nello spasmo tetanico. L'attività è caratterizzata da potenziali successivi (doppietti, tripletti, multipletti) che si verificano durante brevi intervalli di tempo (4-8 ms) con una frequenza di 125-250 pps. Tali potenziali e altri fenomeni EMG si verificano durante il periodo di studio utilizzando test provocativi.
Altri test che rivelano l'eccitabilità neuromuscolare: la sindrome del gomito di Bechterew, il sintomo di Schlesinger, il sintomo del rullo muscolare, ma sono meno informativi e vengono utilizzati meno spesso.
Metodi di studio della sindrome da iperventilazione
- Analisi delle sensazioni soggettive (disturbi) caratterizzate dalla polisistemicità e dalla connessione dei disturbi con la funzione respiratoria.
- Presenza di disturbi respiratori durante o all'inizio della malattia.
- Risultati positivi del test di iperventilazione.
- Test di eccitabilità neuromuscolare.
- La possibilità di interrompere un parossismo di iperventilazione inalando una miscela d'aria contenente il 5% di CO2, oppure respirando "in un sacchetto" (di carta o polietilene) per accumulare la propria CO2, con l'aiuto del quale l'attacco viene interrotto.
- Il paziente presenta ipocapnia nell'aria alveolare e alcalosi nel sangue.
Tecnica del test di iperventilazione: il paziente è in posizione orizzontale o semi-sdraiato (su una sedia). Inizia a respirare profondamente a una frequenza di 16-22 respiri al minuto. Il test dura, a seconda della tolleranza, dai 3 ai 5 minuti. Un test di iperventilazione positivo presenta due varianti di progressione. La prima variante: durante il test si verificano alterazioni emotive, vegetative, tetaniche e di altro tipo, che scompaiono 2-3 minuti dopo il suo completamento. La seconda variante: l'iperventilazione porta allo sviluppo di un parossismo vegetativo, che, iniziato durante il test, continua anche dopo la sua conclusione. La transizione dal test a un parossismo conclamato si osserva inizialmente nella respirazione: il soggetto non riesce a interrompere l'iperventilazione e continua a respirare frequentemente e profondamente. La difficoltà respiratoria è accompagnata da disturbi vegetativi, muscolo-tonici ed emozionali. È generalmente accettato che la comparsa di sensazioni soggettive durante il test simili a quelle che insorgono spontaneamente sia un criterio positivo per stabilire una diagnosi di sindrome da iperventilazione.
A partire dai 50 anni, il test deve essere eseguito con cautela. Le controindicazioni sono l'ipertensione, la presenza di patologie cardiache e polmonari e l'aterosclerosi grave.
Ulteriori metodi per studiare lo stato funzionale del sistema nervoso
Ricerca delle caratteristiche emotive e personali
I disturbi vegetativi, soprattutto a livello cerebrale, sono psicovegetativi. Pertanto, in caso di disturbi vegetativi, è necessario esaminare la sfera mentale. Uno dei metodi per studiarli è uno studio dettagliato della psicoanamnesi, che indichi la presenza di traumi psicologici infantili e attuali. L'analisi clinica dei disturbi emotivi è importante. L'esame psicologico viene effettuato utilizzando vari metodi: il metodo dello studio multifattoriale della personalità (MIP) modificato da F.B. Berezina e M.I. Miroshnikov (1976), i test di Spielberger, Eysenck e Cattell, nonché il test proiettivo di Rorschach, il test di appercezione tematica (TAT), il test delle frasi incomplete, il test di Rosenzweig (test della frustrazione), ecc. I test più informativi nello studio dei disturbi vegetativi sono MIP, Spielberger e Cattell.
Studi elettrofisiologici
L'EEG viene utilizzato non solo per chiarire la localizzazione del processo e, in alcuni casi, la sua natura (scariche generalizzate ipersincrone epilettiche), ma anche per studiare lo stato funzionale dei sistemi di attivazione e disattivazione non specifici del cervello durante il sonno, nella veglia rilassata e tesa, che è modellato da vari carichi: iperventilazione, stimolazione luminosa e sonora, stress emotivo, carico mentale, ecc.
Il metodo più comune per testare sistemi cerebrali non specifici è la registrazione poligrafica di EEG, ECG, GSR, EMG e frequenza respiratoria. Le variazioni di questi indicatori riflettono le relazioni tra i sistemi di attivazione ascendenti e discendenti (Mi). La relazione e lo stato dei sistemi cerebrali de-sincronizzati (formazione reticolare del tronco encefalico) e sincronizzati (sistema talamo-corticale) vengono valutati mediante l'analisi visiva e computerizzata dell'EEG (calcolo dell'indice α, dell'indice di sincronizzazione attuale, ecc.). Durante il sonno, i dati EEG consentono di ottenere informazioni sulle caratteristiche della rappresentazione delle varie fasi del sonno, sui loro periodi di latenza, sui cicli del sonno e sull'attività motoria (SMA).
Negli ultimi anni, l'uso della tecnologia informatica ha ampliato significativamente le possibilità della ricerca neurofisiologica. L'utilizzo del metodo della media ha permesso di isolare i potenziali evento-correlati dall'EEG spontaneo, principalmente quelli causati da stimoli sensoriali e motori.
Lo studio dei potenziali evocati somatosensoriali consente quindi una valutazione efficace e differenziata dello stato funzionale dei diversi livelli dei sistemi afferenti specifici e aspecifici.
Lo studio dei meccanismi di organizzazione dell'azione e dei sistemi effettori consente di registrare il potenziale motorio associato all'esecuzione di movimenti volontari e che riflette sia i processi generali di organizzazione dell'azione e di presa di decisione, sia i meccanismi più locali di attivazione dei motoneuroni corticali.
La registrazione della deviazione negativa contingente (CND) viene utilizzata per studiare i meccanismi dell'attenzione diretta, della motivazione e della previsione probabilistica, consentendoci di valutare lo stato di sistemi cerebrali non specifici.
Lo studio delle caratteristiche dei meccanismi di organizzazione topografica dell'attività cerebrale è possibile con l'aiuto della costruzione di mappe spettrali dell'EEG spontaneo.
L'analisi spettrale compressa (CSA), che utilizza l'algoritmo della trasformata di Fourier veloce, consente di determinare la potenza spettrale dei ritmi EEG e la loro reattività a diversi carichi funzionali, fornendo anche informazioni sullo stato di sistemi cerebrali non specifici. Inoltre, l'EEG CSA rivela la natura dell'interazione interemisferica (asimmetria interemisferica) coinvolta nelle reazioni adattive.
 [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ]
[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ]
Studio delle funzioni ormonali e neuroumorali
I disturbi vegetativi sono spesso associati a disturbi neuroendocrino-metabolici. Sono basati su alterazioni dei rapporti neuroormonali e neuroumorali (dovuti a cambiamenti nella mediazione dei neurotrasmettitori), che a loro volta sono indicatori delle capacità adattive dell'organismo e dello stato dei sistemi ergo- e trofotropico.
In alcuni casi è necessario esaminare sia il profilo ormonale che i rapporti neuroumorali: funzione tiroidea (metabolismo basale mediante il metodo complesso di assorbimento radioisotopico di I), stato del sistema ipotalamo-ipofisi-corteccia surrenale (determinazione dei corticosteroidi e dei loro metaboliti nel sangue e nelle urine), esame della funzione ovarica (temperatura rettale, sintomo pupillare, CII, profilo ormonale), metabolismo dei carboidrati, delle proteine, dell'acqua e dei sali, ecc.
Per studiare lo stato delle relazioni neuroumorali, si determina nel sangue, nelle urine e nel liquido cerebrospinale il contenuto di catecolamine (adrenalina, noradrenalina, dopamina, DOPA e loro metaboliti), di acetilcolina e dei suoi enzimi, di istamina e dei suoi enzimi (diammino ossidasi), l'effetto istaminopexico (HPE) della serotonina mediante escrezione di 5-OIAC nelle urine.
Allo stesso tempo, questi indicatori possono essere utilizzati per valutare lo stato dei sistemi LRK sia specifici che non specifici, nonché la reazione degli apparati ergo- e trofotropici centrali e dei sistemi vegetativi periferici.
Gli studi umorali (elettrolitici) di sodio, potassio, calcio totale, fosforo inorganico, cloro, anidride carbonica e magnesio aiutano a identificare la tetania neurogena latente. Vengono determinati coefficienti che indicano il rapporto tra ioni monovalenti (sodio, potassio) e bivalenti (calcio, magnesio). La sindrome da tetania neurogena (NTS) è prevalentemente normocalcemica, ma presenta una relativa tendenza all'ipocalcemia. Nei pazienti con NTS, il coefficiente che riflette la predominanza di ioni monovalenti rispetto a quelli bivalenti è significativamente aumentato.
Studio delle funzioni della divisione segmentale del sistema nervoso autonomo
Lo sviluppo della didattica moderna sulla patologia del sistema nervoso autonomo ha richiesto una revisione dei vecchi approcci metodologici e lo sviluppo di nuovi metodi di ricerca. I metodi attualmente sviluppati impongono requisiti specifici. I test per la ricerca sul sistema nervoso autonomo devono essere:
- sufficientemente informativo riguardo alla disfunzione autonomica (valutazione quantitativa dei risultati);
- specifici, con risultati ben riproducibili in studi ripetuti (il coefficiente di variazione non deve superare il 20-25%); 3) fisiologicamente e clinicamente affidabili (sicuri);
- non invasivo;
- facile e veloce da eseguire.
Sono ancora pochi i test che soddisfano questi requisiti.
I metodi sviluppati per lo studio del sistema nervoso autonomo nei sistemi cardiovascolare, sudomotorio e pupillare soddisfano i requisiti sopra menzionati più di altri e pertanto stanno entrando più rapidamente nella pratica clinica.
Lo studio dei disturbi vegetativi segmentali dovrebbe essere condotto tenendo conto non solo della localizzazione della lesione, ma anche dei sintomi indicativi della perdita o dell'irritazione delle formazioni vegetative periferiche. È necessario, se possibile, determinarne la natura (simpatica o parasimpatica). È auspicabile chiarire l'interesse di una determinata parte dell'arco vegetativo: afferente o efferente.
Alcuni dei metodi utilizzati possono fornire informazioni sui dispositivi vegetativi soprasegmentali, registrando il tono vegetativo iniziale, la reattività vegetativa e il supporto vegetativo dell'attività; inoltre, è possibile ottenere informazioni sullo stato delle parti segmentali del sistema nervoso vegetativo.
Sistema cardiovascolare
Metodi per determinare lo stato della via efferente simpatica
- Determinazione delle variazioni della pressione arteriosa associate al passaggio alla posizione eretta. Viene calcolata la differenza di pressione arteriosa sistolica in posizione sdraiata e al terzo minuto dopo il passaggio alla posizione eretta.
Interpretazione: un calo della pressione sanguigna sistolica non superiore a 10 mm Hg è una reazione normale, che indica l'integrità delle fibre vasocostrittrici efferenti; un calo di 11-29 mm Hg è una reazione borderline; un calo di 30 mm Hg o più è una reazione patologica, che indica un'insufficienza simpatica efferente.
- Determinazione delle variazioni della pressione arteriosa durante il carico isometrico. Utilizzando un dinamometro, determinare la forza massima con una mano. Quindi, per 3 minuti, il paziente preme il dinamometro con una forza pari al 30% del massimo. Calcolare la differenza di pressione arteriosa diastolica nel terzo minuto di pressione del dinamometro e prima dell'esecuzione del carico, a riposo.
Interpretazione: un aumento della pressione diastolica superiore a 16 mm Hg è una reazione normale; un aumento di 10-15 mm Hg è una reazione borderline; un aumento inferiore a 10 mm Hg è una reazione patologica, indicativa di insufficienza simpatica efferente.
- Valutazione dello stato delle fibre simpatiche vasocostrittrici efferenti. A tale scopo, vengono utilizzati alcuni test basati sulla registrazione del pletismogramma della mano o dell'avambraccio:
- La presentazione di stress mentale, uno stimolo doloroso o un rumore improvviso causano normalmente una diminuzione del riempimento sanguigno della mano e un aumento della pressione arteriosa dovuto alla vasocostrizione periferica. L'assenza di variazioni nel riempimento sanguigno e nella pressione arteriosa indica un danno alle fibre simpatiche efferenti che vanno ai vasi cutanei;
- Quando si esegue la manovra di Valsalva o il test di rotazione sulla sedia di Barany, si verifica normalmente una diminuzione del riempimento ematico a causa dell'aumentata vasocostrizione. L'assenza di variazioni nel riempimento ematico indica un danno ai vasocostrittori periferici simpatici;
- Un respiro profondo e acuto provoca una costrizione riflessa dei vasi degli avambracci. In questo test, la reazione si basa su un riflesso spinale, le cui vie afferenti sono sconosciute, mentre le vie efferenti sono costituite da fibre vasocostrittrici simpatiche. L'assenza di una diminuzione del riempimento sanguigno in questo test indica anche un'insufficienza efferente simpatica;
- Durante gli squat e i sollevamenti passivi delle gambe in posizione prona, il pletismografo mostra un aumento del riempimento sanguigno dovuto a una diminuzione della vasocostrizione. Quando le fibre vasocostrittrici simpatiche che vanno ai vasi dei muscoli scheletrici sono danneggiate, non si verificano alterazioni nel riempimento sanguigno.
È importante notare che i test sopra descritti che utilizzano la pletismografia non presentano chiari confini quantitativi tra norma e patologia, e pertanto il loro utilizzo nella medicina generale è limitato. Tuttavia, i risultati ottenuti nel gruppo di soggetti possono essere confrontati con i dati del gruppo di controllo.
- Test farmacologici:
- Determinazione dei livelli plasmatici di noradrenalina (NA): i livelli plasmatici di noradrenalina sono mantenuti dal rilascio dalle terminazioni nervose simpatiche e dalla midollare del surrene. Poiché la quantità di neurotrasmettitore rilasciata nel sangue è proporzionale all'attività del sistema nervoso simpatico, i livelli plasmatici di noradrenalina possono essere utilizzati come indice dell'attività nervosa simpatica. Si ritiene che la riduzione dei livelli plasmatici di noradrenalina sia dovuta a un rilascio anomalo dalle terminazioni efferenti simpatiche nei vasi sanguigni piuttosto che a modifiche nel suo assorbimento o diffusione attraverso la barriera ematoencefalica o altre membrane. In un individuo sano, i livelli plasmatici di noradrenalina rimangono costanti in posizione supina e aumentano bruscamente quando l'individuo assume una posizione verticale. Nelle posizioni centrali del sistema nervoso autonomo, esiste un certo livello plasmatico di noradrenalina che non cambia quando l'individuo assume una posizione verticale. Nelle lesioni periferiche (neuroni simpatici postganglionari), il livello di noradrenalina in posizione supina è nettamente ridotto e non aumenta durante il test ortostatico. Pertanto, è possibile differenziare le lesioni preganglionari da quelle postganglionari:
- Test della tiramina: la tiramina rilascia noradrenalina e dopamina dalle vescicole presinaptiche postganglionari. Un aumento insufficiente della noradrenalina plasmatica (catecolamine) dopo la somministrazione di tiramina indicherebbe una carenza nella capacità del neurone postganglionare di rilasciare noradrenalina, ovvero un difetto simpatico postganglionare distale;
- Test della noradrenalina: la somministrazione endovenosa di piccole dosi di noradrenalina causa un gran numero di effetti cardiovascolari in una persona sana, tra cui un aumento della pressione arteriosa sistemica. In alcuni pazienti con danno autonomico, si verifica una risposta pressoria esagerata a causa della cosiddetta ipersensibilità alla denervazione che si verifica con la distruzione delle terminazioni nervose presinaptiche. Al contrario, la denervazione completa porta a una risposta pressoria arteriosa inferiore alla norma in questo test;
- Test dell'Anaprilina: l'assenza di rallentamento della frequenza cardiaca con la somministrazione endovenosa di Anaprilina (non più di 0,2 mg/kg) indica un danno ai nervi simpatici che vanno al cuore.
- Registrazione dei potenziali d'azione dei nervi periferici simpatici diretti ai vasi cutanei, ai muscoli striati e alle ghiandole sudoripare. Un moderno metodo elettrofisiologico che, utilizzando la più recente tecnologia dei microelettrodi, consente di registrare l'attività neuronale dei nervi autonomi periferici, di determinare i periodi di latenza delle risposte autonomiche per diversi tipi di stimoli e di calcolare la velocità di conduzione dell'eccitazione lungo le fibre simpatiche efferenti.
Metodi per determinare lo stato della via efferente parasimpatica
- Variazioni della frequenza cardiaca in posizione eretta. Nelle persone sane, la frequenza cardiaca aumenta rapidamente in posizione eretta (il valore massimo si osserva dopo il 15° battito cardiaco) e poi diminuisce dopo il 30° battito. Il rapporto tra l'intervallo RR al 15° battito e l'intervallo RR al 30° battito è definito "rapporto 30:15" o coefficiente "30:15". Normalmente, è pari o superiore a 1,04; 1,01-1,03 è un valore limite; 1,00 indica un'insufficiente influenza vagale sul cuore.
- Variazione della frequenza cardiaca durante la respirazione profonda e lenta - 6 volte al minuto. Determinazione del rapporto tra l'intervallo RR massimamente esteso durante l'espirazione e l'intervallo RR massimamente ridotto durante l'inspirazione. Nelle persone sane, a causa dell'aritmia sinusale causata dall'influenza del nervo vago, questo rapporto è sempre superiore a 1,21. Indicatori compresi tra 1,11 e 1,20 sono borderline. In caso di riduzione dell'aritmia sinusale, ovvero in caso di insufficienza del nervo vago, questo indicatore non sarà superiore a 1,10.
- Variazione della frequenza cardiaca durante la manovra di Valsalva. Viene calcolato il coefficiente di Valsalva. Si respira in un boccaglio collegato a un manometro; la pressione viene mantenuta a 40 mmHg per 15 secondi. Contemporaneamente, si registra la frequenza cardiaca tramite ECG. Calcolo del coefficiente di Valsalva: rapporto tra l'intervallo RR prolungato nei primi 20 secondi dopo il test e l'intervallo RR accorciato durante il test. Normalmente, è pari o superiore a 1,21; i risultati borderline sono compresi tra 1,11 e 1,20; un coefficiente pari o inferiore a 1,10 indica una violazione della regolazione parasimpatica del ritmo cardiaco. Fisiologicamente, durante il test, al momento della tensione, compaiono tachicardia e vasocostrizione, dopodiché si verifica un salto pressorio e successivamente bradicardia.
- Test farmacologici:
- Test dell'atropina. Il blocco parasimpatico cardiaco completo si verifica con l'introduzione di atropina a una dose di 0,025-0,04 mg/kg, rispettivamente da 1,8 a 3 mg di solfato di atropina. L'effetto si ottiene entro 5 minuti e dura 30 minuti. Si osserva una marcata tachicardia. Nei pazienti con danno ai rami cardiaci del vago, non si verifica alcun aumento della frequenza cardiaca.
Metodi per determinare lo stato della via simpatica afferente
Manovra di Valsalva: la respirazione viene eseguita in un boccaglio collegato a un manometro; la pressione nel manometro viene mantenuta a 40 mm Hg per 15 s.
In questo caso, si verifica un aumento della pressione intratoracica, della pressione arteriosa e una variazione della frequenza cardiaca. Tutte le variazioni durano normalmente 1,5-2 minuti e presentano quattro fasi: Fase 1: aumento della pressione arteriosa dovuto all'aumento della pressione intratoracica; Fase 2: calo della pressione sistolica e diastolica dovuto a una variazione dell'afflusso venoso; dopo 5 secondi, il livello di pressione arteriosa viene ripristinato, associato a vasocostrizione riflessa; la frequenza cardiaca aumenta nei primi 10 secondi; Fase 3: brusco calo della pressione arteriosa fino al livello della fine della seconda fase, associato al rilascio dell'aorta; questa condizione dura 1-2 secondi dopo la scomparsa della pressione intratoracica; Fase 4: aumento della pressione sistolica al di sopra del livello di riposo per 10 secondi, aumento della pressione differenziale, aumento della pressione diastolica o invariata. La fase 4 termina quando la pressione arteriosa torna al suo livello originale.
Quando la via afferente simpatica viene danneggiata, si verifica un blocco della risposta nella seconda fase, che si esprime con un calo della pressione sistolica e diastolica e un aumento della frequenza cardiaca.
Se è noto che il nervo vago funziona normalmente (secondo i dati clinici e i risultati dei test) e allo stesso tempo non si verifica alcuna variazione della frequenza cardiaca durante l'ipotensione e l'ipertensione arteriosa, allora si può supporre che sia stata danneggiata la parte afferente dell'arco simpatico, cioè il percorso che conduce al seno carotideo come parte del IX paio di nervi cranici.
I metodi moderni per lo studio dell'apparato vegetativo nel sistema cardiovascolare includono il monitoraggio non invasivo della pressione arteriosa e l'analisi della variabilità della frequenza cardiaca (analisi spettrale delle PC). Questi metodi consentono una valutazione quantitativa integrata della funzione vegetativa in diversi stati funzionali e di chiarire l'influenza e il ruolo dei collegamenti simpatico e parasimpatico nella regolazione vegetativa del sistema cardiovascolare.
Sistema gastrointestinale
I metodi utilizzati per studiare le funzioni vegetative di questo sistema si basano sullo studio della motilità dell'intero tratto gastrointestinale, che è sotto il controllo delle divisioni parasimpatiche e simpatiche del sistema nervoso autonomo.
Prima di passare alla descrizione dei metodi, è necessario avvertire che i risultati positivi possono essere interpretati come patologia vegetativa in caso di esclusione di tutte le cause evidenti di disturbi gastrointestinali (infezione, infiammazione, trauma, tumore, aderenze, patologia del fegato e della cistifellea, ecc.).
Studio della funzione escretoria. Metodi per determinare lo stato della via efferente parasimpatica
- Acidità gastrica. L'insulina viene somministrata a 0,01 U/kg, seguita dalla determinazione dell'acidità gastrica. In una persona sana, l'acidità aumenta in risposta all'ipoglicemia a causa dell'attività del nervo vago. L'assenza di un aumento dell'acidità indica un danno ai rami del vago che si dirigono alle cellule parietali dello stomaco. A proposito, questa è una procedura standard per la valutazione della vagotomia chirurgica. Se le cellule parietali stesse sono danneggiate o assenti, non si verificherà alcun aumento dell'acidità gastrica in risposta alla pentagastrina o all'istamina.
- Gastrocromoscopia. Basata sulla capacità della mucosa gastrica di secernere un colorante - rosso neutro - dopo 12-15 minuti con somministrazione intramuscolare e dopo 5 minuti con somministrazione endovenosa. In caso di insufficienza secretoria, la secrezione del colorante è significativamente ritardata, mentre in caso di achilia non si verifica affatto (predominanza dell'influenza simpatica).
- Risposta dei polipeptidi pancreatici all'ipoglicemia. Il rilascio di polipeptidi pancreatici dal pancreas avviene durante l'ipoglicemia ed è mediato dal nervo vago. Per questo motivo, un aumento insufficiente o assente dei polipeptidi pancreatici in risposta alla somministrazione di insulina è considerato un'insufficienza parasimpatica.
Studio della funzione motoria ed evacuante dello stomaco e dell'intestino
I metodi descritti indicano un danno alle fibre parasimpatiche pregangliari o un'insufficienza simpatica.
Metodi: scintigrafia, radiografia, manometria. È possibile rilevare un rallentamento dei movimenti esofagei, che si verifica in caso di danno alle fibre parasimpatiche pregangliari del nervo vago, e un disturbo del ritmo dei movimenti in caso di degenerazione assonale dei nervi esofagei.
I metodi di contrasto per l'esame dello stomaco e dell'intestino, l'elettrogastrografia e l'ecografia permettono di rilevare disturbi della funzione motoria sotto forma di rallentamento della peristalsi e dell'evacuazione dovuti a danni ai nervi parasimpatici (vago) e aumento della funzione motoria dovuto a insufficienza simpatica.
- Metodo chimografico a palloncino. L'essenza sta nella registrazione della pressione intragastrica, le cui fluttuazioni corrispondono in gran parte alle contrazioni dello stomaco. Il livello di pressione iniziale caratterizza il tono delle pareti dello stomaco. Un palloncino di gomma pieno d'aria è collegato, tramite un sistema di tubi e una capsula di Marey, a un manometro ad acqua. Le fluttuazioni del liquido nel manometro vengono registrate su un chimografo. Analizzando i chimogrammi, vengono valutati il ritmo, la forza delle contrazioni gastriche e la frequenza delle onde peristaltiche per unità di tempo. Le influenze provenienti dai nervi simpatici riducono il ritmo e la forza della contrazione, nonché la velocità di distribuzione dell'onda peristaltica nello stomaco, e inibiscono la motilità. Le influenze parasimpatiche stimolano la motilità.
- Il metodo del catetere aperto è una variante del metodo chimografico a palloncino. In questo caso, la pressione viene percepita dal menisco del liquido.
- L'elettrogastrografia offre i vantaggi di un metodo senza sonda per la valutazione dell'attività motoria dello stomaco. I biopotenziali dello stomaco vengono registrati dalla superficie corporea del paziente utilizzando i dispositivi EGG-3 ed EGG-4. Il sistema di filtri consente l'identificazione dei biopotenziali in un intervallo ristretto che caratterizza l'attività motoria dello stomaco. Nella valutazione dei gastrogrammi, vengono presi in considerazione la frequenza, il ritmo e l'ampiezza per unità di tempo. Il metodo prevede il posizionamento di un elettrodo attivo nella zona di proiezione dello stomaco sulla parete addominale anteriore, cosa non sempre possibile.
- Registrazione dei biopotenziali gastrici da un punto remoto [Rebrov VG, 1975] utilizzando l'apparecchio EGS-4M. L'elettrodo attivo è sul polso destro, quello indifferente è sulla caviglia destra.
- La pashelectrografia è uno studio simultaneo della funzione motoria dello stomaco e dell'intestino. Il metodo si basa sul fatto che la frequenza delle contrazioni muscolari è specifica per le diverse sezioni del tratto digerente e coincide con la frequenza del ritmo elettrico principale [Shede H., Clifton J., 1961; Christensen J., 1971]. Selezionando questa frequenza utilizzando filtri a banda stretta, posizionando gli elettrodi sulla superficie corporea, è possibile tracciare la natura delle variazioni del potenziale totale delle sezioni corrispondenti del tratto gastrointestinale, inclusi l'intestino tenue e crasso.
- Radiotelemetria. La pressione intragastrica viene determinata utilizzando una capsula inserita nello stomaco, che include un sensore di pressione e un trasmettitore radio. I segnali radio vengono ricevuti da un'antenna fissata al corpo del paziente e trasmessi tramite un convertitore a un dispositivo di registrazione. Le curve vengono analizzate con le stesse modalità dell'elettrogastrografia.
Non esistono ancora test semplici, affidabili e informativi per diagnosticare l'insufficienza autonomica del sistema gastrointestinale.
Sistema urogenitale
Anche in questo ambito mancano ancora test semplici e informativi per lo studio dei nervi autonomi; i metodi utilizzati si basano sullo studio delle funzioni degli organi effettori finali.
Metodi per determinare lo stato delle vie efferenti parasimpatiche e simpatiche
- La mittourometria è un metodo quantitativo che, mediante appositi apparecchi - gli uroflussometri - consente di valutare la funzione di evacuazione della vescica, controllata dal sistema nervoso parasimpatico.
- La cistometria è un metodo quantitativo che valuta le funzioni motorie e sensoriali della vescica. In base al rapporto tra pressione intravescicale e volume vescicale, è possibile determinare il livello di danno: a livello dei centri spinali, delle fibre parasimpatiche pregangliari, dei nervi postganglionari.
- La profilometria pressoria uretrale è un metodo per valutare le condizioni dell'uretra utilizzando un grafico costruito, ovvero un profilo pressorio lungo tutta la sua lunghezza durante l'evacuazione dell'urina. Viene utilizzata per escludere patologie delle basse vie urinarie.
- La cistouretrografia è un metodo di contrasto per rilevare la dissinergia degli sfinteri interno ed esterno.
- L'ecografia è un moderno metodo non invasivo per esaminare le funzioni della vescica, consentendo di valutare tutte le fasi della minzione e del riempimento.
- L'elettromiografia dello sfintere anale esterno è un metodo utilizzato per diagnosticare la dissinergia dello sfintere anale esterno della vescica, che funziona in modo simile allo sfintere anale esterno.
- Monitoraggio delle erezioni durante il sonno notturno - utilizzato per la diagnosi differenziale tra impotenza organica e psicogena. In caso di danno organico alle fibre parasimpatiche, le erezioni sono assenti al mattino e durante il sonno notturno, mentre nelle persone sane e in caso di impotenza psicogena le erezioni sono conservate.
- Lo studio dei potenziali simpatici cutanei evocati dalla superficie dei genitali viene effettuato per valutare la funzione dei nervi efferenti simpatici. Quando questi sono danneggiati, i periodi di latenza delle risposte si allungano e le loro ampiezze si riducono.
Pelle (sudorazione, termoregolazione)
Metodi per determinare lo stato della via simpatica efferente
- Studio dei potenziali simpatici evocati cutanei. Il metodo si basa sul fenomeno GSR e consiste nella registrazione dei biopotenziali cutanei in risposta alla stimolazione elettrica del nervo mediano. Poiché il collegamento efferente del GSR è il sistema nervoso simpatico, le caratteristiche della risposta risultante hanno iniziato a essere utilizzate per analizzare questa parte del sistema nervoso autonomo. Quattro coppie di elettrodi di superficie (20x20x1,5 mm) vengono posizionate sui palmi delle mani e sui piedi. La registrazione viene eseguita utilizzando un elettroneuromiografo con una sensibilità dell'amplificatore di 100 μV, nell'intervallo di frequenza 1,0-20,0 Hz con un'epoca di analisi di 5 s. Singoli impulsi rettangolari irregolari della durata di 0,1 s vengono utilizzati come stimolo elettrico. L'intensità di corrente viene selezionata come standard in base alla comparsa di una risposta motoria del pollice durante la stimolazione nell'area di proiezione del nervo mediano a livello del polso. Gli stimoli vengono somministrati in modo casuale con un intervallo di almeno 20 secondi dopo l'estinzione della GSR spontanea. In risposta allo stimolo, viene calcolata la media di 4-6 risposte galvaniche cutanee, denominate potenziali simpatici cutanei evocati (ESP). Vengono determinati i periodi di latenza e le ampiezze I degli ESP. L'informatività di questo metodo è stata dimostrata da una serie di studi su pazienti con varie forme di polineuropatie in patologie sistemiche, endocrine e autoimmuni. In questo caso, un aumento dell'LA e una diminuzione dell'AMP degli ESP sono stati valutati come una violazione della conduzione dell'eccitazione lungo le fibre sudomotorie autonome, mentre l'assenza di risposte è stata attribuita a una grave violazione della funzionalità delle fibre sudoripare. Tuttavia, quando si analizza l'ESP, è necessario tenere sempre presente che i parametri di latenza e ampiezza possono variare non solo in presenza di patologie del sistema nervoso periferico, ma anche di quello centrale. Nell'interpretazione dei dati VKSP dal punto di vista del livello di danno al sistema nervoso centrale (VNS), è necessario tenere conto dei risultati di metodi di ricerca clinici e paraclinici (ENMG, EP, EEG, RM, ecc.). I vantaggi del metodo sono la non invasività, la completa sicurezza e la valutazione quantitativa dei risultati.
Un altro metodo informativo è il test quantitativo del riflesso assonale sudomotorio (QSART), in cui la sudorazione locale viene stimolata mediante ionoforesi con acetilcolina. L'intensità della sudorazione viene registrata da uno speciale suscettometro, che trasmette le informazioni in forma analogica a un computer. Lo studio viene condotto in una stanza speciale isolata termicamente, a riposo e sotto carichi termici (tè caldo, ecc.). La necessità di una stanza specifica e di attrezzature tecniche specifiche per la ricerca limita l'ampia applicazione di questo metodo.
Oggigiorno, i test coloranti vengono utilizzati molto meno frequentemente per valutare la funzione della sudorazione. Alcuni di essi sono descritti di seguito. L'insufficienza della parte efferente dell'arco riflesso simpatico è determinata dall'assenza di sudorazione in una determinata area del corpo. La localizzazione viene stabilita osservando la sudorazione con il test dello iodio-amido di Minor o il test del cromo-cobalto di Yuzhelevsky. La sudorazione si ottiene con vari metodi:
-
- Test dell'aspirina: l'assunzione di 1 g di acido acetilsalicilico con un bicchiere di tè caldo provoca una sudorazione diffusa in tutto l'apparato cerebrale; in caso di lesioni corticali si verifica più spesso una sudorazione di tipo monoplegico, ovvero la sua assenza o diminuzione.
- Il riscaldamento del soggetto in una camera ad aria secca, in una camera di riscaldamento o l'immersione di due arti in acqua calda (43 °C) inducono riflessi sudoripari spinali attraverso le cellule delle corna laterali del midollo spinale. In caso di danno a parti segmentali del midollo spinale, le procedure di riscaldamento, così come il test dell'aspirina, rivelano l'assenza o la riduzione della sudorazione nelle aree corrispondenti.
- Test della pilocarpina: l'iniezione sottocutanea di 1 ml di soluzione di pilocarpina all'1%, agendo sulle ghiandole sudoripare terminali, provoca normalmente la secrezione di sudore in una determinata area del corpo. L'assenza o la diminuzione della sudorazione in questo test si osserva in assenza o danno delle ghiandole sudoripare.
- Test del riflesso assonale: la stimolazione con corrente faradica, l'iniezione intradermica di acetilcolina (5-10 mg) o l'elettroforesi dell'acetilcolina causano normalmente piloerezione locale e sudorazione dopo 5 minuti. L'assenza di piloerezione, la riduzione o l'assenza di sudorazione indicano un danno ai gangli simpatici o ai neuroni postganglionari.
- Studio della temperatura cutanea superficiale mediante termovisori: viene registrata l'intensità della radiazione infrarossa, che costituisce l'essenza dei termogrammi ottenuti. Gli effetti isotermici vengono utilizzati per quantificare il valore della radiazione infrarossa. I valori di temperatura sono espressi in gradi. L'interpretazione del termogramma si basa sulla presenza di asimmetria termica e sul valore del gradiente terminale longitudinale, che riflette la differenza di temperatura tra le aree distali e prossimali della pelle. Lo studio dei termogrammi e dell'intensità della temperatura cutanea ha mostrato che la metà superiore del corpo è più calda di quella inferiore, gli arti destro e sinistro sono caratterizzati da un'immagine simmetrica, le parti prossimali degli arti sono più calde di quelle distali e la differenza è insignificante e graduale. Nei pazienti con disturbi autonomici cerebrali, la distribuzione della temperatura cutanea mediante indicatori termografici è rappresentata dalle seguenti tipologie:
- “termoamputazione” bilaterale a livello del terzo inferiore dell’avambraccio con ipotermia delle mani e dei piedi, con brusco calo della temperatura di 2-4 °C;
- ipertermia delle mani e dei piedi, più comune nei pazienti con sindrome ipotalamica;
- diversi tipi di asimmetrie:
- “termoamputazione” unilaterale della mano;
- asimmetria "termoamputazione" delle mani e dei piedi.
Quando vengono colpite parti segmentali del sistema nervoso autonomo, si osservano principalmente vari tipi di asimmetrie.
Pupilla
È noto che il sistema simpatico e parasimpatico innervano i muscoli che dilatano e restringono la pupilla. La ricerca neurofarmacologica permette di differenziare il danno pre- e postganglionare ai nervi autonomi che innervano i muscoli dell'iride. L'analisi permette di differenziare la comparsa di ptosi e miosi dovute a danno alle fibre simpatiche del muscolo che dilata la pupilla dalla sindrome di Horner, che si basa su un danno più prossimale alle vie simpatiche che conducono a questo muscolo, così come dalla sindrome di Adie (dilatazione tonica delle pupille), che è attualmente associata a danno alle fibre parasimpatiche postganglionari che innervano il muscolo che restringe la pupilla, nonché dalla midriasi che si verifica a causa di danno alle fibre preganglionari.
Il metodo neurofarmacologico di analisi si basa sul fenomeno dell'ipersensibilità alla denervazione delle fibre simpatiche e parasimpatiche postganglionari. È stato dimostrato che, in caso di ipersensibilità alla denervazione della pupilla ristretta in caso di miosi o ptosi, la lesione non è localizzata nella fibra simpatica pregangliare, bensì in quella postganglionare alla base del cranio o lungo l'arteria carotide interna. In caso di ipersensibilità alla denervazione della pupilla dilatata in caso di midriasi, è improbabile anche un danno alle fibre pregangliari nel tronco encefalico, nel seno cavernoso o nel midollo spinale cervicale. Questo è tipico del danno alle fibre postganglionari simpatiche nel ganglio ciliare o negli strati esterni dell'occhio.
Esistono diverse regole quando si esaminano gli alunni e si eseguono test neurofarmacologici:
- Si instilla 1 goccia del farmaco in ciascun occhio ad intervalli di 2 minuti;
- poiché il test viene eseguito per rilevare il difetto, potrebbe essere necessario instillare le gocce tre volte a intervalli di 10 minuti, ovvero 6 gocce in ciascun occhio;
- nei pazienti con anomalie monolaterali delle dimensioni della pupilla, devono essere esaminate entrambe le pupille;
- L'ipersensibilità da denervazione si considera rilevata se la pupilla dilatata si contrae e l'altra non risponde. In assenza di risposta, la concentrazione del farmaco può essere aumentata, a condizione che vengano esaminati entrambi gli occhi. L'ipersensibilità da denervazione della pupilla dilatata può essere esclusa solo se la pupilla normale inizia a contrarsi in assenza di una contrazione più intensa della pupilla dilatata.
In caso di patologia pupillare bilaterale, il confronto è impossibile: si deve esaminare solo un occhio e l'altro servirà da controllo.
Test di ipersensibilità alla denervazione simpatica nella miosi
- Somministrazione di adrenalina allo 0,1%: la pupilla normale non si dilata in risposta all'instillazione di adrenalina. Nell'ipersensibilità da denervazione, l'adrenalina causa midriasi. L'ipersensibilità massima si verifica in caso di danno alla via simpatica postganglionare. La pupilla si dilata di oltre 2 mm. L'adrenalina non causa una variazione significativa delle dimensioni della pupilla in caso di danno alle fibre simpatiche preganglionari (in particolare il "primo neurone"), ovvero, nella sindrome di Horner completa, questo test è negativo.
- Test con soluzione di cocaina al 4%: la cocaina è raramente utilizzata da sola, poiché non consente di individuare la sede del danno al nervo simpatico; più spesso viene utilizzata in combinazione con il test dell'adrenalina. Metodologia del test combinato: vengono somministrate 2 gocce di soluzione di cocaina al 4%, ripetendo l'operazione tre volte se necessario. Una midriasi con miosi distinta indica un danno alla fibra simpatica pregangliare. In assenza di reazione, dopo 30 minuti viene instillata una soluzione di adrenalina allo 0,1%: una lieve dilatazione della pupilla può indicare un possibile danno alla fibra pregangliare, il suo "secondo neurone"; una dilatazione distinta della pupilla è un segno diagnostico di danno alla fibra simpatica postganglionare.
Test di ipersensibilità alla denervazione parasimpatica nella midriasi
Si utilizzano gocce di mecolile al 2,5%. Si somministra 1 goccia di soluzione in ciascun occhio, ripetendo l'instillazione dopo 5 minuti. La pupilla tonicamente dilatata reagisce al mecolile con miosi pronunciata. Non si osserva alcuna reazione nella pupilla integra. Questo test è informativo nella sindrome di Adie.
Oftalmoplegia interna: l'identificazione delle cause non richiede test farmacologici, ma è necessaria un'analisi neurologica topica.
Oltre ai test farmacologici, ce ne sono altri.
- Tempo di ciclo pupillare. Utilizzando una lampada a fessura, una sottile striscia di luce viene fatta passare attraverso il bordo della pupilla. In risposta, si osservano contrazioni ritmiche e costrizione della pupilla. La durata di un tale ciclo (costrizione - espansione) nelle persone sane è di 946 ± 120 ms. Un aumento del tempo di ciclo pupillare indica un'insufficienza parasimpatica.
- La fotografia Polaroid della pupilla con un flash elettronico è un metodo per determinare le dimensioni della pupilla al buio. Determinare le dimensioni della pupilla adattata al buio rispetto al diametro esterno dell'iride consente di valutare lo stato dell'innervazione simpatica. Una dilatazione pupillare insufficiente indica un'insufficienza simpatica. Il metodo è sensibile a minime alterazioni della funzione simpatica.
- La pupillometria televisiva a infrarossi è un metodo quantitativo che consente di determinare le dimensioni esatte della pupilla a riposo, in risposta alla luce e al buio, il che fornisce informazioni dettagliate per la valutazione dell'innervazione autonoma della pupilla.
- Eterocromia dell'iride: il sistema nervoso simpatico influenza la formazione di melanina e determina il colore dell'iride. L'alterazione della pigmentazione di un'iride indica un danno alle fibre simpatiche nella prima infanzia. La depigmentazione negli adulti è estremamente rara. La causa dell'eterocromia negli adulti può essere una malattia locale o il risultato di un'anomalia congenita isolata. La depigmentazione può essere osservata insieme ad altri sintomi di danno all'innervazione simpatica nella sindrome di Horner (solitamente congenita).
Cosa c'è da esaminare?

