Esperto medico dell'articolo
Nuove pubblicazioni
Emorragia: sintomi, arresto dell'emorragia
Ultima recensione: 07.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.
Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.
Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.
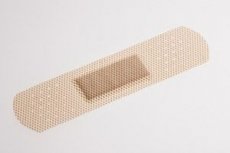
L'emorragia è la fuoriuscita di sangue da un vaso nell'ambiente esterno, nei tessuti o in qualsiasi cavità corporea. La presenza di sangue in una determinata cavità ha un suo nome. Pertanto, l'accumulo di sangue nella cavità toracica è chiamato emotorace, nella cavità addominale - emoperitoneo, nel pericardio - emopericardio, in un'articolazione - emartro, ecc. La causa più comune di emorragia è il trauma.
L'emorragia è una saturazione diffusa di sangue di qualsiasi tessuto (ad esempio, tessuto sottocutaneo, tessuto cerebrale).
Un ematoma è una raccolta di sangue confinata nei tessuti.
Sintomi emorragie
I sintomi dell'emorragia dipendono dall'organo danneggiato, dal calibro del vaso lesionato e dal punto in cui scorre il sangue. Tutti i segni di emorragia si dividono in sintomi generali e sintomi locali.
I sintomi generali delle emorragie esterne ed interne sono gli stessi. Sono debolezza, vertigini con frequenti svenimenti, sete, pallore della pelle e (soprattutto) delle mucose (labbra bianche), polso spesso piccolo, pressione sanguigna progressivamente calante e instabile, forte calo del numero di globuli rossi e del contenuto di emoglobina.
I sintomi locali di emorragia esterna sono già stati elencati; il principale è il sanguinamento da una ferita. I sintomi locali di emorragia interna sono estremamente vari e la loro comparsa dipende dalla cavità in cui scorre il sangue.
- Pertanto, in caso di emorragia nella cavità cranica, il quadro clinico principale è costituito da sintomi di compressione del cervello.
- Quando si verifica un sanguinamento nella cavità pleurica, si manifestano segni di emotorace con un'ampia gamma di segni fisici (dispnea, accorciamento del suono della percussione, indebolimento del respiro e del fremito vocale, limitazione delle escursioni respiratorie) e dati derivanti da metodi di ricerca ausiliari (radiografia del torace, puntura della cavità pleurica).
- Quando il sangue si accumula nella cavità addominale, si manifestano sintomi di peritonite (dolore, nausea, vomito, tensione dei muscoli della parete addominale anteriore, sintomi di irritazione peritoneale) e ottusità delle parti inclinate dell'addome. La presenza di liquido libero nella cavità addominale viene confermata mediante ecografia, puntura o laparocentesi.
- Grazie al piccolo volume della cavità, l'emorragia nell'articolazione non è massiva, quindi non si verifica mai un'anemia acuta che mette a repentaglio la vita del paziente, come accade con altre emorragie intracavitarie.
- Il quadro clinico di un ematoma intratissutale dipende dalle sue dimensioni, dalla posizione, dal calibro del vaso danneggiato e dalla presenza di comunicazione tra quest'ultimo e l'ematoma. Le manifestazioni locali includono gonfiore significativo, aumento del volume dell'arto, compattazione tissutale da rottura e sindrome dolorosa.
Un ematoma in progressiva crescita può portare alla cancrena dell'arto. In caso contrario, l'arto risulta leggermente ridotto di volume, ma si osserva chiaramente un deterioramento del trofismo della parte distale. Durante l'esame, si riscontra una pulsazione al di sopra dell'ematoma e si ode anche un soffio sistolico, che indica la formazione di un falso aneurisma.
Cosa ti infastidisce?
Forme
Non esiste una classificazione internazionale univoca delle emorragie. È stata adottata una classificazione "operativa" che riflette gli aspetti più importanti di questo complesso problema, necessari per le attività pratiche. La classificazione è stata proposta per la pratica clinica dall'accademico B.V. Petrovsky. Include diverse posizioni principali.
- Secondo il principio anatomico e fisiologico, le emorragie si dividono in arteriose, venose, capillari e parenchimatose; esse presentano caratteristiche nel quadro clinico e nei metodi di arresto.
- In caso di emorragia arteriosa, il sangue è di colore scarlatto, scorre a flusso pulsante, non si ferma da solo, il che porta rapidamente a una grave anemia acuta.
- Nelle emorragie venose il sangue è di colore scuro e scorre più lentamente quanto più piccolo è il calibro del vaso.
- Le emorragie parenchimatose e capillari sono esteriormente identiche, la loro differenza rispetto alle precedenti è l'assenza di una fonte visibile di sanguinamento, la durata e la complessità dell'emostasi.
- In base alle manifestazioni cliniche, le emorragie si dividono in esterne e interne (cavitarie, nascoste).
- In caso di emorragia esterna, il sangue fuoriesce nell'ambiente esterno.
- Con un'emorragia interna, il sangue penetra in una cavità corporea o in un organo cavo. Il sanguinamento occulto dovuto a ferite è quasi mai il caso. È spesso causato da ulcere gastriche e intestinali.
- A seconda del momento in cui si verifica l'emorragia si distingue tra emorragia primaria, secondaria precoce e secondaria tardiva.
- Quelle primarie iniziano subito dopo l'infortunio.
- Le emorragie secondarie precoci si verificano nelle prime ore e nei primi giorni successivi alla lesione, a causa della fuoriuscita del trombo dal vaso lesionato. Le cause di queste emorragie sono la violazione dei principi di immobilizzazione, l'attivazione precoce del paziente e l'aumento della pressione sanguigna.
- Un'emorragia tardiva secondaria può svilupparsi in qualsiasi momento dopo che la ferita è diventata suppurata. La causa del loro sviluppo è la fusione purulenta di un trombo o di una parete vasale a causa di un processo infiammatorio.
Sanguinamento arterioso
Si verifica quando un'arteria viene lesionata: sangue rosso scarlatto che fuoriesce dalla ferita a fiotti, come una fontana. L'intensità della perdita di sangue dipende dalle dimensioni del vaso danneggiato e dalla natura della lesione. Un'emorragia grave si verifica in caso di ferite laterali e penetranti dei vasi arteriosi. In caso di rottura trasversale dei vasi, si osserva spesso un arresto spontaneo dell'emorragia dovuto alla contrazione delle pareti vasali, all'inversione dell'intima lacerata nel suo lume, seguita dalla formazione di un trombo. L'emorragia arteriosa è pericolosa per la vita, poiché si perde una grande quantità di sangue in un breve periodo di tempo.
 [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ]
[ 13 ], [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ]
Sanguinamento venoso
Nelle emorragie venose, il sangue non ossigenato che fuoriesce è di colore scuro, non pulsa, scorre lentamente nella ferita e l'estremità periferica del vaso sanguina di più. Le lesioni alle grandi vene situate vicino al cuore sono pericolose non solo a causa dell'emorragia profusa, ma anche a causa dell'embolia gassosa: l'aria entra nel lume di un vaso sanguigno durante la respirazione con conseguente compromissione della circolazione polmonare, spesso portando alla morte del paziente. Le emorragie venose da vasi di medie e piccole dimensioni sono meno pericolose per la vita rispetto alle emorragie arteriose. Il flusso sanguigno lento dai vasi venosi e le pareti vascolari che collassano facilmente se compresse contribuiscono alla formazione di un trombo.
A causa delle peculiarità del sistema vascolare (le arterie e le vene omonime sono situate adiacenti), i danni isolati ad arterie e vene sono rari, quindi la maggior parte delle emorragie è di tipo misto (arterioso-venoso). Tale emorragia si verifica quando un'arteria e una vena vengono lese contemporaneamente ed è caratterizzata da una combinazione dei segni sopra descritti.
Sanguinamento capillare
Si verifica quando le mucose e i muscoli sono danneggiati. In caso di emorragia capillare, l'intera superficie della ferita sanguina, il sangue "cola" dai capillari danneggiati e l'emorragia si arresta applicando una benda semplice o leggermente compressiva.
Le lesioni a fegato, reni e milza sono accompagnate da emorragia parenchimatosa. I vasi degli organi parenchimatosi sono strettamente fusi con lo stroma connettivo dell'organo, il che ne impedisce lo spasmo; l'arresto spontaneo dell'emorragia è difficile.
 [ 19 ]
[ 19 ]
Emorragia esterna
Si tratta della fuoriuscita di sangue sulla superficie del corpo da ferite, ulcere (solitamente vene varicose) e, raramente, da tumori della pelle.
In base al tipo di vaso sanguinante, si distinguono in: arteriose (il sangue è scarlatto, zampilla e, se un grosso vaso è leso, pulsa); venose (il sangue è scuro, scorre con un flusso lento, ma può essere intenso se le vene grandi sono lese); capillari (sudorazione sotto forma di singole gocce che si fondono tra loro; in caso di lesioni estese alla pelle, possono causare una massiccia perdita di sangue). In termini di tempo, la maggior parte delle emorragie è primaria. Le emorragie secondarie si sviluppano raramente, principalmente erosive da ulcere.
La diagnosi di emorragia esterna non presenta difficoltà. Tattiche: sulla scena dell'incidente, conciliazione dei metodi per l'arresto temporaneo dell'emorragia, trasporto in un ospedale chirurgico per l'arresto definitivo dell'emorragia e la correzione della perdita di sangue.
 [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ]
[ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ]
Sanguinamento intratissutale
Si sviluppano a causa di traumi (contusioni, fratture), malattie accompagnate da aumento della permeabilità vascolare o disturbi della coagulazione del sangue (emofilia, sindrome di Aureka nell'insufficienza epatica e ipovitaminosi K); rotture vascolari e dissezioni aneurismiche. Possono formarsi superficialmente con localizzazione nella cute, nel tessuto sottocutaneo e negli spazi intermuscolari; e intraorgano (principalmente negli organi parenchimatosi) a causa di traumi (contusioni) e rotture aneurismiche. Si dividono in 2 tipi.
- In caso di saturazione uniforme dei tessuti con eritrociti (imbibizione), il processo è chiamato emorragia. Le emorragie superficiali non causano difficoltà diagnostiche, poiché sono visibili a occhio nudo come un livido, che si risolve spontaneamente con un graduale scolorimento: i primi 2 giorni ha una tonalità viola-viola; fino al 5°-6° giorno - blu; fino al 9°-10° giorno - verde; fino al 14° giorno - giallo.
- Un accumulo libero di sangue liquido, nel tessuto sottocutaneo, negli spazi intermuscolari, nei tessuti lassi, ad esempio nello spazio retroperitoneale; nei tessuti degli organi parenchimatosi, è chiamato ematoma.
Gli ematomi superficiali con accumulo di sangue nel tessuto sottocutaneo e negli spazi intermuscolari si formano a seguito di traumi (contusioni, fratture, ecc.) o, raramente, di rotture di aneurismi vascolari. Clinicamente, sono accompagnati da un aumento di volume del segmento, spesso sporgente al di sopra della contusione. La palpazione rivela una formazione elastica, morbida, moderatamente dolente, il più delle volte associata a un sintomo di fluttuazione (sensazione di liquido che scorre sotto la mano). In caso di rottura dell'aneurisma, si rileva inoltre la pulsazione dell'ematoma, a volte visibile a occhio nudo, e si udisce un soffio sistolico all'auscultazione. La diagnosi, di norma, non presenta difficoltà, ma in caso di dubbio, può essere confermata dall'angiografia.
Gli ematomi possono diventare purulenti, dando il quadro tipico di un ascesso.
Tattica: contusioni; trattamento ambulatoriale da parte di chirurghi o traumatologi; in caso di ematomi è consigliabile il ricovero ospedaliero.
Emorragia intracavitaria
Per emorragia intracavitaria si intende il sanguinamento nelle cavità sierose. L'emorragia nella cavità cranica è definita come ematoma intracranico; nella cavità pleurica - emotorace; nella cavità pericardica - emopericardio; nella cavità peritoneale - emoperitoneo; nella cavità articolare - emartro. L'emorragia in cavità non è solo una sindrome che complica il decorso del processo patologico sottostante, più spesso un trauma, ma anche la principale manifestazione evidente di lesione o rottura dell'organo parenchimatoso.
Gli ematomi intracranici si formano principalmente in seguito a traumi craniocerebrali, meno frequentemente a rottura di aneurismi vascolari (più frequentemente nei ragazzi di 12-14 anni durante lo sforzo fisico). Sono accompagnati da un quadro clinico piuttosto pronunciato, ma richiedono una diagnosi differenziale con gravi contusioni cerebrali ed ematomi intracerebrali, sebbene siano spesso associati a meningite.
L'emotorace può svilupparsi in caso di lesione toracica chiusa con danno al polmone o all'arteria intercostale, ferite toraciche penetranti e lesioni toraco-addominali, rotture di bolle polmonari vascolarizzate nell'enfisema bolloso. In questi casi, l'emotorace è anche una manifestazione di danno. Nella sua forma pura (solo accumulo di sangue), l'emotorace si verifica solo con danno isolato ai vasi intercostali. In tutti i casi di danno polmonare, un segno di una violazione della sua tenuta è la formazione di emopneumotorace, quando, insieme all'accumulo di sangue, il polmone collassa e l'aria si accumula nella cavità pleurica. Clinicamente, è accompagnato da un quadro di sindromi anemiche, ipossiche, ipovolemiche e pleuriche. Per confermare la diagnosi, è necessario eseguire una radiografia polmonare, una puntura della cavità pleurica e, se indicato e possibile, una toracoscopia. La diagnosi differenziale viene effettuata con pleurite, chilotorace ed emopleurite, basandosi principalmente sui dati della puntura e sull'esame di laboratorio della puntura.
L'emopericardio si sviluppa in caso di lesioni toraciche chiuse e penetranti, quando l'effetto dell'agente trasmissivo colpisce le sezioni anteriori del torace. Il pericardio contiene solo 700 ml di sangue; la perdita di sangue non causa lo sviluppo di una sindrome da anemia acuta, ma l'emopericardio è pericoloso a causa del tamponamento cardiaco.
Il quadro clinico è caratteristico ed è accompagnato da un rapido sviluppo di insufficienza cardiaca: depressione dello stato di coscienza; progressiva (letteralmente di minuto in minuto) diminuzione della pressione sanguigna; aumento della tachicardia con marcata diminuzione del riempimento, successivamente con passaggio a un'aritmia filiforme, fino alla completa scomparsa. Contemporaneamente, cianosi generalizzata, acrocianosi, cianosi delle labbra e della lingua aumentano rapidamente. In termini di diagnosi differenziale, è necessario ricordare che tale sviluppo progressivo di insufficienza cardiovascolare non si verifica in nessuna patologia cardiaca, nemmeno in caso di infarto del miocardio: o l'arresto cardiaco si verifica immediatamente, oppure si verifica una lenta progressione. La percussione, difficile da eseguire in situazioni estreme, rivela un'espansione dei margini del cuore e del fascio cardiovascolare. Auscultazione: sullo sfondo di toni cardiaci nettamente indeboliti nei primi minuti, si può udire un rumore di spruzzo; successivamente, si notano toni estremamente ovattati e, più spesso, il sintomo di "flutter". È necessario differenziare dalla pericardite. In tutti i casi, il complesso deve iniziare con una puntura pericardica, un ECG e, dopo aver scaricato il pericardio, eseguire una radiografia e altri studi;
L'emoperitoneo si sviluppa in caso di trauma addominale chiuso e penetrante, perforazione di organi cavi, apoplessia ovarica e gravidanza ectopica con rottura delle tube di Falloppio. Considerando che la cavità peritoneale contiene fino a 10 litri di liquido, l'emoperitoneo è accompagnato dallo sviluppo di una sindrome da anemia acuta.
In caso di danni a stomaco, fegato e intestino, il cui contenuto sia un potente irritante per il peritoneo, si sviluppa immediatamente il quadro clinico della peritonite. In caso di emoperitoneo "puro", il quadro è attenuato, poiché il sangue non causa una forte irritazione del peritoneo. Il paziente lamenta un dolore addominale moderato, che si attenua in posizione seduta (sintomo del "lancio del bicchiere"), poiché il sangue fluisce dal plesso solare alla piccola pelvi e l'irritazione scompare; debolezza e vertigini - dovute a; perdita di sangue; gonfiore - dovuto alla mancanza di peristalsi. All'esame obiettivo: il paziente è pallido, spesso con una colorazione cinerea della pelle del viso; letargico e indifferente - a causa dello sviluppo di shock emorragico; alla palpazione - l'addome è molle, moderatamente dolente, non sono evidenti sintomi di irritazione peritoneale; percussione, solo con grandi volumi di emoperitoneo - ottusità nei fianchi, in altri casi - timpanite, dovuta a distensione intestinale.
L'emartrosi è un sanguinamento nella cavità articolare, che si sviluppa principalmente in seguito a traumi. Le articolazioni del ginocchio, che sopportano il massimo carico fisico e presentano una maggiore vascolarizzazione, sono le più colpite. Altre articolazioni raramente causano emartro e non presentano un quadro clinico così evidente.
Le emorragie intraorgano sono versamenti di sangue nelle cavità degli organi cavi. Sono seconde per frequenza dopo le emorragie esterne. Sono tutte pericolose non solo per la quantità di sangue perso, ma anche per la disfunzione degli organi interni. Sono difficili da diagnosticare, da prestare il primo soccorso e da scegliere un metodo per trattare la patologia sottostante che ha causato l'emorragia.
Emorragia polmonare
Le cause dell'emorragia polmonare sono molteplici: bronchite atrofica, tubercolosi, ascessi e cancrena polmonare, polipi bronchiali, malformazioni, tumori polmonari, polmonite infartuale, ecc. Questo tipo di emorragia è considerato il più pericoloso, non per la perdita di sangue, ma perché provoca lo sviluppo di un'insufficienza respiratoria acuta, poiché provoca o emoaspirazione (inalazione di sangue negli alveoli con il loro blocco) o atelettasia del polmone, quando è completamente pieno di sangue.
Quando si tossisce, il sangue viene espulso: schiumoso, di colore scarlatto (in caso di tumori alveolari e polmonite infartuale, rosa).
Il paziente può ingerire questo sangue, sviluppando un vomito riflesso simile a "fondi di caffè". L'espettorato deve essere raccolto in contenitori graduati. La quantità viene utilizzata per valutare l'intensità del sanguinamento e l'espettorato viene anche inviato per le analisi di laboratorio. Quando vengono rilasciati fino a 200 ml di sangue al giorno, il processo è chiamato emottisi; quando vengono rilasciati fino a 500 ml di sangue al giorno, si parla di sanguinamento intenso; in caso di quantità maggiori, di sanguinamento profuso.
La diagnosi è confermata non solo dal quadro clinico: emottisi, sindrome da insufficienza respiratoria acuta, cacofonia all'auscultazione polmonare. Anche radiologicamente, l'emoaspirazione si manifesta con molteplici piccoli oscuramenti polmonari a forma di "tempesta di denaro", atelettasia - oscuramento omogeneo del polmone - a livello di tutto il lobo o dei lobi inferiori, con spostamento del mediastino: verso il lato dell'oscuramento (in caso di oscuramenti dovuti a versamento nella cavità pleurica, il mediastino si sposta sul lato opposto); in caso di polmonite infartuale - oscuramento triangolare del polmone con l'apice rivolto verso la radice. La broncoscopia con endoscopio tubolare è assolutamente indicata.
Un paziente del genere deve essere ricoverato: se c'è un'indicazione di un processo tubercolare - nel reparto chirurgico del dispensario antitubercolare; in assenza di tubercolosi - nel reparto di chirurgia toracica; in caso di tumori ai polmoni e ai bronchi - nei dispensari oncologici o nel reparto toracico.
Sanguinamento gastrointestinale
Si manifestano con ulcere allo stomaco e al duodeno, colite, tumori, fissurazioni della mucosa (sindrome di Mallory-Weiss), gastrite atrofica ed erosiva (soprattutto dopo l'assunzione di bevande surrogati).
Per la diagnosi e la determinazione dell'intensità di questo tipo di sanguinamento, sono importanti 2 sintomi principali: vomito e alterazioni delle feci. In caso di sanguinamento debole: vomito a "fondi di caffè", feci formate, nere; colore. In caso di sanguinamento grave: vomito a coaguli di sangue; feci liquide, nere (melena). In caso di sanguinamento profuso: vomito di sangue non coagulato; feci o assenza di feci, o rilascio di muco a "gelatina di lampone". Anche in caso di sospetto, è indicata una FGDS d'urgenza. La radiografia dello stomaco non viene eseguita nella fase acuta.
Il sanguinamento esofageo si verifica a causa delle vene varicose dell'esofago in caso di ipertensione portale causata da insufficienza epatica in cirrosi, epatite e tumori epatici. Il quadro clinico dell'emorragia in sé assomiglia a quello di un sanguinamento gastrointestinale. Tuttavia, l'aspetto del paziente è tipico dell'insufficienza epatica: la pelle è giallastra, spesso itterica, il viso è gonfio, è presente una rete capillare sugli zigomi, il naso è bluastro, sono visibili vene dilatate e tortuose su torace e tronco; l'addome può essere aumentato di volume a causa dell'ascite; il fegato è spesso notevolmente ingrossato, denso, dolente alla palpazione, ma può anche essere atrofico. In tutti i casi, questi pazienti presentano insufficienza ventricolare destra con ipertensione del circolo polmonare: dispnea, instabilità pressoria, aritmie, fino allo sviluppo di edema polmonare. La FGDS d'urgenza è indicata per la diagnosi e la diagnosi differenziale.
Sanguinamento intestinale - dal retto e dal colon può essere causato più spesso da emorroidi e ragadi anali; meno frequentemente da polipi e tumori del retto e del colon; ancora meno frequentemente da colite ulcerosa aspecifica (NUC). Il sanguinamento dal colon superiore è accompagnato da feci liquide e sanguinolente sotto forma di coaguli di sangue o melena. Il sanguinamento dal retto è associato a feci dure, mentre il sanguinamento da tumori o polipi inizia prima delle feci, mentre il sanguinamento da emorroidi e ragadi anali si verifica dopo le feci. Sono venosi, non abbondanti e si arrestano facilmente da soli.
Per la diagnosi differenziale, vengono eseguiti l'esame esterno dell'anello anale, l'esame digitale del retto, l'esame del retto con specchietto rettale, la rettoscopia e la colonscopia. L'uso integrato di questi metodi di ricerca consente una diagnosi topica accurata. Metodi radiologici. L'esame U (irrigoscopia) viene utilizzato solo in caso di sospetto cancro. In caso di sanguinamento del colon e del sigma, la colonscopia ha il massimo effetto diagnostico, poiché è possibile non solo esaminare attentamente la mucosa, ma anche coagulare il vaso sanguinante, per eseguire l'elettroresezione del polipo sanguinante.
Sanguinamento postoperatorio
Di norma, sono secondarie in fase precoce. Il sanguinamento dalle ferite postoperatorie si verifica quando un trombo viene espulso dai vasi della ferita. Le misure iniziano con l'applicazione di un impacco di ghiaccio sulla ferita. Se il sanguinamento persiste, si divaricano i margini della ferita e si procede all'emostasi: legando il vaso, suturandolo con tessuti, o tramite diatermocoagulazione.
Per controllare la possibilità di emorragia intra-addominale, dopo l'intervento chirurgico vengono inseriti drenaggi tubulari nelle cavità addominale e pleurica, collegati ad aspiratori a vuoto di vario tipo: direttamente collegati ai drenaggi ("pere") o tramite vasi di Bobrov. Normalmente, nei primi 2 giorni vengono rilasciati fino a 100 ml di sangue attraverso i drenaggi. In caso di emorragia, si verifica un abbondante flusso di sangue attraverso i drenaggi. Ciò può essere dovuto a due motivi.
Sanguinamento afibrinogenico
Si sviluppano con un elevato consumo di fibrinogeno ematico, che si verifica durante interventi chirurgici lunghi, superiori alle due ore, sugli organi addominali e toracici, con conseguente massiccia perdita di sangue e sviluppo della sindrome da coagulazione intravascolare disseminata (CID). Una caratteristica distintiva di queste emorragie è: insorgenza precoce dopo l'intervento chirurgico (quasi immediatamente, sebbene il chirurgo sia sicuro dell'emostasi); è lenta e non risponde alla terapia emostatica. La conferma si ottiene testando il contenuto di fibrinogeno ematico. Il fibrinogeno ematico può essere ripristinato e, di conseguenza, l'emorragia può essere arrestata mediante trasfusione di fibrinogeno da un donatore (ma è molto raro). Questo può essere fatto reinfondendo il proprio sangue nelle cavità. Il fibrinogeno viene raccolto in un barattolo di Bobrov sterile senza conservanti, filtrato e reinfuso. Il fibrinogeno ematico si ripristina spontaneamente in 2-3 giorni.
Un'evidente emorragia secondaria precoce si verifica quando la legatura si stacca dal vaso a causa di un difetto nella sua applicazione. Una caratteristica distintiva è l'improvviso e massiccio flusso di sangue attraverso i drenaggi, con un netto peggioramento delle condizioni del paziente. Per arrestare tale emorragia, nonostante le gravi condizioni del paziente, viene eseguito un intervento chirurgico di reintervento d'urgenza (relaparotomia o retoracotomia).
Come esaminare?
Trattamento emorragie
Si distingue tra arresto spontaneo e arresto artificiale dell'emorragia. L'arresto spontaneo si verifica quando i vasi di piccolo calibro vengono danneggiati a causa dello spasmo e della trombosi. I traumi ai vasi di calibro maggiore richiedono l'uso di misure terapeutiche; in questi casi, l'arresto dell'emorragia si distingue in temporaneo e definitivo.
L'arresto temporaneo di un'emorragia non sempre giustifica il suo nome, poiché spesso le misure adottate in caso di lesione di vasi di medie dimensioni, soprattutto venosi, garantiscono un arresto definitivo. Le misure per l'arresto temporaneo di un'emorragia includono la posizione elevata dell'arto, un bendaggio compressivo, la massima flessione dell'articolazione, la pressione delle dita sul vaso, l'applicazione di un laccio emostatico, l'applicazione di una pinza al vaso e il suo mantenimento nella ferita.
La procedura più comune in terapia fisica per fermare un'emorragia è l'applicazione del freddo.
Questa azione prevede l'applicazione di un impacco sulla zona interessata, un sacchetto contenente ghiaccio, in modo da restringere i vasi sanguigni della pelle e degli organi interni in questa zona. Di conseguenza, si verificano i seguenti processi:
- I vasi sanguigni della pelle si restringono per riflesso, con conseguente diminuzione della temperatura, pallore della pelle, diminuzione della trasmissione del calore e ridistribuzione del sangue agli organi interni.
- I vasi sanguigni della pelle si dilatano per riflesso: la pelle diventa rosso-rosata e calda al tatto.
- I capillari e le venule si dilatano, le arteriole si restringono; il flusso sanguigno diminuisce; la pelle diventa cremisi e fredda. Successivamente, i vasi si restringono, quindi si verifica una riduzione regionale del sanguinamento, il metabolismo rallenta e il consumo di ossigeno diminuisce.
Gli obiettivi della procedura a freddo:
- Ridurre l'infiammazione.
- Ridurre (limitare) il gonfiore traumatico.
- Arrestare (o rallentare) l'emorragia.
- Anestetizzare la zona interessata.
Il bendaggio compressivo viene applicato come segue. L'arto leso viene sollevato. Un rotolo di garza sterile di cotone viene applicato sulla ferita e la si fascia strettamente. La posizione sollevata dell'arto viene mantenuta. La combinazione di queste due tecniche consente di arrestare efficacemente l'emorragia venosa.
Se i vasi sanguigni nel gomito o nella fossa poplitea sono danneggiati, l'emorragia può essere temporaneamente arrestata mediante la flessione massima dell'articolazione, fissando questa posizione con una benda di tessuti molli.
Se le arterie principali sono danneggiate, l'emorragia può essere fermata brevemente premendo il vaso contro le ossa sottostanti con le dita. Questo tipo di controllo dell'emorragia (dovuto al rapido affaticamento delle mani di chi presta soccorso) può durare solo pochi minuti, quindi è necessario applicare un laccio emostatico il prima possibile.
Le regole per l'applicazione di un laccio emostatico sono le seguenti. L'arto ferito viene sollevato e avvolto sopra la ferita in un asciugamano, su cui viene applicato il laccio emostatico. Quest'ultimo può essere standard (laccio emostatico di gomma di Esmarch) o improvvisato (un pezzo di tubo di gomma sottile, una cintura, una corda, ecc.). Se il laccio emostatico è di gomma, deve essere teso con forza prima dell'applicazione. Quando il laccio emostatico viene applicato correttamente, la pulsazione nella parte distale dell'arto scompare. Considerando che la durata dell'applicazione del laccio emostatico sull'arto non supera le 2 ore, è necessario annotare l'ora della sua applicazione, annotarla su un foglio e attaccarla al laccio emostatico. Il paziente deve essere trasportato in una struttura medica accompagnato da un operatore sanitario. L'arresto definitivo dell'emorragia può essere ottenuto con vari metodi: meccanici, termici, chimici e biologici.
I metodi meccanici per l'arresto definitivo dell'emorragia includono il tamponamento, la legatura del vaso nella ferita o lungo la sua lunghezza, la sutura vascolare. L'emostasi con un tampone di garza viene utilizzata per le emorragie capillari e parenchimatose, quando è impossibile utilizzare altri metodi. Dopo la trombosi dei vasi (dopo 48 ore), è consigliabile rimuovere il tampone per evitare infezioni. La legatura del vaso nella ferita deve essere eseguita sotto controllo visivo. Il vaso sanguinante viene afferrato con una pinza emostatica, legato alla base con un nodo, la pinza viene rimossa e viene annodato un secondo nodo. Talvolta la fonte di sanguinamento è nascosta da una massa muscolare possente, ad esempio nella regione glutea, e la sua ricerca è rischiosa a causa di un ulteriore trauma significativo. In questi casi, il vaso viene legato lungo la sua lunghezza (arteria iliaca interna). Interventi simili vengono eseguiti per le emorragie secondarie tardive da una ferita purulenta. Una sutura vascolare viene applicata quando si cuciono le estremità di un vaso lesionato o quando la sua sezione schiacciata viene sostituita con un trapianto o un'endoprotesi. Le suture manuali vengono utilizzate con fili di seta oppure vengono eseguite utilizzando dispositivi speciali che fissano le estremità del vaso lesionato con clip in tantalio.
I metodi termici includono l'esposizione dei vasi sanguinanti a basse e alte temperature. Il più delle volte, per prevenire la formazione di ematomi intermuscolari ed emartri, si utilizza l'esposizione della pelle al freddo sotto forma di impacchi di ghiaccio, irrigazione con cloruro di etile, impacchi freddi, ecc. Le emorragie capillari e parenchimatose vengono efficacemente arrestate da impacchi con una soluzione calda di cloruro di sodio allo 0,9%. L'elettrocoagulazione con diatermia fornisce una buona emostasi per le emorragie da vasi di piccole e medie dimensioni.
I metodi chimici per arrestare le emorragie includono l'uso di vasocostrittori e agenti coagulanti, utilizzati sia localmente che per via endovenosa. I più comuni sono lozioni e irrigazioni delle ferite con soluzioni di perossido di idrogeno, soluzione di adrenalina allo 0,1%, cloruri di calcio e di sodio. Soluzioni di cloruro di calcio al 10%, soluzioni di acido ascorbico al 5%, soluzioni di acido aminocaproico al 4%, ecc. vengono somministrate per via endovenosa.
I metodi biologici di arresto delle emorragie sono utilizzati principalmente per le emorragie capillari e parenchimatose. La causa di tali emorragie è rappresentata da interventi chirurgici associati alla separazione di estesi conglomerati adesivi e al danno agli organi parenchimatosi (fegato, reni). Tutti i metodi biologici di arresto delle emorragie possono essere suddivisi nei seguenti gruppi:
- tamponamento di una ferita sanguinante con tessuti autologhi ricchi di trombochinasi (omento, muscolo, tessuto adiposo, fascia); il tamponamento viene eseguito con un pezzo libero di omento, muscolo o un trapianto peduncolato con sutura ai margini delle ferite;
- trasfusione di piccole dosi (100-200 ml) di massa di globuli rossi, plasma;
- introduzione di bisolfito di sodio di menadione e soluzione di acido ascorbico al 5%;
- applicazione locale di derivati del sangue (film di fibrina, spugna emostatica, ecc.): vengono introdotti nella ferita e lasciati lì dopo la sutura.
In caso di anemia acuta, è necessario determinare il volume di sangue perso. Questo può essere determinato approssimativamente nei seguenti modi.
In base al quadro clinico.
- Non si verificano disturbi emodinamici: la perdita di sangue può arrivare fino al 10% del volume ematico circolante.
- Pelle pallida, debolezza, frequenza cardiaca fino a 100 al minuto, pressione sanguigna ridotta a 100 mm Hg, perdita di sangue fino al 20% del volume sanguigno circolante.
- Forte pallore della pelle, sudore freddo, adinamia, frequenza cardiaca fino a 120 al minuto, pressione sanguigna inferiore a 100 mm Hg, oliguria (perdita di sangue fino al 30% del volume sanguigno circolante).
- Alterazione della coscienza, frequenza cardiaca fino a 140 battiti al minuto, pressione sanguigna inferiore a quella critica, anuria (perdita di sangue superiore al 30% del volume sanguigno circolante).
- In caso di fratture della tibia, il volume di sangue perso è solitamente di 0,5-1 l, della coscia di 0,5-2,5 l, del bacino di 0,8-3 l.
L'entità della perdita di sangue può essere determinata in modo affidabile solo tramite esami di laboratorio (utilizzando tabelle o nomogrammi che tengano conto della pressione sanguigna, del BCC, dell'ematocrito, del peso specifico del sangue, ecc.)
La perdita di sangue acuta deve essere immediatamente compensata e, se il livello di emoglobina è pari a 100 g/l e l'ematocrito è del 30%, è indicata una trasfusione di emoderivati.

