Esperto medico dell'articolo
Nuove pubblicazioni
Papillomavirus umano: struttura, ciclo di vita, modalità di trasmissione, prevenzione
Ultima recensione: 04.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.
Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.
Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.
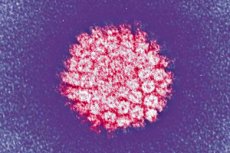
Una delle infezioni più comuni è il papilloma virus umano. Analizziamo i suoi principali tipi, il rischio di oncogenicità, i sintomi, i metodi diagnostici e terapeutici.
L'HPV è un'infezione altamente specifica per il corpo umano appartenente alla famiglia dei Papovaviridea, ovvero i Papovirus del sottogruppo A. Una persona su sei sul pianeta ne è portatrice. Il piccolo patogeno termostabile sopravvive bene nell'ambiente esterno ed è resistente al trattamento termico. Ha un'elevata capacità di infettare l'epitelio multistrato: pelle, mucose, epitelio cilindrico dei polmoni, prostata e canale cervicale.
Oggi la medicina conosce più di 120 sierotipi del virus, 35 dei quali colpiscono la pelle e le mucose. Alcuni sierotipi sono oncogeni, cioè in grado di causare la degenerazione tumorale dei tessuti colpiti.
- Bassa oncogenicità – 6, 11, 42, 43, 44, 73.
- Elevata oncogenicità: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68.
Una volta nel corpo umano, il virus si diffonde attraverso il flusso sanguigno, penetra nel DNA cellulare e ne compromette il normale funzionamento. La cellula infetta inizia a dividersi e crescere attivamente, causando la comparsa di escrescenze caratteristiche nella zona interessata.
Secondo le statistiche mediche, l'infezione da HPV è più comune se trasmessa durante i rapporti sessuali. Solo negli ultimi 7-10 anni, il numero di persone infette è aumentato di oltre 10 volte. La malattia richiede una diagnosi e un trattamento completi.
Struttura papillomavirus umano
L'HPV ha piccoli virioni privi di membrana, con un diametro non superiore a 30 nm. Le sue dimensioni sono quindi 5 volte inferiori a quelle del virus dell'influenza e dell'HIV, che presentano una membrana. Il materiale genetico del papillomavirus è il DNA, che contiene circa 8.000 coppie di basi e numerosi composti proteici. Il genoma è una molecola a doppio filamento ricca di istomi, ovvero proteine cellulari che partecipano alla compattazione del DNA nel nucleo.
I geni virali codificano diversi tipi di proteine, ciascuna delle quali svolge funzioni specifiche nel suo ciclo vitale. Si distinguono le proteine precoci (E), responsabili delle funzioni regolatorie e della proliferazione delle cellule infette, e le proteine tardive (L), che svolgono funzioni strutturali.
I seguenti tipi di proteine sono responsabili della struttura del virus:
- E1-E8 – partecipano alla replicazione del DNA e vengono sintetizzati immediatamente dopo l'infezione. Si manifestano con la granulosità della pelle, in cui si accumulano.
- L1-L2 – formano la struttura del virus. Sono responsabili della formazione dell'involucro esterno (capside), che penetra nello strato corneo dell'epidermide.
Particolarmente pericolose sono le strutture proteiche coinvolte nell'oncogenesi:
- E6 – disattiva il soppressore tumorale p53 delle cellule sane, causando un'eccessiva proliferazione delle strutture cellulari. E6 porta a una forte diminuzione di p53 e a processi degenerativi.
- E7 – lega Rb, cioè un oncosoppressore responsabile del rallentamento delle reazioni enzimatiche della divisione cellulare incontrollata.
E6 ed E7 portano a una crescita cellulare incontrollata, causando la formazione di tumori. Allo stesso tempo, la proteina E2 blocca questo processo patologico, ma questa capacità si perde immediatamente dopo che il genoma infetta una cellula umana.
A causa della sua struttura complessa, l'HPV è difficile da coltivare in laboratorio. Questo perché le particelle virali si formano solo in organismi viventi o in colture organotipiche complesse, simili alle cellule umane.
Ciclo di vita papillomavirus umano
Il processo infettivo e il ciclo vitale del papilloma virus umano si basano sull'auto-riproduzione di virioni infettivi. Nel normale corso del processo patologico, esiste una stretta relazione tra il ciclo di replicazione del DNA virale e il ciclo vitale di una cellula infetta del corpo umano. Il papillomavirus interrompe la replicazione del DNA cellulare, stabilendo un programma per la riproduzione delle proprie cellule infette con una maggiore attività infettiva.
Inibendo la replicazione, c'è un'alta probabilità di alterare il ciclo dell'infezione e trasformarlo in un tumore maligno. Se il ciclo vitale viene interrotto o interrotto, la produzione di virioni infettivi diventa impossibile.
In una cellula infetta, l'HPV esiste in due forme:
- Episomiale: localizzato all'esterno dei cromosomi della cellula infetta, presenta un basso rischio di oncogenicità.
- Integrato: il DNA virale è incorporato nel cromosoma cellulare. Questa forma è maligna.
A seconda della forma intracellulare dell'infezione, sono possibili le seguenti varianti del processo infettivo:
- Decorso latente (nascosto) – HPV in forma episomica, ma non provoca alterazioni patologiche e non presenta manifestazioni cliniche.
- I papillomi sono un'infezione di tipo episomiale. Il numero di cellule nello strato basale aumenta, il che porta alla comparsa di escrescenze cutanee di varie localizzazioni.
- Displasia: i virioni sono in forma episomale e integrata.
- Carcinoma: il virus si presenta in forma integrata. Compaiono cellule atipiche, a indicare lo sviluppo di processi maligni nell'organismo.
Il periodo di incubazione dall'infezione alla comparsa dei primi sintomi può variare da mezzo mese a diversi anni. In questo caso, nell'organismo possono svilupparsi contemporaneamente diversi genotipi. In alcuni casi, l'autoguarigione si verifica entro 6-12 mesi dall'infezione, ovvero si verifica una violazione della replicazione del DNA virale.
Come si trasmette il papillomavirus umano?
L'HPV si trasmette da una persona malata a una sana. L'infezione avviene attraverso stretti contatti familiari, durante i rapporti sessuali o durante il parto, da madre a figlio.
Le modalità di penetrazione dell'infezione nel corpo sono le seguenti:
- Contatto con pelle o mucose infette.
- Utilizzo di oggetti personali di una persona infetta.
- Indossare le scarpe o gli abiti del paziente.
- Frequentare saune, piscine e altri luoghi pubblici con elevata umidità.
Secondo le statistiche mediche, la via di trasmissione più comune dell'HPV è il rapporto sessuale non protetto. L'infezione si verifica indipendentemente dal tipo di contatto (vaginale, orale, anale). Il virus entra nell'organismo attraverso microlesioni delle mucose e dell'epidermide. La presenza di escrescenze nella cavità orale può indicare un'infezione durante un bacio o un rapporto orale. Gli uomini infettano le donne più spesso. L'infezione è possibile solo in presenza di papillomi e verruche sui genitali.
Quando l'infezione viene trasmessa dalla madre al figlio, la papillomatosi si trasmette durante il parto o durante il passaggio attraverso il canale del parto. Il neonato può sviluppare escrescenze anogenitali simili a verruche e condilomi sulla superficie interna della laringe e della faringe, complicando la respirazione. L'infezione può verificarsi anche durante l'allattamento. La trasmissione domestica del virus è estremamente rara. Ciò è dovuto al fatto che l'infezione non persiste a lungo nell'ambiente.
Poiché il virus del papilloma umano non è altamente contagioso, l'infezione avviene sotto l'influenza di alcuni fattori:
- Diminuzione delle difese del sistema immunitario.
- Violazione delle funzioni barriera dell'epidermide o delle mucose.
- Alterazione della microflora intestinale o vaginale.
- Malattia sessualmente trasmissibile (la papillomatosi è un'infezione secondaria).
- Esacerbazione delle malattie croniche.
- Stress frequente o condizioni di lavoro dannose.
- Mancato rispetto delle norme igieniche personali.
- Uso di farmaci che sopprimono il sistema immunitario.
Nel corso della vita, una persona può essere infettata contemporaneamente da diversi genotipi di infezione. L'azione dei fattori sopra menzionati porta all'attivazione dell'infezione. Le cellule infette iniziano a moltiplicarsi attivamente, causando escrescenze cutanee di varie forme e localizzazioni.
 [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ]
[ 13 ], [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ]
Immunità
Oggi la papillomatosi è una delle malattie più comuni. Le persone con un sistema immunitario forte possono essere portatrici del virus per un lungo periodo senza nemmeno saperlo.
È il sistema immunitario a svolgere un ruolo fondamentale nella protezione dell'organismo dai microrganismi patogeni. Una risposta immunitaria tempestiva porta alla distruzione del patogeno, che non ha il tempo di infettare le cellule basali dell'epitelio.
Esistono diversi fattori che indeboliscono il sistema immunitario e contribuiscono all'infezione e all'attivazione del virus:
- Frequenti infezioni virali respiratorie e lesioni infettive e infiammatorie del corpo.
- Attività fisica intensa.
- Stress e tensione psico-emozionale.
- Ipotermia.
- Abuso di alcol, fumo e altre cattive abitudini.
Una ridotta immunità favorisce la crescita attiva delle neoplasie papillomatose. Per prevenirla, si raccomanda l'assunzione di immunomodulatori e vitamine, che favoriscono una rapida guarigione e l'eliminazione del virus dall'organismo.
Prevenzione papillomavirus umano
È molto più facile e importante prevenire qualsiasi malattia che curarla. La prevenzione del papilloma virus umano si basa su uno stile di vita sano e sul rafforzamento del sistema immunitario. È il sistema immunitario a svolgere un ruolo decisivo nella comparsa dell'infezione da HPV. Quando le difese dell'organismo si indeboliscono, anche l'organismo si indebolisce, creando un ambiente favorevole per le lesioni infettive.
La prevenzione della papillomatosi e di altre malattie si riduce a queste semplici regole:
- Stile di vita sano.
- Assenza di cattive abitudini.
- Nutrizione corretta ed equilibrata.
- Rapporti sessuali protetti e partner regolare.
- Assenza di stress e di altri shock emotivi.
- Trattamento tempestivo di qualsiasi patologia.
- Vaccinazione.
- Visite mediche preventive periodiche.
Le raccomandazioni di cui sopra si riferiscono al primo livello di prevenzione. Esistono vaccini specifici per prevenire l'infezione da HPV ad alto rischio cancerogeno. Contengono proteine-antigeni virali, sotto l'influenza dei quali l'organismo produce anticorpi specifici che contribuiscono a distruggere l'infezione quando si manifesta.
Esistono anche misure di prevenzione secondaria, che includono lo screening visivo e citologico per rilevare il virus e monitorarne le dinamiche di sviluppo. Se i risultati di questi test sono positivi, al paziente viene prescritta una serie completa di esami diagnostici. Di norma, si tratta di PCR, biopsia, colposcopia e una serie di altri metodi.
La prevenzione terziaria viene effettuata in caso di infezione da HPV ad alto rischio oncogeno. Il paziente deve sottoporsi a un Pap test per la citologia ogni sei mesi per tre anni dopo l'infezione. Se il risultato è negativo, il test viene ripetuto una volta all'anno per il resto della vita del paziente.
Vaccinazione contro il papillomavirus umano
Uno dei metodi di prevenzione della papillomatosi è la vaccinazione. La vaccinazione contro il papilloma virus viene utilizzata per prevenire l'infezione da HPV ad alto rischio cancerogeno, ovvero i tipi 16 e 18. Si consiglia di vaccinarsi prima dei primi rapporti sessuali, ovvero nell'adolescenza, dai 16 ai 23 anni.
Bisogna tenere presente che se il virus è già presente nell'organismo, l'effetto dell'iniezione è nullo. Tuttavia, molti scienziati ritengono che la somministrazione del vaccino a pazienti già infetti allevi il decorso del virus e acceleri il processo di guarigione.
La vaccinazione prevede l'inoculazione di uno dei seguenti farmaci:
- Cervarix
Vaccino ricombinante adsorbito per la prevenzione delle malattie causate dal papilloma virus umano. Contiene una miscela di particelle virali dei ceppi 16 e 18. L'efficacia del farmaco si basa sul suo sistema adiuvante. Fornisce protezione crociata dell'organismo da qualsiasi manifestazione di HPV rilevabile citologicamente.
Durante la vaccinazione completa secondo un calendario vaccinale specifico, il farmaco promuove la formazione di anticorpi specifici contro il virus nell'organismo. Le immunoglobuline vengono rilevate nel 100% dei pazienti sottoposti a un ciclo vaccinale.
- Indicazioni d'uso: prevenzione del cancro cervicale nelle pazienti di sesso femminile di età compresa tra 10 e 25 anni, prevenzione delle infezioni acute e croniche associate al papillomavirus umano, nonché delle patologie cellulari, tra cui lo sviluppo di cellule atipiche piatte di eziologia sconosciuta, neoplasia intraepiteliale cervicale e condizioni precancerose nelle pazienti di età compresa tra 10 e 25 anni.
- Metodo di somministrazione: il vaccino viene somministrato nell'area del muscolo deltoide. La somministrazione endovenosa e intradermica è controindicata. Prima della vaccinazione, il preparato deve essere sottoposto a test organolettici e agitato accuratamente per ottenere una sospensione bianca opaca. Il medicinale viene somministrato in tre fasi con una singola dose da 0,5 ml. Per la vaccinazione primaria, il programma è 0-1-6 mesi.
- Effetti collaterali: dolore al sito di iniezione, aumento dell'affaticamento, vertigini, disturbi gastrointestinali e muscoloscheletrici, reazioni allergiche cutanee. Esiste anche il rischio di reazioni anafilattiche.
- Controindicazioni: ipersensibilità ai componenti del vaccino, ipertermia acuta, ricadute di malattie croniche. La vaccinazione deve essere effettuata con particolare cautela in caso di trombocitopenia e disturbi della coagulazione del sangue. Il vaccino non è adatto per il trattamento di lesioni preesistenti causate da HPV di tipo 16 e 18. Le iniezioni di Cervarix non devono essere effettuate durante la gravidanza e l'allattamento. Non sono stati registrati casi di sovradosaggio.
Il vaccino è disponibile in siringa monodose. Il farmaco deve essere conservato in frigorifero per tre anni dalla data di produzione.
- Gardasil e Gardasil 9
Il farmaco Gardasil è un set di antigeni di papillomavirus di tipo 6, 11, 16 e 18. Contribuisce ad attivare il sistema immunitario per formare anticorpi antivirali e fornire protezione immunologica all'organismo. Gardasil®9 è un vaccino ricombinante 9-valente contro il papillomavirus umano. È attivo contro i seguenti ceppi di infezione: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. Entrambi i vaccini forniscono protezione crociata contro i genotipi non presenti nel farmaco: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 e 59.
- Indicazioni d'uso: prevenzione dell'infezione da papillomavirus umano, prevenzione di patologie cancerose e precancerose di cervice, vulva, ano e pene. Raccomandato per la vaccinazione di pazienti di età compresa tra 9 e 45 anni.
- Istruzioni per l'uso: agitare il flacone con la soluzione e verificare la presenza di inclusioni estranee. Aspirare la soluzione in una siringa e iniettare per via intramuscolare nel delta della spalla o nella parte anterolaterale della coscia. Dopo la procedura, il paziente deve essere tenuto sotto controllo medico per 30 minuti. Le iniezioni vengono somministrate secondo schemi appositamente sviluppati. Schema standard 0-2-6 mesi, accelerato 0-1-4 mesi.
- Effetti collaterali: prurito, gonfiore e dolore nel sito di iniezione, mal di testa, febbre, svenimento, anafilassi, processi infiammatori negli organi pelvici, tromboembolia, orticaria, gastroenterite, ecc. In caso di sovradosaggio, la gravità delle reazioni sopra descritte aumenta.
- Controindicazioni: intolleranza ai principi attivi, disturbi della coagulazione del sangue, gravidanza e allattamento, trattamento con anticoagulanti.
Gardasil e Gardasil 9 sono disponibili sotto forma di sospensione in fiale con un dosaggio di 0,5 ml ciascuna.
I vaccini sopra indicati sono certificati e hanno superato tutti i controlli necessari. La vaccinazione viene effettuata in regime ambulatoriale, nel rispetto delle norme di asepsi e antisepsi.
 [ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ], [ 24 ], [ 25 ]
[ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ], [ 24 ], [ 25 ]
Usare il preservativo per prevenire l'HPV
La principale via di trasmissione dell'HPV è il sesso non protetto con una persona infetta. Studi clinici hanno dimostrato che l'uso del preservativo per prevenire il papillomavirus è altamente efficace. Con questo metodo contraccettivo, l'infezione si verifica in circa il 30% dei casi. Il rischio di infezione durante i rapporti sessuali senza l'uso del preservativo è del 90%. La trasmissione dell'HPV tramite il preservativo si verifica più spesso dopo il sesso anale, non dopo quello vaginale.
Bisogna anche tenere presente che i microrganismi patogeni sono presenti in tutti i fluidi biologici del corpo umano: saliva, muco, ecc. Pertanto, se uno dei partner presenta delle escrescenze caratteristiche della malattia sulla mucosa della cavità orale, l'infezione è possibile non solo durante il sesso orale, ma anche durante il bacio.
Per quanto riguarda i rapporti sessuali durante il trattamento della papillomatosi, i rapporti intimi sono possibili dopo aver eseguito metodi distruttivi di disinfezione di papillomi, condilomi o verruche e dopo un ciclo di trattamento antivirale per sopprimere l'attività dell'infezione. In questo caso, i rapporti sessuali dovrebbero essere effettuati solo con l'uso di contraccettivi di barriera per prevenire recidive o infezioni del partner.
Previsione
Il papillomavirus umano è una delle malattie a decorso latente più comuni. La prognosi di questa patologia quando infettata da ceppi a bassa e media oncogenicità è favorevole. In caso di infezione da HPV del terzo gruppo (alta cancerogenicità), l'esito della malattia dipende dalla diagnosi precoce e dal trattamento.

