Esperto medico dell'articolo
Nuove pubblicazioni
Sindrome catatonica
Ultima recensione: 12.07.2025

Tutti i contenuti di iLive sono revisionati o verificati da un punto di vista medico per garantire la massima precisione possibile.
Abbiamo linee guida rigorose in materia di sourcing e colleghiamo solo a siti di media affidabili, istituti di ricerca accademici e, ove possibile, studi rivisti dal punto di vista medico. Nota che i numeri tra parentesi ([1], [2], ecc.) Sono link cliccabili per questi studi.
Se ritieni che uno qualsiasi dei nostri contenuti sia impreciso, scaduto o comunque discutibile, selezionalo e premi Ctrl + Invio.
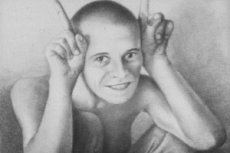
Un fenomeno psichiatrico, una forma particolare di follia, descritto per la prima volta come malattia a sé stante da K. Kohlbaum alla fine del XIX secolo. Fu lui a coniare anche il nome: catatonia, che deriva dal greco antico κατατείνω, che significa "sforzare". La manifestazione principale di questa condizione è una violazione del tono muscolare, la cui tensione è associata a disturbi della volontà.
Successivamente, la sindrome catatonica fu attribuita alla psicosi schizofrenica. È ormai noto che la catatonia può manifestarsi, oltre che con la schizofrenia, in concomitanza con molti disturbi mentali, nonché con malattie neurologiche e generali, intossicazioni, neoplasie e lesioni cerebrali.
Epidemiologia
La prevalenza della catatonia nella popolazione mondiale è sconosciuta e vari studi riportano dati completamente contraddittori.
Esistono prove che circa il 5-10% degli schizofrenici sviluppi sintomi di catatonia. E sebbene le manifestazioni catatoniche siano ancora considerate nel contesto della schizofrenia, in alcuni studi moderni condotti su pazienti con sindrome catatonica inclusi nel campione, su nove-dieci persone con disturbi affettivi, si riscontrava un solo schizofrenico.
Si stima che tra i giovani affetti da disturbi dello spettro autistico i sintomi della catatonia siano riscontrati in una persona su sei/ottave.
Secondo diverse fonti, dal 10 al 17% dei pazienti con catatonia viene ricoverato in ospedali psichiatrici. Il ruolo dei fattori etnici nello sviluppo di questa sindrome è sconosciuto.
L'incidenza della catatonia nei pazienti di sesso femminile e maschile è pressoché la stessa, ma la catatonia idiopatica è più comune nelle donne.
La sindrome catatonica nelle persone a rischio può manifestarsi a qualsiasi età, tuttavia nei bambini e negli anziani è molto meno frequente rispetto alle generazioni più giovani. In genere, la catatonia si manifesta negli schizofrenici all'inizio delle manifestazioni della malattia principale, tra i 16 e i 40 anni.
Le cause catatonia
Attualmente non si sa esattamente quali processi cerebrali causino uno stato catatonico. Tuttavia, anche uno sviluppo anomalo intrauterino della corteccia cerebrale nel feto può portare alla schizofrenia e ad altri disturbi mentali. Non si esclude una predisposizione ereditaria.
I sintomi della catatonia si osservano in persone con disturbi funzionali delle connessioni glutammatergiche corticali e sottocorticali, disturbo dell'equilibrio tra eccitazione e inibizione, deficit funzionale dell'acido γ-amminobutirrico e blocco dei recettori dopaminergici postsinaptici.
Inoltre, durante l'autopsia di persone decedute con sindrome catatonica, sono state rilevate anomalie strutturali degli elementi frontali dell'encefalo (fossa cerebrale, circonvoluzioni frontali media e inferiore).
La catatonia non è un'entità nosologica indipendente. Oltre alle anomalie congenite e alle patologie ostetriche, tra le cause di questa sindrome si considerano anche disturbi organici acquisiti derivanti da malattie, lesioni e intossicazioni.
 [ 8 ]
[ 8 ]
Fattori di rischio
È stato identificato il cosiddetto spettro catatonico delle malattie, in cui è più probabile lo sviluppo della catatonia.
Innanzitutto, si tratta di disturbi mentali, con disturbi emotivi ( affettivi ) in primo piano, in particolare depressione profonda e mania, persino prima della schizofrenia. Questo spettro di patologie include psicosipost-traumatiche e post-partum, nevrosi isterica e disturbi autistici. La sindrome catotonica si osserva in pazienti con ritardo mentale e bambini con disturbi dello sviluppo mentale.
Le persone che hanno sofferto di encefalite, ictus, trauma cranico, epilessia, tumori al cervello e malattia di Tourette presentano un rischio piuttosto elevato di sviluppare uno stato catatonico.
Alcuni disturbi metabolici congeniti e acquisiti che portano a carenza di sodio o cianocobalamina, eccesso di rame ( malattia di Wilson-Konovalov ) e idiozia amaurotica nella prima infanzia sono considerati fattori di rischio per questa sindrome.
Patologie endocrine e autoimmuni croniche, malattie oncologiche, morbo di Werlhof, AIDS e febbre tifoide possono portare allo sviluppo di catatonia. Questa condizione può anche essere conseguenza di ipossia, colpo di calore, gravi malattie subite durante l'infanzia, in particolare la febbre reumatica.
La sindrome catatonica si sviluppa nei tossicodipendenti a seguito di intossicazione da monossido di carbonio e gas di scarico, come effetto collaterale di un ciclo terapeutico a base di bloccanti del recettore della dopamina (neurolettici), anticonvulsivanti, glucocorticosteroidi, antibiotici come la ciprofloxacina, disulfiram (un farmaco per il trattamento degli alcolisti), miorilassanti con il principio attivo ciclobenzaprina. La sospensione improvvisa dell'antipsicotico clozapina, degli anticonvulsivanti e dei dopaminomimetici, nonché delle benzodiazepine, può causare questa condizione.
In alcuni casi non è mai stato determinato cosa scatenasse lo sviluppo della catatonia: sindrome catatonica idiopatica.
Patogenesi
Anche il meccanismo con cui si sviluppa questa condizione rientra nell'ambito delle speculazioni, e ne esistono diverse.
Poiché si osserva un pronunciato effetto terapeutico nel trattamento della catatonia con l'uso di farmaci benzodiazepinici, si presume che alla base del disturbo delle funzioni psicomotorie vi sia una carenza di acido γ-amminobutirrico (GABA), il principale neurotrasmettitore dei processi di inibizione nella corteccia cerebrale. Le benzodiazepine normalizzano le funzioni dei nuclei della base, influenzando i recettori GABA, aumentando l'affinità dell'acido per i neuroni cerebrali. Un'altra ipotesi simile riguarda l'aumentata attività del neurotrasmettitore eccitatorio, il glutammato.
I tentativi di trattare la catatonia con neurolettici non hanno avuto successo, anzi è stato osservato un peggioramento delle condizioni dei pazienti. Su questa base, si ipotizza che la catatonia si verifichi a causa di un blocco immediato e massiccio dei recettori dopaminergici. Inoltre, il trattamento con stimolanti della dopamina è solitamente efficace, e anche la terapia elettroconvulsivante (elettroshock) promuove il rilascio di recettori dopaminergici.
La sindrome da astinenza dal neurolettico atipico Clozapina si manifesta sotto forma di catatonia, la cui causa è legata al rilascio dei recettori colinergici e serotoninergici, a causa dei quali aumenta l'attività di questi sistemi.
Nei pazienti con sindrome catatonica cronica, accompagnata da grave disfunzione del linguaggio, le tomografia PET rivelano disturbi metabolici bilaterali nella parte superiore della zona talamica del diencefalo e nei lobi frontali della corteccia cerebrale.
I ricercatori hanno identificato un tipo speciale di catatonia autistica osservata in individui con disturbi dello sviluppo mentale, la cui patogenesi comprende una carenza di acido γ-amminobutirrico, disturbi nelle piccole strutture del cervelletto e una predisposizione ereditaria dovuta alla presenza di un gene sul braccio lungo del cromosoma 15.
Si ritiene che la crisi epilettica non convulsiva sotto forma di sindrome catatonica (catatonia ictale) sia causata da danni al cervello viscerale ( sistema limbico ).
Queste ipotesi si basano su osservazioni reali di pazienti, sulle loro reazioni ai farmaci e ai test diagnostici. Un'altra ipotesi si basa sul fatto che la sindrome catatonica è attualmente osservata in pazienti con malattie mentali e generali che si trovano in condizioni gravi (pre-morte). Lo stupore catatonico è considerato una reazione di orrore causata da un senso di morte imminente. Le prede cadono in uno stato simile quando incontrano un predatore.
Sintomi catatonia
I primi segni di catatonia imminente creano l'impressione di un aumento anomalo delle caratteristiche peculiari dell'individuo. Nel periodo prodromico, il paziente è più introverso del solito, trascorre quasi tutto il tempo da solo ed è irritato dai tentativi di coinvolgerlo in attività comuni. Lamenta spesso difficoltà ad addormentarsi, mal di testa, debolezza e incapacità di compiere azioni significative.
Successivamente, l'umore cambia in modo significativo, compaiono ansia, vari pensieri e visioni deliranti, intorpidimento degli arti e di tutto il corpo, la percezione della realtà si trasforma, la negatività aumenta, il paziente può rifiutarsi completamente di muoversi e di mangiare.
Sono stati descritti molti sintomi della sindrome catatonica, alcuni dei quali sono caratteristici di diversi disturbi mentali; non è necessario che un complesso completo di sintomi si manifesti in un singolo paziente. Le caratteristiche dei segni clinici dipendono dal tipo di sindrome e dall'età del paziente.
Durante lo stato catatonico si può osservare quanto segue:
- stupore - una combinazione di completa immobilità e assenza di qualsiasi tipo di contatto con il paziente (mutismo), sebbene in linea di principio il paziente conservi la capacità di parlare, a volte si manifesta uno dei sintomi: immobilità o mutismo;
- negativismo: il paziente resiste ai tentativi di dare al proprio corpo una posizione diversa, mentre la resistenza muscolare è pari in forza agli sforzi esterni;
- disgusto verso gli altri, il personale medico (avversione) – il paziente non risponde all'appello, si allontana, dimostrando con tutto il suo aspetto una riluttanza a stabilire un contatto;
- catalessi (flessibilità cerea) - un periodo anormalmente lungo di mantenimento di una posizione fantasiosa ed estremamente scomoda, che il medico può dare al paziente; inoltre, il paziente stesso assume spesso posizioni strane e scomode e vi rimane per lungo tempo;
- sottomissione portata all'automatismo: il paziente fa assolutamente tutto con straordinaria precisione, il corpo assume con flessibilità qualsiasi posizione, anche la più scomoda, senza resistenza, ma torna di nuovo alla posizione originale quando non viene toccato (a differenza della catalessi);
- il segno del “cuscino d’aria” – il paziente giace con la testa sollevata dalla superficie del letto, come se fosse su un cuscino invisibile, per un tempo piuttosto lungo – una posizione tipica della catatonia;
- ambitendente – manifestazione di ambizioni peculiari; il paziente, pur acconsentendo, non vuole comunque obbedire, ad esempio porge la mano al medico, ma all'ultimo momento la ritira;
- verbigerazione – ripetizione degli stessi stereotipi linguistici: frasi o periodi, parole (palilalia), singole sillabe (logoclonia);
- logorrea - mormorio monotono, continuo, incoerente;
- ecolalia – il paziente ripete tutti i suoni pronunciati dal medico;
- ecoprassia: ripetere i movimenti di qualcun altro;
- blocco del pensiero e del movimento - improvvisa cessazione del linguaggio o del movimento;
- Stereotipi e perseverazioni motorie: ripetizione costante di movimenti identici e privi di significato.
I pazienti hanno gli occhi spalancati, afferrano la mano del medico durante la visita, dell'infermiere o dei parenti, impedendo loro di toccarli. Un tratto caratteristico è la transizione istantanea da uno stato di torpore a uno di eccitabilità e viceversa, mentre i movimenti sono impulsivi, assurdi e privi di significato (salti, capriole, attacchi). L'eccitazione linguistica si manifesta con imprecazioni, canti, borbottii indistinti. Sia l'eccitazione motoria che quella linguistica sono caratterizzate da infinite ripetizioni di smorfie, salti, grida. Alcuni pazienti sono educati: salutano e si inchinano continuamente. A volte la transizione da uno stato di eccitazione a uno di inibizione e viceversa avviene gradualmente.
Nella maggior parte dei casi i pazienti sono orientati in modo soddisfacente nel tempo e nello spazio, ma si verificano anche confusione della coscienza, del linguaggio, allucinazioni molto varie, istantanee o a sviluppo graduale.
Gli stadi gravi sono caratterizzati da sintomi quali mutismo e immobilità, forte negativismo, posture bizzarre, riluttanza a mangiare, rigidità muscolare prolungata e crescenti disturbi del linguaggio.
Spesso uno stato di eccitazione con delirio e allucinazioni è seguito da una normalizzazione a breve termine dello stato, a volte così lunga da rasentare la guarigione.
Tuttavia, uno stato di torpore catatonico di varia intensità e durata si sviluppa ancora più frequentemente. Può essere cronico, con frequenti e improvvisi scoppi d'ira, accompagnati da fughe insensate.
Talvolta la sindrome si manifesta sotto forma di crisi catatoniche, che si esprimono nell'alternanza periodica di stupore ed eccitazione.
I sintomi del disturbo dell'innervazione vascolare sono evidenti: il viso pallido del paziente può arrossarsi all'istante, a volte anche alcune parti del corpo diventano rosse: la fronte, una guancia, un orecchio, il collo. I pazienti perdono peso e hanno disturbi del sonno persistenti. Altri sintomi somatici che accompagnano la catatonia sono aritmie, aumento della sudorazione e della salivazione, eruzioni cutanee simili all'orticaria, fluttuazioni della temperatura corporea (mattina e sera), costrizione - dilatazione delle pupille e variabilità della loro reazione, respiro superficiale.
La catatonia cronica nelle malattie mentali, in particolare negli schizofrenici, porta generalmente alla progressione del ritardo mentale. Allo stesso tempo, è proprio nella forma catatonica della schizofrenia che le remissioni a lungo termine dopo la sindrome nel 15% dei pazienti sono praticamente simili alla loro guarigione.
La catatonia infantile si manifesta spesso con sintomi di stereotipi motori ritmici: smorfie, corsa in tondo, movimenti monotoni di braccia, gambe e corpo, corsa o camminata in punta di piedi, sul lato esterno o interno del piede, ecc. Movimenti e azioni sono caratterizzati da impulsività, mutismo, ecoprassia, ecolalia e si osservano spesso altri disturbi del linguaggio. Spesso, un bambino può presentare una catatonia regressiva: inizia a imitare completamente il comportamento degli animali (leccandosi e leccando oggetti, mangiando senza l'aiuto di posate, ecc.).
Bisogna tenere presente che la sindrome catatonica non sempre attraversa tutte le fasi di sviluppo descritte e in diversi casi si osserva un ordine casuale.
I disturbi psicomotori nella sindrome catatonica sono classificati come agitazione e stupore.
Lo stato eccitato è caratterizzato dall'attività psicomotoria e si divide nelle seguenti forme:
- eccitazione patetica (mantenendo la coscienza) - aumenta gradualmente, nella fase più elevata - manifestazioni moderate; i pazienti sono manierati, patetici, c'è uno sfondo elevato di umore, sotto forma di esaltazione, e non ipertimia; si notano pose e gesti patetici, può esserci ecolalia; poi l'eccitazione aumenta e il paziente inizia a scherzare apertamente, compaiono azioni impulsive, che ricordano l'ebefrenia;
- l'eccitazione impulsiva ha un esordio acuto, si sviluppa improvvisamente e rapidamente, nella maggior parte dei casi le azioni del paziente sono dure e distruttive, di natura antisociale; si osservano disturbi del linguaggio (verbigerazione);
- Oltre al culmine della forma precedente, che raggiunge il punto di frenesia, alcuni esperti distinguono una terza variante: l'eccitazione silenziosa, quando il paziente, senza emettere un suono, distrugge tutto ciò che lo circonda, riversando aggressività su chi gli sta intorno e persino su se stesso.
Nello stupore, i muscoli del paziente sono quasi sempre tesi e rigidi, a volte al punto da rendere impossibili anche i movimenti passivi. Un paziente in stato di substupore è sedentario e lento, mentre in stato di stupore giace, siede o sta in piedi immobile. Il paziente è silenzioso, il suo viso è come una maschera congelata, le espressioni facciali sono spesso assenti, a volte i movimenti dei muscoli facciali corrispondono allo stato affettivo: il paziente corruga la fronte, stringe le palpebre, contrae i muscoli delle mascelle e del collo, allunga le labbra come una "pipa". I pazienti possono rimanere in uno stupore catatonico per un lungo periodo, misurato in settimane e mesi. Si riscontra un disturbo di tutte le funzioni, anche quelle istintive, nonché sintomi di disturbi della sfera somatica e del sistema nervoso autonomo: cianosi e gonfiore delle estremità, ipersalivazione, iperidrosi, seborrea, ipotensione. Si distinguono tre forme di catatonia stuporosa:
- catalettico: l'individuo mantiene per un lungo periodo di tempo una determinata posizione, spesso innaturale, che ha adottato lui stesso o gli è stata data da altri (flessibilità cerea), ad esempio, sdraiato su un "cuscino d'aria" con una coperta sopra la testa; un discorso normale e ad alta voce non provoca una reazione, ma può reagire a un sussurro; sotto l'influenza dell'oscurità e del silenzio, lo stupore a volte si indebolisce e il contatto diventa possibile per un po' (questa forma è caratterizzata dalla presenza di delirio e allucinazioni);
- negativistico - il ritardo motorio è associato alla resistenza a qualsiasi tentativo da parte del paziente di cambiare posizione; la resistenza può essere attiva e passiva;
- intorpidimento - picco di inibizione e rigidità dei muscoli, spesso in posizione fetale o su un "cuscino d'aria", le labbra sono distese a forma di tubo.
Sono state osservate trasformazioni reciproche di una forma di stupore o eccitazione catatonica in un'altra, sebbene tali casi siano rari. Più comuni sono le trasformazioni di uno stato eccitato in uno stuporoso e viceversa, solitamente del tipo appropriato, ad esempio, eccitazione patetica → stupore catalettico, impulsiva → negativistica o stupore con intorpidimento.
In base alla presenza o assenza di un disturbo della coscienza, la catatonia viene classificata nei seguenti tipi: vuota, lucida e onirica.
La sindrome "vuota" è caratterizzata dai sintomi tipici della sindrome senza delirio e allucinazioni, nonché da: iterazioni monotone di movimenti, pose, frasi e parole, catalessi, sintomi di eco, negativismo - inerte (il paziente sabota le richieste), attivo (il paziente esegue azioni, ma non quelle richieste), paradossale (esegue azioni opposte a quelle richieste). Questo tipo di sindrome si osserva talvolta in lesioni organiche del tessuto cerebrale (neoplasie, conseguenze di traumi cranio-cerebrali, infezioni e intossicazioni).
La catatonia lucida (pura) è caratterizzata dalla presenza di sintomi produttivi (deliri, allucinazioni) in assenza di disturbi della coscienza. L'autoidentificazione dell'individuo non è compromessa, ricorda e riesce a riprodurre gli eventi realmente accaduti durante il periodo di stupore.
La catatonia oneiroide è il decorso di questa sindrome, con episodi deliranti e maniacali, allucinazioni e annebbiamento della coscienza. Inizia improvvisamente con un marcato aumento dell'eccitazione psicocinetica. Il comportamento e le espressioni facciali dell'individuo cambiano rapidamente e compaiono tratti maniacali. I movimenti sono attivi, naturali, flessibili, compaiono delirio, attività linguistica e mancanza di bisogno di un interlocutore (schizofasia). Il paziente sperimenta eventi vividi e vividi in un mondo solitario che non corrispondono affatto alla realtà: il sonno catatonico, caratterizzato dalla presenza di una trama e dalla completezza. L'individuo stesso si sente il protagonista di storie che si sono svolte esclusivamente nella sua mente. Queste sono accompagnate da un'eccitazione fantastica, con un'intensa colorazione emotiva, con cambiamenti istantanei dall'eccitazione caotica a uno stato di torpore. Le espressioni facciali del paziente, che riflettono l'eccitazione che sperimenta nel sonno catatonico, sono solitamente molto espressive. Dopo essere uscito dalla sindrome, il paziente non ricorda alcun evento reale, ma è in grado di descrivere i suoi "sogni". Il sonno catatonico dura da diversi giorni a diverse settimane.
Si ritiene che la catatonia lucida sia caratteristica solo della schizofrenia, mentre la catatonia oneiroide è più comune nelle neoplasie delle parti basali del cervello, nelle psicosi epilettiche post-traumatiche o acute, nelle conseguenze di gravi infezioni e intossicazioni e nella paralisi progressiva.
La catatonia febbrile è un disturbo mentale acuto e si osserva negli schizofrenici e negli individui con disturbi affettivi. Le manifestazioni esterne assomigliano a quelle di tipo onirico, accompagnate dal rapido sviluppo non solo di disturbi psicopatologici, ma anche somatici. Può avere un decorso maligno se non si inizia immediatamente con misure terapeutiche nelle prime ore di sviluppo della sindrome.
Un sintomo specifico è l'elevata temperatura corporea, che si manifesta con febbre, e possono verificarsi sbalzi di temperatura. Inoltre, il polso e il respiro del paziente accelerano, la pelle diventa grigiastra, i tratti del viso si fanno più definiti, le orbite si infossano, la fronte si ricopre di gocce di sudore, lo sguardo non è concentrato, le labbra sono secche e la lingua presenta una patina bianca o marroncina.
La causa della morte del paziente è lo sviluppo di un edema cerebrale.
La catatonia regressiva si osserva più spesso nei bambini. Si manifesta con la copia degli stereotipi comportamentali degli animali.
Complicazioni e conseguenze
Le caratteristiche della sindrome catatonica sono tali da poter causare conseguenze negative sia per il paziente che per chi gli sta intorno. Questa condizione non può essere ignorata; ai primi segni della sindrome, è necessario consultare un medico ed eventualmente anche ricoverare il paziente.
La maggior parte dei pazienti in stato di eccitazione presenta un comportamento antisociale e può causare gravi lesioni a se stessi e agli altri, anche mortali.
Il rifiuto di mangiare può portare a cachessia, disidratazione e morte per inedia se il paziente non viene nutrito e idratato forzatamente tramite un sondino. L'alimentazione non naturale a lungo termine è complicata da disturbi dell'apparato digerente, squilibrio idroelettrolitico, sviluppo di ipoglicemia e ipercapnia.
Nei pazienti affetti da sindrome catatonica, a seguito della prolungata permanenza in una posizione (spesso innaturale), possono comparire piaghe da decubito, polmonite ipostatica, trombosi venosa, embolia polmonare e pneumotorace.
La mancata osservanza delle più elementari norme igieniche può portare a infezioni del cavo orale e degli organi genitourinari.
La catatonia è spesso complicata da sintomi vegetativi, ipertermia, disfunzione cardiaca, fluttuazioni della pressione sanguigna, comparsa di contratture muscolari, paresi e paralisi.
Il decorso maligno della sindrome catatonica porta solitamente alla morte.
Diagnostica catatonia
Questa condizione viene diagnosticata dagli psichiatri, basandosi sulla storia clinica del paziente e sui risultati degli esami oggettivi.
La base per l'esame del paziente è la presenza di uno o più sintomi di sindrome catatonica. Vengono presi in considerazione la presenza di immobilità prolungata in una posizione (stupore), agitazione anomala, mutismo, negativismo, resistenza o sottomissione automatica, posture bizzarre (flessibilità della cera), fenomeni di eco, rigidità muscolare, verbigerazione e autismo.
Sono obbligatori gli esami di laboratorio: sangue - clinico, per il contenuto di glucosio, creatinfosfochinasi, ormoni tiroidei, test di funzionalità epatica, contenuto di autoanticorpi, metalli pesanti, infezione da HIV e reazione di Wasserman; urine - generali e per la presenza di sostanze stupefacenti, test specifici per la funzionalità renale. Possono essere prescritti esami batteriologici del sangue e delle urine.
Sulla base dei risultati dell'esame, vengono prescritti esami diagnostici strumentali, che possono includere elettrocardiografia, ecografia, elettroencefalografia, tomografia computerizzata e risonanza magnetica. Se necessario, al paziente viene prescritta una puntura del liquido spinale e possono essere prescritti altri esami più specifici.
La catatonia è una condizione che si manifesta in diverse patologie. Innanzitutto, il medico deve identificare le cause curabili, che giocano un ruolo decisivo nella scelta della strategia terapeutica.
Diagnosi differenziale
La sindrome catatonica può svilupparsi in diverse condizioni patologiche e la loro differenziazione è di fondamentale importanza nella prescrizione di farmaci volti a normalizzare le condizioni del paziente.
Innanzitutto, si presume che il paziente soffra di schizofrenia, poiché la sindrome catatonica è storicamente associata a questa malattia. La catatonia patetica al culmine della crescita dei sintomi deve essere differenziata da un sottotipo di questa malattia come l'ebefrenia: chi soffre di questa forma della malattia si comporta in modo infantile, fa smorfie, e il suo background emotivo è instabile. Per la diagnosi di schizofrenia catatonica (secondo l'ICD-10), almeno uno dei principali sintomi della catatonia (stupore/agitazione, immobilità in varie posizioni/flessibilità cerea/rigidità muscolare, negativismo/automatismo dei comandi) deve essere registrato nel paziente per almeno due settimane.
Per i disturbi affettivi, il criterio diagnostico è la manifestazione più estrema: lo stupore catatonico. La catatonia è riconosciuta come diagnosi correlata a disturbi affettivi come il disturbo ossessivo-compulsivo, la depressione, la mania e il disturbo bipolare.
La catalessi (una condizione in cui una persona mantiene una posizione scomoda per lungo tempo e questa posizione può essere facilmente cambiata) è uno dei sintomi della catatonia, ma non l'unico. Le crisi catalettiche sono chiamate paralisi del sonno e nella maggior parte dei pazienti si risolvono abbastanza rapidamente.
La sindrome neurolettica maligna, causata dall'assunzione di antipsicotici, è considerata da molti specialisti una forma di catatonia letale. Tuttavia, queste due condizioni presentano un'importante differenza clinica: l'esordio della prima è caratterizzato da un'estrema eccitazione psicotica, mentre la seconda si manifesta con una grave rigidità extrapiramidale dei muscoli del corpo. La loro differenza è di grande importanza, poiché nel primo caso, interventi tempestivi possono salvare la vita del paziente.
L'encefalografia aiuta a distinguere la catatonia dallo stato epilettico non convulsivo.
La catatonia si differenzia dalla sindrome da rigidità muscolare, dai gravi sintomi negativi delle patologie mentali, dall'ipertermia maligna, dal morbo di Parkinson, dalla demenza, dai disturbi catatonici organici e da altre sindromi iper e ipocinetiche.
Un esame completo del paziente aiuta a stabilire se la catatonia è funzionale o organica e a stabilire in quale reparto ricoverare il paziente per ricevere assistenza: psichiatrico o somatico generale.
Chi contattare?
Trattamento catatonia
I pazienti affetti da sindrome catatonica necessitano quasi sempre del ricovero ospedaliero, nei casi più complessi anche della terapia intensiva, poiché necessitano di cure costanti da parte del personale infermieristico e del monitoraggio del funzionamento degli organi vitali.
Nel trattamento della catatonia, la preferenza è data ai farmaci della serie benzodiazepinica, la cui azione è mirata a stimolare il neurotrasmettitore inibitorio acido γ-amminobutirrico, la cui ridotta attività è considerata una delle cause di questa condizione. Queste sostanze hanno un effetto calmante e ipnotico, riducono l'agitazione mentale e hanno un effetto rilassante sul tessuto muscolare. Hanno un moderato effetto anticonvulsivante.
Esiste esperienza nel trattamento di pazienti con catatonia con la formulazione orale del farmaco Lorazepam a media durata d'azione e con iniezioni intramuscolari di Diazepam (azione prolungata), con un rapido effetto terapeutico (entro due giorni) nella maggior parte dei pazienti. Due di loro hanno raggiunto la remissione dopo una singola dose. Tuttavia, metà dei pazienti ha richiesto l'elettroshock per un'ulteriore normalizzazione della condizione.
Altri ricercatori segnalano un effetto ancora più impressionante del Lorazepam: l'80% del gruppo di studio ha riscontrato la completa scomparsa dei segni di catatonia nel giro di sole due ore dall'assunzione del farmaco.
Le benzodiazepine a basse dosi sono efficaci in caso di stupore catatonico e agitazione. Anche la catatonia organica risponde bene alla terapia con questi farmaci.
I pazienti resistenti alla terapia con benzodiazepine vengono solitamente sottoposti a terapia elettroconvulsiva. Questo metodo viene utilizzato per trattare pazienti con malattie mentali, inclusi gli schizofrenici. È efficace nella depressione, organica e isterica, nonché nella catatonia idiopatica. Il numero di sedute di elettroshock necessarie per un determinato paziente non dipende dalle cause della sindrome catatonica. Questo metodo radicale contribuisce ad aumentare i livelli di dopamina.
Il trattamento della catatonia con dopamina, in particolare nelle sue forme maligne, è praticato anche in psichiatria. Oltre alla terapia elettroconvulsivante, utilizzata in questo caso come trattamento d'urgenza, i regimi terapeutici includono benzodiazepine, bromocriptina (uno stimolatore del recettore della dopamina) e dantrolene (un miorilassante).
Anche il farmaco dopaminergico antiparkinsoniano amantadina si è dimostrato efficace nel trattamento della catatonia.
I neurolettici non vengono utilizzati per trattare la catatonia, nemmeno negli schizofrenici, la cui patologia di base viene trattata con questi farmaci.
Tuttavia, nei casi di resistenza all'azione delle benzodiazepine (catatonia resistente), il paziente può sperimentare una remissione rapida e duratura dopo il trattamento con il neurolettico atipico Risperidone.
Lo stupore catatonico, resistente al trattamento tradizionale con benzodiazepine, ha risposto alla terapia di combinazione con farmaci al litio in combinazione con un neurolettico.
Il farmaco anticonvulsivante per gli epilettici Finlepsin (Carbamazepina) si è dimostrato efficace come trattamento di emergenza e nella terapia di mantenimento della sindrome catatonica.
L'analogo delle benzodiazepine Zolpidem ha avuto un effetto rapido e benefico su un paziente con catatonia resistente ai trattamenti tradizionali (benzodiazepine e terapia elettroconvulsiva). Questo farmaco stimola selettivamente i recettori delle benzodiazepine della sottoclasse omega-1.
Non ha un effetto rilassante sui muscoli e non ferma i crampi, tuttavia si è dimostrato un buon sonnifero, riducendo il periodo di addormentamento e la fase latente del sonno, prolungando la durata totale e la qualità del sonno. Inoltre, il farmaco non causa sonnolenza diurna né dipendenza.
I trattamenti moderni descritti sono stati oggetto di ricerca e hanno un valore basato sull'evidenza.
Prevenzione
La catatonia può derivare da diverse cause ed è impossibile prevenirle tutte, tuttavia è possibile ridurne il rischio. È necessario adottare un atteggiamento responsabile nei confronti della propria salute e insegnare ai propri figli a fare lo stesso, a non usare sostanze psicoattive, a curare tempestivamente le malattie mentali e neurologiche, ad aumentare la resistenza allo stress e a rafforzare il sistema immunitario. Queste misure includono una corretta alimentazione, l'attività fisica e una visione positiva del mondo.
Se in famiglia è presente una persona malata appartenente a un gruppo a rischio, è necessario proteggerla da stress e situazioni traumatiche; ai primi segni di catatonia, è necessario consultare un medico. La medicina moderna dispone di un valido arsenale di rimedi per far uscire una persona da questo stato.
Previsione
I ricercatori che studiano questo fenomeno (per lo più psichiatri occidentali) riportano esiti terapeutici favorevoli per i pazienti con sindrome catatonica, insorta per vari motivi. Apparentemente, nella maggior parte dei casi la prognosi dipende dalla tempestività del trattamento, dalla correttezza e dalla qualità dello stesso. La maggior parte dei pazienti ha risposto rapidamente al trattamento e ha superato questo stato.
Molti ricercatori riferiscono che i pazienti con disturbi affettivi (mania, depressione) presentano un'alta frequenza di episodi catatonici successivi. La catatonia periodica aggrava il decorso dei disturbi affettivi, riduce le funzioni cognitive dei pazienti e la loro capacità di risolvere i problemi della vita quotidiana.
Negli schizofrenici anche i sintomi catatonici rappresentano un fattore sfavorevole.
Lo sviluppo della sindrome catatonica negli adolescenti e negli anziani ha conseguenze più sfavorevoli rispetto alla popolazione giovane e attiva.
Nel complesso, vi è un'alta probabilità che il paziente esca dalla fase catatonica acuta; tuttavia, le conseguenze a lungo termine e la frequenza delle ricadute sono determinate dalla diagnosi primaria del paziente.

